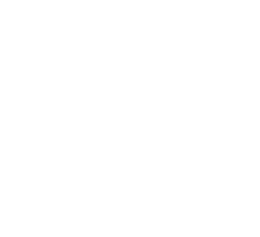Articoli
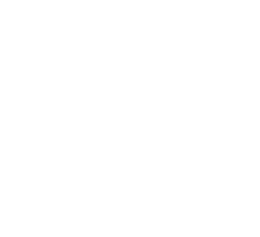



#Hey,Doc!
Bentornati in Hey, Doc!, cari appassionati lettori cinefili e amanti del Documentario e, in particolare, ben ritrovati a voi che in questi giorni state provando a recuperare qualunque film disponibile candidato agli imminenti Premi Oscar 2021: lungometraggi e cortometraggi, fiction e documentari, film con svariate tecniche di animazione e opere provenienti da diversi paesi in giro per il mondo.
Ognuno si prepara come meglio può per la tanto attesa Notte degli Oscar e questa rubrica si impegna costantemente per placare la vostra fame bulimica di documentari.
Se nella scorsa puntata ci eravamo dati agli antipasti presentandovi i cinque corti documentari candidati all'Oscar 2021, oggi passiamo alle portate principali: i cinque lungometraggi documentari.
[Non hai un film per vincere un Oscar? Niente paura! Fabbricati la tua mega statuetta! (Copyright Getty Images)]
Sia chiaro, l'antipasto non era mediocre, tutt'altro: era una sciccheria a base di caviale e champagne!
Il problema è che è finito troppo presto e ha solo contribuito a stimolare il nostro appetito, quindi ora proseguiamo con intere teglie di primi e secondi piatti!
Quest'anno, i documentari in nomination ci raccontano storie coraggiose di vero giornalismo, parlano di lotte contro la discriminazione razziale e nei confronti delle persone disabili, portano noi spettatori in fondo al mare a esplorare la natura, impararando da essa e - con saggezza - ci invitano a riflettere sui nostri comportamenti.
Una cinquina ricca, con opere molto diverse tra loro, tutte impegnate in un'ardua sfida che l'anno scorso vide vincitore Made in USA - Una fabbrica in Ohio (titolo originale American Factory).
Quali produzioni sono state presentate in gara agli Oscar come Miglior documentario 2021?
Proviamo a farcene un'idea!
Collective
di Alexander Nanau, 2019
I documentari che svelano scomode verità - citando fonti attendibili e dimostrando la veridicità dei fatti senza scadere nell'inutile e già sovrabbondante complottismo - partono già con una marcia in più, indipendentemente dal risultato propriamente cinematografico del film.
Esistono opere come il recente The dissident, del regista Premio Oscar Bryan Fogel, gli sconvolgenti L'atto di uccidere e The look of silence di Joshua Oppenheimer, o il poetico La memoria dell'acqua di Patricio Guzmán.
Produzioni che rappresentano vere e proprie rarità del Documentario di denuncia riuscendo a distaccarsi in maniera incredibilmente naturale dalla cronaca, abbracciando al contempo ambiti lontanissimi da quello di partenza e raggiungendo risultati di altissimo livello.
Ci sono poi documentari che, pur restando piuttosto ordinari nella struttura, con una fotografia e un montaggio non particolarmente impressionanti e una colonna sonora non eccezionale o quasi inesistente, non possiamo fare a meno di apprezzare per il loro contributo all'informazione, quella vera, per il loro atto di ribellione allo pseudo-giornalismo che tralascia, nasconde - o peggio ancora - falsifica le notizie per tutelare gli interessi di uomini e istituzioni economicamente e politicamente potenti.
[Mirela Neag, redattrice dello Sport Gazette, e Cătălin Tolonta, capo redattore del quotidiano]
È in questa categoria di documentari che rientra a pieno diritto Collective, ultimo lavoro del regista rumeno Alexander Nananu che, partendo dall'incendio che avvenne nel 2015 durate un concerto al Colectiv, un locale di Bucarest, mette sotto i riflettori una storia di bugie e giochi di potere che ha dell'incredibile.
Tramite le indagini portate avanti da Cătălin Tolonta, all'epoca capo redattore del quotidiano sportivo Sport Gazette, e da alcuni redattori del giornale, Collective mostra come - indizio dopo indizio - siano state svelate le carte di chi giocava d'azzardo con la vita dei cittadini di un'intera nazione.
Le motivazioni?
Le solite: prestigio e denaro.
Cosa mostra Collective?
Il marcio che è arrivato a intaccare le istituzioni rumene fino al nocciolo, il sistema sanitario di un'intera nazione piegato dal ricatto, in ginocchio a causa dell'omertà di chi avrebbe avuto il compito di sorvegliare e condannare, ma che ha preferito o è stato costretto a essere parte del gioco.
L'impotenza dei cittadini e, di riflesso, quella dello spettatore conducono al pensariero di come - trovandosi in una realtà corrotta come quella mostrata dal regista - nessuna arma avesse possibilità di vittoria se non la penna del giornalista.
E, purtroppo, è proprio la realizzazione di questo pensiero che lascia profondamente sconfortati.
[Una delle vittime dell'incidente del Colectiv presente nel documentario]
Come già accennato, il documentario di Alexander Nananu non spicca per virtuosismi stilistici, ma la sua semplicità - in tal senso è emblematica anche l'assenza di colonna sonora - si adatta bene alla storia raccontata.
L'idea di fondo che traspare è quella di mettere in risalto i fatti nudi e crudi.
Niente pizzi e merletti.
Seguiamo passo passo le indagini di Cătălin Tolonta e del suo staff, scopriamo i fatti con i loro stessi tempi, quasi facessimo parte del team della Sport Gazette; esultiamo con loro nel momento in cui ci si avvicina alla verità ma, allo stesso tempo, speriamo che non venga trovato altro, che ulteriori indagini portino a un buco nell'acqua, tanto è l'orrore che si palesa davanti ai nostri occhi.
Nel vortice di menzogne - che culmina in un finale amaro senza alcuna speranza per il futuro - la chiave per uscire dall'incubo è racchiusa nella scena durante la quale una folla di cittadini, scoperta la verità grazie all'inchiesta del quotidiano sportivo di Tolonta, inneggia al capo redattore e al suo staff, celebra a squarcia gola la vera informazione e, furiosa nei confronti di un governo che li ha presi in giro, accusa tutti coloro che ne hanno coperto le malefatte.
Candidato al Premio Oscar per Miglior documentario, Collective è presente anche tra i cinque candidati al Premio Oscar per Miglior film internazionale 2021.
Crip Camp: disabilità rivoluzionarie
di James Lebrecht e Nicole Newnham, 2020
Dopo l'esordio con il documentario American Factory, vincitore del Premio Oscar al Miglior documentario 2020, la casa di produzione fondata da Barack e Michelle Obama, la Higher Ground Production, è tornata all'attacco con un nuovo lungometraggio che non ha tardato ad accaparrarsi una delle cinque nomination ai Premi Oscar 2021 nella stessa categoria del suo predecessore e, forse, anche con più merito.
Crip Camp: disabilità rivoluzionarie è la storia di una vera e propria rivoluzione che ha portato al riconoscimento dei diritti delle persone disabili, un movimento la cui scintilla è nata da un gruppo di persone ritrovatesi a passare insieme un'estate in una sorta di colonia estiva per disabili gestita da hippie, Camp Jened, e che anni dopo ha finito per coinvolgere tutti gli Stati Uniti, arrivando fino alle cariche politiche più alte.
In apertura al documentario troviamo James Lebrecht - uno dei due registi oltre a Nicole Newnham - tecnico del suono con alle spalle una lunga carriera nel sound editing che spazia dal Documentario (Unrest) ai fiction film (Fuoco cammina con me), arrivando fino all'animazione (Il gigante di ferro): un percorso lavorativo di tutto rispetto iniziato nel 1990, a dispetto di ciò che molti avrebbero potuto credere alla sua nascita.
[James Lebrecht davanti alla sua postazione di lavoro]
Lebrecht nacque infatti con la spina bifida e due arti inferiori non completamente sviluppati, dunque non ha mai potuto spostarsi sulle sue gambe.
Non per questo si è dato per vinto e il suo CV ne è la dimostrazione.
Ma la strada verso l'indipendenza e il successo non è stata semplice e, affiancato da altri che hanno vissuto esperienze simili alla sua, ce la racconta introducendoci a un'America degli anni '70 sulle note di For what it's worth dei Buffalo Springfield.
All'epoca, essere un disabile negli Stati Uniti significava a tutti gli effetti venire tagliato fuori da una società che non prendeva minimamente in considerazione le necessità di chi era fisicamente o mentalmente invalido.
Le motivazioni erano varie e differenti fra loro.
Prima di tutto c'era il disinteresse economico da parte del governo nel rendere accessibili i servizi pubblici a quella fetta di società che, numericamente, risultava essere una minoranza.
Quindi, nel momento in cui bisognava - letteralmente - tirare le somme, conveniva certamente di più spendere i soldi dei contribuenti per opere di cui avrebbe usufruito la maggioranza (più elettori per il buon vecchio zio Richard Nixon) rispetto a dotare i mezzi pubblici urbani di passerelle per sedie a rotelle.
In aggiunta non mancava il disagio - quasi la paura - da parte dei cittadini di avere intorno persone così strane, che avevano movenze scoordinate e goffe, difetti di pronuncia e che si comportavano in maniera diversa.
Paura e ignoranza unite assieme, storicamente, non hanno mai dato frutti genuini.
[Ospiti del Camp Jened ripresi in filmati di repertorio presenti in Crip Camp: disabilità rivoluzionarie]
Ma le cose erano destinate a cambiare.
Nel 1971 Camp Jened ospitò infatti molti di quelli che negli anni a venire sarebbero diventati i più accaniti sostenitori dei diritti delle persone disabili.
Il centro estivo fu fucina di menti rivoluzionarie che avrebbero organizzato manifestazioni in tutti gli States, occupato locali pubblici, fondato organizzazioni per i diritti civili.
James Lebrecht, l'inarrestabile Judith Heumann che diventò il volto simbolo della rivoluzione, la dolcissima coppia formata da Denise e Neil Jacobson, entrambi poliomielitici che, contro ogni pregiudizio, dopo essersi conosciuti al campo estivo decisero di passare la vita insieme.
E tanti altri ancora, uomini e donne che lottarono coraggiosamente affinché i loro diritti di esseri umani venissero riconosciuti come tali: perché la disabilità non ha nulla in contrasto con l'umanità.
Il documentario mostra come la "chimica" che si venne a creare a Camp Jened tra ospiti e responsabili - quest'ultimi praticamente indistinguibili dai primi - fu effettivamente l'epifania che fece capire l'importanza della sensibilizzazione sociale nei confronti dei disabili.
Di quanto potesse essere preziosa l'integrazione dei portatori di handicap e la necessità essenziale di far vivere loro una vita al di fuori delle quattro domestiche con la sola compagnia dei genitori.
[Corteo di manifestanti per i diritti delle persone disabili]
Dal momento che il vero problema non erano i disabili bensì i cosiddetti "normodotati" che ignoravano costantemente chi non era come loro - o nei casi peggiori, mostravano atteggiamenti discriminatori (un discorso che, pensandoci, può essere declinato per qualunque minoranza) - la cosa da fare era tentare di ricreare in grande il felice microcosmo che era nato a Camp Jened.
Crip Camp: disabilità rivoluzionarie è il classico documentario in cui interviste ai protagonisti si alternano a filmati di repertorio, eppure non è un film ordinario nel tema e nel racconto.
Ci consente di scoprire le lotte che ha dovuto affrontare una porzione di società di cui troppo poco spesso si parla e che, erroneamente, si pensa non sia mai stata sotto i riflettori perché incapace nel far sentire la propria voce.
Ma disabile non è sinonimo di "non capace" e gli eroi di Camp Jened ne sono la prova.
Disponibile su Netflix e YouTube.
The mole agent
di Maite Alberdi, 2020
Pensate di essere troppo vecchi per cambiare lavoro e che a nessuno interessi assumere qualcuno della vostra età?
Beh, vi sbagliate: c'è chi è stato assunto alla veneranda età di 83 anni, non per monitorare i lavori stradali con le braccia dietro la schiena bensì come agente topo, ovvero come talpa.
L'agenzia investigativa di Rómulo Aitken riceve da una donna il compito di verificare che la madre, ospite di una casa di riposo a San Francisco, non sia vittima di furti e maltrattamenti all'interno della clinica.
Per non destare sospetti durante l'indagine, l'agenzia si trova costretta a dover assumere una talpa credibile, qualcuno che si confonda bene tra gli ospiti della casa per anziani ma, allo stesso tempo, che non sia completamente a digiuno di strumenti tecnologici come il cellulare.
È così che il pensionato Sergio Chamy, protagonista dell'ultimo documentario di Maite Alberdi, si ritrova a lavorare per tre mesi come spia sotto copertura fingendosi ospite del centro, alla ricerca di informazioni su una certa Sonia Perez.
[Sergio Chamy, protagonista di The mole agent, alle prese con uno smartphone]
Tra sorrisi teneri e risate, momenti di gioia e serenità, ci sono anche tanta amarezza, sofferenza, solitudine, rimpianti espressi più o meno palesemente dagli ospiti della casa di riposo ma che noi, insieme con Sergio, intuiamo.
Tramite tutti i dispositivi da investigatore segreto di cui è equipaggiato il nostro pluriottantenne "novello Ispettore Gadget" - tra cui una penna e un paio di occhiali con microcamere incorporate - sbirciamo in giro per i corridoi della casa di riposo, entriamo nelle camere degli ospiti, cerchiamo di capire cosa c'è che non va in quel posto, vogliamo il colpevole di quel dolore che, lì dentro, è un po' parte delle vite di tutti.
Desiderare un responsabile esterno, colui che ci permetta di smacchiare le coscienze e lavare i peccati; un capro espiatorio su cui riversare la nostra frustrazione e scaricare la nostra rabbia.
Lo facciamo sempre, con arroganza e presunzione, senza pensare di analizzare prima il nostro comportamento e le nostre mancanze nei confronti del prossimo.
Non capendo che tali disattenzioni possono essere la causa del malessere delle persone che abbiamo intorno.
Siamo nel XXI secolo, ma mandiamo ancora al rogo la prima persona che ci capita sotto mano per poi ripartire - con aria soddisfatta - sulla nostra scopa di saggina.
[Una tra le più toccanti scene di The mole agent]
Tra un'amicizia e l'altra stretta con le vecchine della casa di riposo, tra una carezza e una parola dolce, Sergio l'investigatore ci offre un saggio insegnamento, quasi fosse un nonno che distrubuisce consigli ai nipoti.
La bella palette di colori - che risalta nelle scene all'aperto - alleggerisce la pesantezza emotiva di alcuni momenti, la fotografia curata e la scelta di tracce musicali che compongono la OST sono elementi che contribuiscono a rendere The mole agent un documentario originale e assolutamente degno di una nomination da parte dell'Academy.
Disponibile su Amazon Prime USA
Il mio amico in fondo al mare
di Pippa Ehrlich e James Reed, 2020
Quante volte vi siete ritrovati a difendere il valore del Documentario, ribadendo come questo riesca a spaziare, andando a soddisfare le curiosità più recondite di ogni cinefilo che si rispetti e sottolineando come questo genere cinematografico non si risolva semplicemente nell'esplorazione didattica del regno animale?
Che poi, a ben vedere, fossero tutti documentari come quelli di National Geographic ci sarebbe solo da guadagnare!
Ma in risposta alle critiche dell’amico poco curioso per cui “i documentari sono lenti e noiosi” (lo so: tutti noi heydocchiani ne abbiamo almeno uno da riportare sulla retta via) potremo finalmente far crollare tutti i suoi preconcetti con un titolo: Il mio amico in fondo al mare.
Documentario scritto e diretto da Pippa Ehrlich e James Reed, Il mio amico in fondo al mare è la delicata storia del legame di amicizia e fiducia che Craig Foster - regista di mestiere ma qui protagonista e voce narrante - è riuscito a instaurare con un timidissimo abitante del mare.
Un animaletto un po’ diverso dal tipico cane o gatto da appartamento: un polpo.
Dopo un periodo di intenso stress durante il quale sentiva di non avere più né la forza né la voglia necessarie a andare avanti con il suo lavoro di cineasta e con le responsabilità da genitore, Craig decide di fare qualcosa per rimettere in carreggiata la sua vita privata e lavorativa.
Sceglie di tornare alle proprie origini, di fare un salto nelle passate esperienze della sua infanzia - che hanno profondamente contribuito a renderlo l’uomo che è oggi - ma dalle quali, nel suo percorso di vita, è stato costretto a allontanarsi.
Il mare, la forza dell’oceano e il suo fascino, i misteri che in esso si celano: Foster sente che quello è tutto ciò di cui ha bisogno e, solo entrando in sintonia con il mondo naturale, abbandonandosi con corpo e anima, gettandosi nel suo amato oceano come quando era bambino, solo così riuscirà a tornare a galla, risalendo l’abisso in cui sente di essere sprofondato.
Non poteva minimamente immaginare quanto (o perché) avesse ragione.
Iniziano così le sue immersioni nell’Oceano Atlantico sudafricano, nuotando tra le foreste di kelp, in un mare non esattamente accogliente: squali, meduse e una temperatura che può arrivare anche a 8 °C.
[Craig Foster durante una delle sue immersioni nell'Oceano Atlantico, tra le foreste di kelp]
Per entrare davvero in contatto con il mondo che lo circonda, l’unico modo che ritiene effiace per procedere è avventurarsi in quell’ambiente senza muta, bombole di ossigeno, vestendo solo la sua pelle.
È follia, sì, ma è anche un sistema per abbracciare la filosofia di vita di Henry David Thoreau espressa in Walden o vita nei boschi:
“Non ci può essere nessuna oscura malinconia per chi vive in mezzo alla Natura e ai suoi sensi sereni.
[…] Amo ciò che è selvaggio non meno di ciò che è buono.
[…] Mi piace, talvolta, affrontare la vita con esuberanza, e trascorrere i miei giorni come gli animali.”
Nuota un giorno, nuota l’altro... arriva il giorno in cui Foster si imbatte in un diffidente polpo che scappa via poco dopo il loro incontro.
Un essere tentacolato che - scoprirete il perché - sul momento Craig non riconosce nemmeno come membro del regno animale, ma che scatena immediatamente la sua curiosità.
Da lì l'idea assurda: che accadrebbe se mi immergessi ogni giorno, andando a trovare con regolarità quel polpo?
È questo l’inizio di una meravigliosa avventura in fondo al mare, fatta di piccoli gesti e commoventi contatti, ricca di stupore e paura.
Un vortice di emozioni, nuotando insieme a Foster e al suo amico che si rivelerà un saggio maestro di vita (come suggerisce il titolo originale del documentario: My octopus teacher) dotato di otto tentacoli.
Una storia meravigliosa e incredibile, la quale si impreziosice con riprese subacquee che riempiono gli occhi di gioia ed entusiasmo: coloratissime anemoni, banchi di pesci lucenti e maestose foreste di kelp che donano al tutto un’atmosfera quasi onirica, lasciando filtrare o no la luce secondo il loro volere, sono il fondale perfetto per il documentario.
[Craig Foster e il suo amico polpo, protagonisti de Il mio amico in fondo al mare]
Ne Il mio amico in fondo al mare, le colonne sonore di Kevin Smuts ci accompagnano con gentilezza, rimandando forse in alcuni momenti alle note sonorità che Hans Zimmer ha usato per il suo Interstellar, ma la cosa non disturba: del resto, lì nelle profondità del mare, sembra di essere su un altro pianeta.
Altra nota di merito è rappresentata dal comparto sonoro che, vista l'alta qualità di molte sequenze, amplifica le emozioni del momento, diminuendo la distanza tra lo spettatore e i protagonisti della storia: peter sentire il rumore delle ventose che si staccano dalle dita di Foster è da brividi.
Il mio amico in fondo al mare è un’esemplare storia di sopravvivenza e uno sprono a rialzarsi quando sembra non esserci più speranza.
È un dolce racconto di fiducia tramite cui risalta l’importanza della sensibilità umana nei confronti tanto degli animali quanto di qualunque altro essere vivente.
Time
di Garrett Bradley, 2020
Sibil Fox Richardson è un'imprenditrice e mamma di sei figli che da anni lotta quotidianamente in favore della scarcerazione di suo marito Robert G. Richardson il quale, nel 1997, organizzò una rapina in banca insieme alla moglie stessa e al nipote.
Tutti vennero arrestati ma Rob, non avendo accettato il patteggiamento, ricevette la pena più pesante: una condanna a scontare 60 anni di prigione nel Louisiana State Penitentiary.
Fox, invece, dopo aver patteggiato, tornò a essere una libera cittadina dopo tre anni e mezzo di detenzione e, da allora, lotta per riavere a casa suo marito.
La trama non è complessa e di semplice comprensione, così come l'obiettivo della regista Garrett Bradley: criticare il sistema carcerario americano con le sue pene troppo aspre, le "manette facili" della Louisiana e, soprattutto, l'accanimento nei confronti della comunità afroamericana che, insieme ai latinos e ai nativi americani, negli Stati Uniti sono in numero cinque volte maggiore rispetto ai bianchi incarcerati.
Nobilissime cause da prendere a cuore, quelle dell'uguaglianza e della lotta contro la discriminazione, attuali quanto non mai se pensiamo ai tristi omicidi di George Floyd, Trayvon Martin, Breonna Taylor.
In Time, però, lo spettatore fatica a scrollarsi di dosso quella fastidiosa sensazione che, validi obiettivi a parte, tutto sembra essere un po' troppo artefatto, costruito ad arte in maniera - potrebbero dire i più maligni - piuttosto furba.
[Sibil Fox Richardson, protagonista di Time]
Il voler gridare come fa la protagonista che, a differenza di quanto c'è scritto nelle aule di tribunale, la legge non è uguale per tutti, è cosa buona e giusta.
Urlare ancora più forte che c'è un evidente accanimento contro gli afroamericani, anche.
Trasformare ciò che doveva essere un cortometraggio in lungometraggio, facendo entrare nel montato finale un notevole numero di video che Fox girava ogni giorno con il suo cellulare con l'obiettivo di mostrare al marito la famiglia lontano dalla quale era costretto, è un escamotage non utile allo comprensione del film.
In aggiunta, un uso più moderato di queste clip all'interno del documentario avrebbe senz'altro contribuito a snellirne il ritmo, a rendere più evidente lo scorrere del tempo tramite gli stessi video che, distribuiti diversamente, sarebbero potuti essere punti di riferimento in un orologio che nella linea temporale della storia non ha smesso di correre.
Per chiarire occorre una breve ma - spero - utile divagazione.
Un recente e molto più efficace esempio di critica alle vere e proprie persecuzioni che gli afroamericani sono costretti a subire da parte delle forze dell'ordine è rappresentato dal cortometraggio Due estranei (disponibile su Netflix), diretto da Travon Free e Martin Desmond Roe, che troviamo tra i candidati al Premio Oscar per il Miglior Cortometraggio.
[Sibil Fox Richardson con cinque dei suoi sei figli]
Non è un documentario, ha uno stile completamente diverso da Time, ma il punto è che il corto non si perde in chiacchiere o in ripetizioni - nonostante siano, paradossalente, le sue unità narrative fondamentali - scorre fluido e senza attrito, ma lancia sassate improvvise che destabilizzano chi guarda.
Trentadue minuti per una chiarissima critica contro il razzismo che dilaga tra le fila dei poliziotti americani e un invito a non rimanere in silenzio.
Guardando Time e Due estranei vi farete voi stessi una vostra opinione.
L'altro punto non convincente di Time è la scelta del bianco e nero adottata dalla regista.
Non è chiara la motivazione per cui sia stato utilizzato, non è una necessità narrativa e finisce per sembrare una forzatura utile a dare una "pennellata di poesia" alla storia.
Fino alla fine la speranza era che, arrivando le vicende fino ai giorni nostri, la pellicola si colorasse in accordo con lo scorrere del tempo, mostrando così - anche cromaticamente - il contrasto tra un passato sospeso in un limbo di incertezze e un presente più roseo e colmo di speranza.
Ma, purtroppo, il desiderio che ciò avvenisse è rimasto tale.
Nonostante tutti questi elementi che fanno storcere un po' il naso, considerando l'importanza politica dei premi conferiti dall'Academy, Time non è certamente da considerare spacciato nella sua corsa al Premio Oscar.
Disponibile su Amazon Prime Video.
Siamo giunti alla fine di questo viaggio: che ne pensate dei candidati all'Academy Award di quest'anno?
Li avete già visti tutti o dovete recuperarne alcuni?
E che ne pensate rispetto alla cinquina dell'anno scorso?
Noi ci rivedremo l'anno prossimo con gli appuntamenti pre Notte degli Oscar e molto prima per parlare di altri appassionanti documentari, sempre su Hey, Doc!
Intanto vi ricordiamo del nostro ConcorsOscar 2021 e...
Stay Doc!
Ci hai mai visti pubblicare news sulla fioritura dei ciliegi in Giappone o sulle sedute di agopuntura urologica a cui si sottopongono le star di Hollywood?
No, e non lo faremo mai perché tutto ciò non ha alcuna attinenza con il Cinema.

Articoli
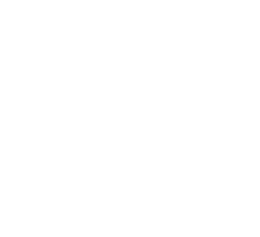


Articoli
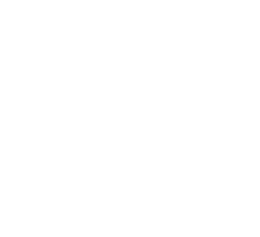


SuldivanodiAle