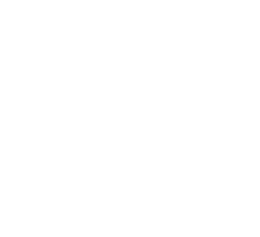Ognimesealcinema
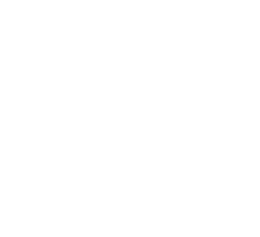



#Cinerama
Seguendo il corso della medesima equazione metastorica, osserviamo il parto e la sostanza di tre perle della satira politica, generate in (e da) tre contesti storici delicatissimi, gravidi di tensioni e fervori ideologici.
Nell'Italia a cavallo tra anni '60 e '70, nell'URSS prossima alla dissoluzione e nella Germania Ovest vicina alla riunificazione, vengono al mondo tre pellicole davvero radicali, soprattutto dal punto di vista contenutistico, pienamente inserite negli accesi dibattiti dei loro tempi.
Evitando preamboli superflui, gettiamoci subito nell'analisi concreta di questo strambo terzetto.
Il primo film in questione è Il potere, di Augusto Tretti.
Si tratta di un'opera decisamente sui generis e dalla travagliata storia produttiva (e distributiva), bizzarra quanto il suo autore.
Facciamo però un passo indietro.
Dopo aver operato come aiuto-regista ne Il bidone di Federico Fellini, Tretti firma il suo primo lungometraggio nel 1960, dopo tre anni di lavoro.
È La legge della tromba: realizzato con fondi esigui e dotato di una patina quasi amatoriale, il film mostra già una forte carica eversiva e satirica, anche sul piano stilistico (specie dal punto di vista sonoro).
Come farà anche successivamente, il regista opta per interpreti non professionisti, talvolta coinvolgendo alcuni familiari, ma sfrutta tale scelta in maniera dirompente.
Se in tal modo il Neorealismo ricercava una sorta di naturalezza libera da sovrastrutture, spesso in linea con una certa ideologia, Tretti, invece, guarda a Bertolt Brecht.
Per il cineasta veronese, "i personaggi devono sembrare marionette che raccontano un discorso che deve servire a pensare".
Egli, quindi, decide volutamente di contrastare la fruizione passiva, favorendone una attiva, critica e orientata in senso politico.
[Un frame da Il potere] satira satira satira satira satira
Inizialmente il film incontra parecchie difficoltà nella distribuzione, e anche gran parte della critica lo stronca, tacciandolo di dilettantismo.
Ugo Casiraghi è tra i pochi a riconoscerne il valore, e, insistendo sul suo carattere "comico-grottesco", cita come riferimenti i fratelli Marx, Charles Chaplin e il primo Jacques Tati.
Dopo qualche tempo, però, Tretti riesce a mostrare l'opera ad Alberto Moravia, che a sua volta contatta gentucola come Michelangelo Antonioni, Cesare Zavattini, Ennio Flaiano e Fellini.
Questi accolgono benevolmente il film, ma è il letterato Franco Fortini a condensare, in poche parole, il senso intero della produzione del regista, compresa quella futura:
"…non capita spesso di poter sentire suonare il Dies Irae con l'accento stralunato d'una trombetta di latta".
Sull'onda di questi pareri positivi, Goffredo Lombardo, a capo della Titanus, importante casa di produzione e distribuzione, decide di puntare su Tretti, distribuendo (nel 1962) La legge della tromba e finanziando il suo progetto successivo.
Intorno al 1964, dopo alcuni fallimenti commerciali, la Titanus chiude però i battenti del proprio compartimento produttivo, imponendo il fermo della lavorazione de Il potere, ormai arrivata a metà.
Solo nel 1971, dopo "una battaglia continua per trovare il produttore" ("il quale poi non sapeva trovare la distribuzione"), il film viene ultimato e distribuito.
[Un logo che probabilmente avrete visto diverse volte]
Se possibile, in questa opera Tretti inasprisce il suo sperimentalismo formale e contenutistico.
Come nel caso della prima pellicola, il film a una prima occhiata risulta davvero amatoriale, facendo quasi sorridere.
In effetti le ristrettezze economiche si fanno sentire, ma sono filtrate da un'elevata padronanza del linguaggio filmico, che riesce a superare, concettualmente, queste mancanze concrete.
Ritorna quella "recitazione burattinesca" intesa in senso anti-verista, sommata a un doppiaggio linguisticamente dissonante rispetto ai contesti, e si inseriscono poi altri elementi colti.
Rimanendo nella scia di Brecht, ma con un "estro vernacolo" (come notava Flaiano), Tretti sfrutta anche la frammentazione narrativa.
Il film, infatti, è diviso in segmenti: in ordine, "età della pietra", "età romana", "epopea del Far West", "Italia 1919" ed "epoca moderna".
In tal modo si interrompe ripetutamente la visione in modo palese, segnalando tutto a schermo (quasi richiamando il siparietto brechtiano), costringendo lo spettatore a riflettere.
In certi frangenti si inseriscono, agendo in senso straniante, anche delle immagini di personaggi o eventi storici recenti, istituendo precise analogie tra passato e presente, con connotazioni politiche (e non solo) molto evidenti.
I cinque segmenti sono poi a loro volta intervallati da scenette, molto teatrali, in cui compaiono tre animali seduti su altrettanti troni: un leone rappresenta il "potere militare", una tigre quello "commerciale", un leopardo quello "agrario" (e/o specificamente politico).
Questo trio, concretizzato dai costumi di Nino Gottardi, rimane eternamente immobile nonostante il passare dei secoli e dei millenni, discorrendo tranquillamente su come perpetuare il proprio dominio.
[Bertolt Brecht] satira satira satira satira satira satira
Così facendo, più che interessarsi a un preciso momento storico (anche se è sempre chiaro il riferimento al presente), il regista-sceneggiatore compie un preciso discorso metastorico e antistorico.
Soprattutto antistorico, nel solco di una tradizione letteraria già comparsa prepotentemente in Italia sul finire dell'Ottocento, se non prima.
Nel perseguire tali fini, Tretti sembrerebbe cadere nel didascalismo, ma a salvarlo da tale accusa è, ironicamente, proprio il suo presunto dilettantismo.
Partendo da quella che Moravia chiama una "visione del mondo […] rustica", egli impiega una "tecnica volutamente rozza, volta a non attenuare nelle suggestioni della forma l'aggressività del discorso", come scrivono Sandro Zambetti e Vittorio Giacci.
Ha dunque "ben poco di goliardico o di cineamatoriale", allontanandosi, rispettivamente, sia da una "superficialità caricaturale" sia da una "tendenza al perfezionismo tecnico" che, rischiando concretamente di fallire, avrebbe probabilmente generato del kitsch (e non del camp).
Il senso di questa operazione, non di facile decifrazione, è acutamente intuito da Ennio Flaiano, già nel 1971:
"Il dono di Tretti è una semplicità che non si copia, presuppone la superba innocenza dell'eremita.
È una semplicità che riporta l'immagine fotografica alle composizioni di Nadar, di Daguerre […].
…niente in lui è ingenuo o copiato, ma viene da una cultura ben digerita, strizzata alla radice […].
La ricerca della bellezza […] che rovina tanti nuovi autori e li spinge […] nel kitsch […] è in Tretti una ricerca della cosa essenziale, adrammatica […].
…fa un Cinema didascalico da sillabario", che Ugo Brusaporco chiama anche "griffithiano".
In questo modo le stilizzazioni radicali che sono applicate (per esempio nel caso del Duce, con la sua maschera che svela esplicitamente la finzione scenica) e che sono sempre permeate da una dissacrante ironia, cooperano nel creare quella vitalità folle ed esuberante che, almeno in parte, caratterizza la trattazione di temi altrimenti pesantissimi.
[Ennio Flaiano] satira satira satira satira satira satira
In questo senso sono particolarmente calzanti i paralleli istituiti, guardando al mondo teatrale, da Giannalberto Bendazzi e Flaiano.
Bendazzi parla della "prima […] commedia dell'arte che possa ricordarsi nella Storia del Cinema italiano", mentre il letterato pescarese cita un nome poco noto, quello di Angelo Beolco, detto Ruzante.
Nonostante ne Il potere, in fin dei conti, non prevalga nessun personaggio, proprio in virtù del suo carattere metastorico, il paragone più azzeccato è il secondo.
Drammaturgo e attore veneto operante nel primo Cinquecento, Ruzante, servendosi di un forte espressionismo linguistico e di interpreti di supporto non professionisti, riuscì sapientemente a far convivere un impianto superficialmente comico con un sottotesto drammatico-satirico legato al presente.
Come non ha mancato di ricordare Dario Fo - straordinario interprete delle opere di Beolco - nel ricevere il premio Nobel per la letteratura, egli fu in grado di portare "in scena il quotidiano, […] l'ipocrisia e la spocchia dei potenti".
In maniera simile, ma senza dimenticare gli altri tratti sopradetti, Tretti ha sfruttato uno sguardo di questo tipo per costruire dei quadretti narrativamente autonomi ma idealmente relati, in chiave satirica.
Un'altra linea tematica rilevante, ma secondaria, riguarda poi un certo approccio metacinematografico, declinato anch'esso in maniera critica e simil-parodica.
Ciò emerge già da quello stile apparentemente amatoriale, come ha evidenziato lo stesso regista:
"...con Il potere ho voluto mettere in ridicolo le strutture formale del Cinema di consumo: i colori sfolgoranti, la bella fotografia, il lusso e lo sfarzo".
Nonostante questo opporsi al discorso formale dominante sottintenda una polemica politica (sia in senso concreto che in senso lato), è pur possibile scovare dei riferimenti molto diretti, in un gioco intertestuale che, per certi versi, anticipa alcuni dettami postmoderni.
Particolarmente colpiti sono i generi del peplum e del western, guardando tanto agli archetipi hollywoodiani quanto alle repliche italiane, spesso caserecce e ridicole.
Sempre sul versante stilistico, da rimarcare sono anche lo sperimentalismo nel comparto sonoro, usato sovente in modo dissonante, e un limitato ma efficace ricorso a una fotografia di tipo espressionista, in un'opera prevalentemente caratterizzata da un bianco e nero poco contrastato.
Se dopo tutto questo non vi fosse venuta voglia di recuperare Il potere, vi basti sapere che si tratta di un film in cui la retorica fascista è ben commentata da grugniti in sottofondo.
O che Federico Fellini ha definito Tretti come "il matto di cui ha bisogno il Cinema italiano".
[Dario Fo] satira satira satira satira satira satira satira
Arriviamo ora alla seconda pellicola del nostro terzetto.
Dopo un approccio metastorico (e antistorico) passiamo alla fantascienza, dopo un film estremamente di nicchia passiamo a quello che, almeno nell'Est Europa, è un cult.
Sto parlando di Kin-dza-dza!, distopia sovietica del 1986.
L'opera nasce in un contesto storico-politico non sereno, per usare un eufemismo.
Nella prima metà degli anni '80, infatti, si assiste al (metaforico) passaggio di consegne tra il rigido conservatorismo di Leonid Bréžnev e il riformismo di Michail Gorbačëv.
Alla "nomenklatura" del primo, un apparato burocratico gestito come una sorta di clan familiare, si sostituiscono parole d'ordine come "perestrojka" (ricostruzione dal punto di vista socioeconomico) e "glasnost'" (trasparenza nelle comunicazioni ufficiali).
Si innescano quindi grandi cambiamenti che, com'è noto, porteranno alla dissoluzione dell'URSS, tra 1990 e 1991.
Proprio in (e da) tali circostanze scaturisce un prodotto come Kin-dza-dza!, scritto da Georgij Danelija e Revaz Gabriadze e diretto solo dal primo.
I due, entrambi georgiani, avevano già avuto occasione di collaborare nel corso degli anni, realizzando opere ironico-parodistiche mai aspramente satiriche.
Stavolta, però, decidono di scagliarsi contro la decadente e corrotta società del tempo.
E, imbeccati da Tonino Guerra, lo fanno puntando sulla fantascienza, genere ben in grado di mascherare eventuali intenti altri.
Il regista ha più volte negato questo scopo direttamente satirico, ma, leggendo tra le righe e analizzando il film (e considerando la storia personale dei due sceneggiatori), è difficile ignorare certi riferimenti.
[Georgij Danelija] satira satira satira satira satira satira
In breve, l'opera racconta la storia di due sovietici che, casualmente, dopo aver incontrato un clochard, si ritrovano nel desertico pianeta Pluk (nella galassia Kin-dza-dza), dove legano il proprio destino a due abitanti umanoidi e cercano di tornare sulla Terra.
La pellicola, ambientata quasi interamente nel deserto turkmeno Karakum, colpisce per la sua stranezza e per la sua atmosfera sospesa.
La coppia protagonista si trova catapultata in una società nuova, tecnologicamente evoluta (almeno in un certo senso) ma socialmente involuta, ma ancor prima di scoprire ciò si scontra con la lingua locale, incomprensibile nella sua sconcertante semplicità di facciata.
Eccetto una decina di parole decodificate anche grazie all'aiuto dei (semi)autoctoni, che sanno leggere nel pensiero e che si appropriano dunque del russo, il resto del vocabolario è condensato in una sola parola, "ku".
E, a conti fatti, è forse l'aspetto linguistico il più interessante di tutti, più delle numerose trovate fantascientifiche o dello humor che si muove tra il deadpan e il surreale.
Il riversare in maniera così estrema la quasi totalità del lessico in una sola parola, peraltro composta da due grafemi, è un'operazione forte, certamente finalizzata.
Innanzitutto, è bene (ri)sottolineare la nazionalità dei due sceneggiatori, allora sovietici ma anche georgiani.
Il russo appartiene alla famiglia linguistica indoeuropea, e rientra nel macro-ceppo slavo: derivando dal protoslavo e dal paleoslavo, è quindi evidente una certa vicinanza (anche culturale) nei confronti di un buon numero di altre comunità di parlanti.
La sua stessa trascrizione grafica, che si poggia sull'alfabeto cirillico, conferma tale carattere.
Il georgiano, invece, appartiene al gruppo isolato delle lingue cartveliche, che, per ragioni soprattutto storiche e geografiche, ha interagito poco con altri ceppi.
E anche l'alfabeto georgiano risulta piuttosto lontano da quello cirillico.
[Il primo impatto con Pluk] satira satira satira satira
Pur parte dell'impero russo dai primi dell'Ottocento, la Georgia ha dunque mantenuto una tradizione culturale e idiomatica poco adattatasi agli standard dello Stato-leader.
In tal senso, un mirabile ritratto visivo ed etnografico è offerto dal regista Sergej Paradžanov, con La leggenda della fortezza di Suram.
Imponendo questa dittatura linguistica del "ku", Danelija e Gabriadze hanno pertanto voluto porre in evidenza un paio di questioni: il rischioso predominio della Russia, capace di minacciare le identità delle nazioni più piccole, e il classismo intrinsecamente presente in tale dinamica, soprattutto nell'epoca della nomenklatura.
Ma la ricerca linguistica dei due non si è limitata a questo.
Andando ancora più per il sottile, essi hanno provato a ribaltare completamente il rapporto di forza tra lingua/cultura russa e altre lingue/culture inserite nell'URSS.
Nelle poche parole della lingua di Pluk, si scorgono infatti diversi rimandi al georgiano o ad altre lingue parlate nell'Unione, come l'ucraino (che però appartiene sempre al ceppo slavo e impiega una variante dell'alfabeto cirillico).
In tal modo, per una volta, a occupare una posizione subalterna sono i parlanti russi.
Ciò è confermato anche dal fatto che uno dei due protagonisti, interpretato dal figlio di Revan Gabriadze, scambia talvolta qualche parola in georgiano con gli autoctoni, escludendo idealmente ancor di più il proprio compagno di avventure, che conosce solo il russo.
Considerati tali aspetti linguistici, focalizziamoci ora sul worldbuilding del grottesco pianeta.
Come detto, la società locale è sì tecnologicamente evoluta, ma lo è in modo ambiguo, in modo, appunto, distopico.
Ogni cittadino, grossomodo, possiede una navicella volante e altri congegni avanguardistici, ma questi sono caratterizzati da un'estetica quasi steampunk.
In questo vasto deserto non emergono edifici, se non qualche baracca o la modesta capitale, e tutto sembra fatto di ferro vecchio e arrugginito.
Oggetti e abiti sono, infatti, tanto bizzarri quanto poveri, e non è affatto difficile scorgere, in queste scelte di scenografia e costumi, una satira fantascientifica delle condizioni del proletariato sovietico.
[Scenografia e costumi in Kin-dza-dza!] satira satira
Gli sceneggiatori, non paghi, decidono però, ancora, di andare oltre, trattando direttamente temi come il razzismo e il classismo, dunque interrogandosi criticamente in merito alla relazione tra moralità e (presunto) progresso.
In una galassia in cui "non esiste un imbecille che avrebbe pensato la verità", sapendo di poter essere letto nel pensiero, vige una rigida separazione tra "ciatlani" e "pazachi".
La collocazione in una delle due classi si basa sul semplice riconoscimento da parte di un piccolo marchingegno, che emette una luce verde o arancione a seconda dei casi, fatto che sottolinea la totale assurdità e arbitrarietà di una simile norma sociale.
I pazachi, subalterni, sono poi costretti a portare dei campanellini per il naso e a compiere, nell'incontrare membri della classe opposta, un singolare e comico saluto.
Un'ulteriore distinzione è segnalata dal colore dei pantaloni, che esprime la posizione degli individui nella gerarchia socioeconomica.
I due protagonisti provano più volte a spiegare agli indigeni l'immoralità di tali situazioni, ma questi ribattono dicendo cose simili:
"Quando la società non ha la differenziazione di colore dei pantaloni, tale società non ha scopo".
Oltre a tali elementi, il film è ricco di parecchi altri riferimenti all'attualità sovietica: due veloci esempi possono essere l'adorazione acritica per il leader del pianeta e la consuetudine di corrompere le forze dell'ordine.
Prima di analizzare la prossima pellicola, vale infine la pena di sottolineare qualche ultimo aspetto, soprattutto dal punto di vista stilistico.
In prima battuta, come nel caso di Tretti, assistiamo all'utilizzo di una colonna sonora vagamente straniante, talvolta venata da un sapore malinconico che ben si sposa con alcune (deboli) derive melodrammatiche.
Altro pontenziale punto d'interesse è la presenza di una comicità che, oltre alla tendenza deadpan principale, sconfina nello slapstick, almeno in certi frangenti.
Ciò - ipotizzo - potrebbe derivare da alcune esperienze dello sceneggiatore Gabriadze, fondatore di uno dei più celebri teatri di figura al mondo, il Rezo Gabriadze Marionette Theater di Kutaisi, in Georgia.
[Uef, ciatlano, e Bi, pazaco] satira satira satira satira
Dopo una satira in chiave metastorica e una satira fantascientifica (manchevole di un finale provocatorio bloccato dalla censura), passiamo ora al terzo e ultimo componente del nostro terzetto, che si cala direttamente in un preciso momento storico, anzi precisissimo.
Sono le 17.00 del 30 aprile 1945, e siamo nel Führerbunker per assistere all'ultima ora di vita di Adolf Hitler e dei suoi più fedeli accoliti.
E chi poteva raccontare una storiella simile, in chiave satirica, se non Christoph Schlingensief, geniale drammaturgo e regista?
Se non conoscete il soggetto, vi basteranno cinque minuti di una qualsiasi sua opera per inquadrarlo, per inquadrare il suo estro e il suo radicale anticonformismo, sovente declinato in modo politico.
Dopo pellicole come Menu Total ed Egomania, il regista abbandona un simbolismo estremo per presentare vicende sempre più storicamente esplicite, realizzando, nel giro di quattro anni, la propria trilogia tedesca (che rimanda a Luchino Visconti, ben noto in Germania grazie alla collaborazione con Helmut Berger).
Primo capitolo è 100 Years of Adolf Hitler, derivato da un'omonima opera teatrale e realizzato nel 1989, un secolo dopo la nascita del dittatore e un anno prima della riunificazione tedesca, in un periodo, dunque, non esattamente pacifico.
Come ricorda la piattaforma MUBI, dove potere trovare questa e altre pellicole di Schlingensief, il film "fu girato in 16 ore in un autentico bunker della seconda guerra mondiale [situato nella regione della Ruhr, n.d.r.] con solo una torcia a fare luce sulla follia".
16 ore in cui, a cast e troupe, fu categoricamente vietato di allontanarsi dal set.
Ho scelto di presentare quest'opera e non altre, dal valore simile, per dei motivi piuttosto semplici.
In primo luogo, come segnala Simone Buttazzi, i film di Schlingensief "sono tedeschi fino al midollo" e "non concedono spiegazioni o sottotitoli per chi, le cose crucche, non le mastica poi tanto", fatto che ha decretato una sostanziale non-esportabilità.
In toto, quindi, 100 Years of Adolf Hitler risulta forse essere la pellicola che più di tutte riesce a condensare una forte carica polemica con una buona comprensibilità, almeno per il pubblico estero.
[Christoph Schlingensief] satira satira satira satira
Mettendo meno carne al fuoco rispetto ad altri lavori, emerge infatti un grottesco cristallino, presentato nella sua purezza dionisiaca (che si lega a Joseph Beuys, e di conseguenza a Friedrich Nietzsche) e impiantato su di un canovaccio limitato spazialmente, temporalmente e narrativamente.
Per certi versi, anche Schlingensief guarda a Brecht - figura che ha avuto un'influenza impareggiabile su generazioni di artisti teutonici - mirando a sollecitare una fruizione attiva.
La finzione è palesemente svelata dai ciak che si vedono a inizio inquadratura, da medesime scene addirittura rigirate e mostrate per due volte, dal frenetico uso della camera a mano e da una recitazione iper-enfatica e straniante.
O anche dall'onnipresente ombra della giraffa, dalla musica gioiosa totalmente fuori contesto e dall'illuminazione che, come detto, proviene solo da una torcia evidentemente manovrata da un operatore.
O, ancora, dal televisore che mostra canzonatoriamente Wim Wenders a Cannes nel 1984.
Un altro possibile riferimento teatrale è sottolineato da Matteo Boscarol, che descrive il film come un "delirio scatologico, sessuale e politico che ricorda gli eccessi teatrali e sonori di Antonin Artaud", col suo teatro della crudeltà.
La pellicola, difatti, risulta essere uno sconvolgente guazzabuglio di volgarità quasi tribale, di stranezze stilistiche e di comportamenti al limite del surreale.
Il tutto si sposa chiaramente con un'ironia salace, in grado di sfruttare ora la corporeità degli attori ora le convergenze/divergenze a livello di trama e dialoghi, sfiorando talvolta il nonsense avanguardista (e una qualche connessione col Dada, anche solo per ragioni geografiche, non è affatto da escludere).
In quest'ora scarsa, si percepisce un angosciante senso di fine imminente, ribadito qua e là dal rumore di bombardamenti e spari, che produce tremendi effetti su gerarchi nazisti e relative famiglie.
Più colpito di tutti è il Führer - interpretato da Udo Kier - che vaga tremolante e smarrito, passando da momenti di sconforto a lampi di mitomania.
[Udo Kier è Adolf Hitler] satira satira satira satira satira
Non rimane quasi nulla del venerato e temuto uomo che fu, e Laurence Kardish, curatore al MoMA, vede ciò come una risposta a Hans-Jürgen Syberberg, al suo Hitler, un film dalla Germania del 1977.
Per Kardish, Syberberg "tenta di comprendere l'ascesa del nazismo tramite citazioni da fonti primarie [coeve, n.d.r.] ed eleganti dispositivi visivi".
Schlingensief, invece, rende i gerarchi nazisti "meschini e ridicoli come dovevano essere, in realtà, quando hanno esercitato il potere".
Così si configura, pertanto, la costruzione satirica dell'opera, che, come visto, si riverbera anche sul lato formale.
Citando un passo della monografia Christoph Schlingensief: Art Withour Borders delle australiane Tara Forrest e Anna Teresa Scheer, il regista, realizzando questo "mockumentary trash e horror, […] suggerisce che che venire a patti col passato non è solo una questione di politica, ma anche di gusto".
E questo è un discorso che può benissimo essere esteso alla totalità della produzione cinematografica, e non solo, del cineasta tedesco, che sfocia spesso e volentieri nel camp, sia in senso politico sia in senso puramente storico-estetico, come nel caso di The 120 Days of Bottrop.
In quest'ultimo film, del 1997, egli omaggia Pier Paolo Pasolini e Rainer Werner Fassbinder, collaborando con Margit Carstensen, indimenticabile Petra von Kant divenuta, in diverse fasi della sua carriera, attrice feticcio di entrambi i registi tedeschi, e presente anche in 100 Years of Adolf Hitler.
Per concludere, tanto riaffermare il carattere profondamente politico della produzione di Schlingensief, se ce ne fosse bisogno, è doveroso far notare il curioso e caustico parallelo istituito tra i titoli di due sue opere.
100 Years of Adolf Hitler, per l'appunto, e 100 Years of CDU, pièce teatrale realizzata nel 1993 per celebrare ironicamente il principale partito della nazione, l'Unione Cristiano-Democratica di Germania, una sorta di Democrazia Cristiana tedesca.
Cinque anni dopo, il regista finirà addirittura in carcere, reo di istigazione all'omicidio nei confronti di Helmut Kohl, allora cancelliere federale e leader della CDU.
[Un frame da The 120 Days of Bottrop] satira satira satira
Ringrazio Mattia Gritti per la proposta della tematica, e ringrazio tutti, lettrici e lettori, per questo primo anno di Cinerama, che ha mantenuto una certa costanza grazie a voi.
E come sempre, vi ricordo del sondaggio che si svolge sul gruppo Facebook Cinefactsers! per la scelta dell'argomento da trattare in rubrica, ormai più a cadenza mensile che bisettimanale.
Cinerama Out.

Ognimesealcinema
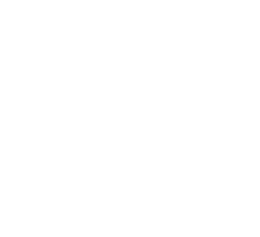


Ognimesealcinema
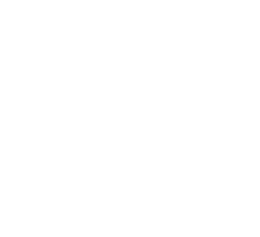


LineeD'Azione