
#Cinerama
Sul film etnografico: Intermezzo - Docudrama e docufiction - Cinerama 20
Di termini, di concetti, di fondamenti
Abbiamo concluso il primo articolo dedicato al film etnografico evocando il rapporto complesso che quest'ultimo intrattiene con la nozione di documentario: nozione - e/o prassi classificatoria - già non univoca, e da qui dunque riprendiamo, lanciandoci in un'analisi che problematizzerà termini/concetti come docudrama e docufiction.
Partiamo ribadendo una certa insensatezza propria alla tradizionale dicotomia - erronea già in termini logico-categoriali - che oppone (film di) finzione e documentario, segnalando al contempo come sia da salvaguardare un approccio fondato sul buonsenso, per quanto semplificatorio possa essere: ciò che non pare salvaguardabile, semmai - almeno per scrive - è l'usuale concezione dello statuto dell'immagine documentaria, che permea troppi pensieri sul tema a prescindere dalla sua esplicitezza e che riguarda, appunto, il rapporto tra realtà fenomenica e realtà filmica in genere.
In sostanza, nel parlar comune queste realtà sono talora intese come caratterizzate da un legame riproduttivo d'ispirazione platonica, conscia o meno che sia: si tratta dell'idea di copia - a prescindere dalle valutazioni di merito - menzionata ne La Repubblica, idea che ovviamente s'inserisce in un sistema filosofico di più ampia portata e, a sua volta, in un contesto socio-economico-storico-culturale-etc. non ignorabile.
Ora, la tentazione di adottare questa prospettiva parrebbe forte: il Cinema è un medium riproduttivo, e le riproduzioni che crea sono contraddistinte da un elevatissima - anche se non massima - fedeltà percettiva rispetto alla materia riprodotta (perlomeno non considerando la continuità spaziotemporale, alla luce del ruolo del montaggio), rispetto alla realtà empirica.
Ciò sembra ancor più vero, se possibile, se riferiamo queste considerazioni al caso del documentario, genere/tipo testuale fondato proprio su di una specifica relazione con la realtà fenomenica, sovente finalizzata a celare/minimizzare la presenza, ingombrante e inevitabile, di una mediazione.
Citando il critico Adriano Aprà, in tal caso dunque - richiamando il "sistema di attese" citato nella prima parte dell'analisi - "il patto implicito dello spettatore con lo schermo è: […] «ciò che vedo è vero, e non solo verosimile, e per questo ci credo»", il che, tra l'altro, connette il nostro discorso a tutta una serie di riflessioni riguardanti l'ideologia nel/del Cinema.
Quanto detto si fonda però sul presupposto, non-platonico e spesso implicito/inconscio, che la riproducibilità tecnica comporti anche una riproducibilità ontologica, cioè sul presupposto che la realtà presentata a schermo, oltre a poter essere percettibilmente similissima a quella fenomenica, possa appunto ri-manifestarne l'essenza, in un senso qui distante da Platone.
Posto che questa non è la sede per tentare di approfondire una questione di tale ordine, a sua volta relata ad interrogativi ancor più inestricabili, chi scrive ritiene il Cinema un mezzo ontologicamente generativo, in grado di creare ogni singola volta, pur nello spazio definito dai contorni concreti del riprodotto - il che qualifica il medium come percettivamente derivativo - e a prescindere dagli intenti autoriali, una realtà nuova.
Se poi questa realtà possa o meno intersecarsi, sempre sul piano ontologico, con quella empirica o se il mezzo possieda una generatività piena sono altri discorsi, così come esula dalla nostra prospettiva il cercare di definire la paternità e/o l'eventuale variabilità di una data realtà cinematografica.


[Vista la natura dell'articolo, che si presta solo saltuariamente ad associazioni iconografiche, presenterò 4 immagini per ciascuno dei due film che saranno menzionati: Nanuk l'eschimese e L'ultimo Eden, entrambi di Robert J. Flaherty. Partiamo con un frame dal primo]
L'interpretazione che ho appena proposto è, per l'appunto, un'interpretazione, parziale - anche solo sul versante quantitativo - e passibile di critiche, e la sua accettazione non è certo propedeutica alla fruizione della nostra disamina, che tuttavia poggia su certi assunti.
Quello forse centrale verte sul fatto che ogni documentario implica necessariamente una messinscena e una mediazione, la quale si risolve in una vaghissima alterazione dell'esistente e nell'adozione di un punto di vista (non solo ottico).
Del resto, nel Cinema l'effettiva conquista di una prospettiva non-teatrale, nei primi anni del Novecento, corrisponde al passaggio chiave ben sottolineato dallo scrittore André Malraux, per cui (via Christian Metz) "è stato necessario che l'apparecchio imparasse a cambiare posizione [tramite il montaggio e/o la mobilità della cinepresa, n.d.r.] perché […] il cinema, da semplice mezzo di riproduzione [tecnica, n.d.r.] diventasse mezzo d'espressione", pensiero che possiamo accettare in maniera sfumata alla luce della nostra macro-impostazione ontologica.
Il concetto di espressione rimanda inoltre, anche per vie traverse, alla nozione di connotazione (obliquamente connessa a quella di interpretazione), sempre propria di un mezzo cinematografico che non è possibile intendere in senso solo denotativo, nemmeno nel caso limite dei proto-documentaristi Lumière.
Possiamo allora riferirci, ancor più obliquamente (o indebitamente), ad una frase del teorico francese Jean Mitry, che riflettendo sul montaggio - comparto non a caso chiamato in causa già due volte - scrive:
"Non si capirà mai nulla del Cinema [anche documentario, almeno per chi scrive, n.d.r.] finché si considererà il dato rappresentato come la finalità della sua intenzione".
Ciò, per concludere questa mini-carrellata di citazioni e prima di entrare nel vivo del discorso, anche perché il senso di un film, piegando ai nostri fini le parole del filosofo Max Black (che nell'intervento citato parla di pittura e, in misura minore, di fotografia), "è «non-naturale» e non riducibile ai termini dell'inferenza fattuale operata in base al veicolo" artistico.


[Un frame da Nanuk l'eschimese] docufiction docufiction
Cominciamo ora ad osservare le interazioni tra il concetto di film etnografico - che abbiamo provato a definire -, le realizzazioni concrete ad esso generalmente ricondotte e poli di genere/tipo testuale come film di finzione e documentario, slegati dunque da quelli (effettivi? dicotomici?) realtà/finzione.
È stato detto come le più celebri opere di Robert J. Flaherty siano considerabili esempi di docufiction, chiariamo pertanto il perché di tale classificazione e un possibile significato di tale etichetta, caratterizzata da parecchia ambiguità anche in relazione al termine docudrama.
Osservando come la pagina in inglese di Wikipedia qualifichi Nanuk l'eschimese come "film muto che combina [a prescindere dalla consapevolezza, n.d.r.] elementi di documentario e di docudrama" e come la versione italiana si limiti, con un curioso e/o grossolano impiego della congiunzione disgiuntiva, a bollarlo come "film drammatico o documentario", sarà bene - specie alla luce della posizione quantitativamente dominante dell'enciclopedia online - focalizzarci in primis sulla coppia terminologica.
Citiamo allora Wikipedia, di nuovo, un frammento in cui si dice che "i film documentari che, per finalità narrative, contengono al loro interno sequenza ricostruire e/o interpretate da attori vengono comunemente definiti docu-fiction o docu-drama": si noti come questi due stranierismi, oltre a essere legati da un'altra congiunzione di dubbio valore, siano collegati ipertestualmente ad una stessa scheda - dato già rilevante - che offre una panoramica sulla questione linguistica.
La riporto qui quasi per intero (senza corsivi), per poterla commentare nel dettaglio in seguito:
"I termini che usano fiction a volte sono usati per dare più enfasi all'aspetto fittizio della narrazione rispetto ad una più semplice drammatizzazione;
uno dei più comuni, docu-fiction, utilizzato anche come sinonimo di docu-drama, in alcuni testi è preferito per opere che pongono maggiore attenzione alla cura della narrazione rispetto alla documentazione degli eventi narrati, divenendo più simili a classici esempi di fiction.
Alcuni dizionari provano quindi a offrire sfumature di significato leggermente diverse per i due termini, definendo il documentario drammatico come la «drammatizzazione di eventi reali» e la docu-fiction come qualsiasi fiction la cui narrazione usa tecniche documentaristiche, oltre ad opere che mischiano immagini di eventi reali e ricostruzioni artificiali".
Accettiamo la tendenziale bipartizione, ma esploriamola: riallacciandoci anche alla complessa storia delle nozioni di diegesi e mimesi, segnaliamo infatti la non-scontatezza della relazione tra documentario e narrazione, relazione che, del resto, può prestarsi a diverse letture ideologiche.
Possiamo innanzitutto domandarci, ribaltando la prospettiva, se Cinema narrativo e Cinema di finzione siano concetti coincidenti o solo parzialmente sovrapponibili, o se addirittura l'aggettivo sia pleonastico, visto che, com'è stato detto, già la semplice presenza in un film di un inizio e di una fine - connessa ad una fruizione-tipo inevitabilmente lineare e dal tempo fisso - potrebbe fungere da embrione di una narrazione.
Seppur si possa trovare del vero in quest'ultima ipotesi, appelliamoci per ora al senso comune, anzi facciamolo due volte, per non dilungarci troppo: saltiamo quindi diversi passaggi logici e proseguiamo accettando la seconda alternativa, tra l'altro piuttosto convenzionale.
Diremo insomma che un documentario può essere narrativo (e che un film di finzione può essere non-narrativo), almeno in qualche maniera.


[Un frame da Nanuk l'eschimese] docufiction docufiction
Tale considerazione necessita tuttavia di ulteriori precisazioni, specie in due sensi: essa richiama in causa l'idea di diegesi e rende poi doveroso volgere le nostre attenzioni allo stesso concetto di narrazione.
Partiamo dalla diegesi: se la Treccani la definisce - in accordo con l'etimologia greca - come "la linea del racconto", è bene segnalare come nel tempo siano state avanzate altre interpretazioni teoriche, spesso estensive come quella che preferiremo, la quale intende la diegesi, in sostanza, come la realtà filmica nella sua interezza.
È perciò chiara la maniera in cui il nostro ragionamento può ricomporsi, alla luce di quanto detto sullo statuto ontologico del Cinema: così, quando sovente diegesi e finzione vanno a braccetto, sarà infatti possibile applicare il primo termine anche al documentario, tanto in virtù della specificità ontologica di ogni singolo film quanto del fatto che una certa strutturazione spaziotemporale (ed eventualmente narrativa, in senso stretto) è comunque deputata a tutte le pellicole, prescindendo dal loro genere/tipo testuale.
Per quanto concerne il secondo versante, ben più complesso, riallacciamoci invece alla tradizione narratologica, ovviamente interessata ai testi, letterari o cinematografici che siano, e apriamo una lunga digressione.
Ricorrendo al manuale di linguistica menzionato nella parte uno di questo percorso (L'italiano. Varietà, testi, strumenti), evidenziamo come gli autori, sulla scorta delle ricerche di quel Gérard Genette le cui teorie hanno riscosso successo nell'ambito della Settima Arte, individuino quattro proprietà formali del testo narrativo, ovvero la presenza di: un protagonista animato; una serie di eventi connessi a livello temporale e soprattutto causale; un evento atto a innescare tale concatenazione; azioni compiute dai personaggi in vista di un fine individuato.
Chiaramente il caso del documentario impone specifiche cautele, sia si considerino espressioni (quasi-)pure sia si prendano in esame prodotti ibridi, proprio perché - anche accettando quanto detto sull'ontologia - esso intrattiene sempre una particolare relazione con la realtà fenomenica, relazione che è alla base della stessa possibilità di distinguerlo, almeno nei casi più comuni, dalle opere di finzione.
Possiamo qui ricordare le riflessioni di Bill Nichols, forse il massimo studioso della forma in questione, considerando com'egli fissi alcune coordinate/premesse basilari parecchio utili e come renda chiaro il perché il film etnografico risulti convenzionalmente legato al documentario.
Per il teorico statunitense, parafrasando, un documentario è un qualcosa che parla - direttamente, almeno in un certo senso - della realtà, che mostra persone reali e che racconta storie su ciò che accade realmente, ed è quest'ultimo assunto a esplicitare una sfumatura essenziale.
Nichols non usa infatti formule quali "il documentario racconta ciò che accade realmente": in tal modo avrebbe sì posto in rilievo l'operazione di articolazione discorsiva propria ad ogni film, materializzata a livello di montaggio, ma avrebbe taciuto su di un passaggio che, peraltro, rende nuovamente possibile riflettere sui rapporti tra Cinema e ideologia.
È quel "su ciò che" a fungere da perno, a rendere chiara quella costretta assunzione di un punto di vista da parte del regista, tradotto tanto in un approccio interpretativo-connotativo nei confronti della realtà - una realtà dunque non univoca - quanto, appunto, nell'adozione di strategie retoriche, più o meno esplicite/individuabili, più o meno connotanti.
Insomma, il film documentario (come il film tout court) è necessariamente caratterizzato da una retorica, ma resta da capire quanto retorica e narrazione vadano di pari passo, e se quel raccontare sia assimilabile al dire e/o al narrare.
Provando a considerare la visione suggerita da Nichols e riflettendo su teoria e prassi del Cinema documentario, ci accorgeremo in modo piuttosto immediato di come il quartetto di criteri sopramenzionato possa risultare non-soddisfatto, almeno in senso stretto.
Del resto, com'è ovvio, il documentario può possedere una natura (o struttura) convenzionalmente definita come non-narrativa.


[Un frame da Nanuk l'eschimese] docufiction docufiction
Guardiamo allora alla classificazione dei tipi testuali (letterari) elaborata da Egon Werlich, che cataloga "in base alla funzione cognitiva prevalente e al macro-atto pragmatico" realizzato dal testo e distingue, di conseguenza, tipo descrittivo, narrativo, scenico, espositivo, argomentativo e regolativo: da questa prospettiva, traslabile non senza difficoltà in campo cinematografico, notiamo come pure il film tout court possa essere grossomodo declinato in queste cinque maniere, non reciprocamente esclusive.
Citiamo poi il teorico Paolo Bertetto: per lui "il film può essere una forma non narrativa" e, nello specifico, "il Cinema documentario […] è costruito con una logica che considera secondaria o inutile la narrazione" nonostante esso contempli sovente "componenti narrative".
Tra parentesi, è proprio questa tradizionale secondarietà della narrazione a determinare, almeno in un certo senso, la tendenza a ricondurre il film (filo-)etnografico nell'alveo del documentarismo.
Potremmo provare a intersecare le proposte di Werlich e Bertetto per dire come la logica sottesa al documentario paia spesso situata in bilico tra atteggiamento espositivo (didattico, e latamente descrittivo) e atteggiamento argomentativo (ben collegabile a certe strategie retoriche), senza per questo non poter presentare (necessariamente?) dei caratteri narrativi.
Ora, tali caratteri possono essere intesi in due maniere, una - stretta - legata ai quattro criteri summenzionati e una più indefinita: abbiamo già sottolineato come sia agevole comprendere la non-necessarietà della prima, ma il secondo approccio, invero parecchio composito, può comunque essere prezioso, mettendo in crisi alcuni spunti già presentati.
In primis, riferiamoci ancora alla tipologia di Werlich, accantonando Genette, quando schematizza alcune caratteristiche non-formali del testo narrativo: il suo focus è infatti rappresentato da fenomeni "colti nel loro contesto temporale", e la relativa matrice cognitiva riguarda la "capacità di cogliere le differenze e le interrelazioni tra le percezioni relative al tempo".
Questi riferimenti alla temporalità riguardano ovviamente il mondo diegetico, e ancor di più l'intreccio - mentre ad esempio il tipo descrittivo è connesso alle "percezioni relative allo spazio" -, ma possiamo provare a considerare anche il medium (attraverso cui è espresso il testo) in sè.
Nel nostro caso, essendo il Cinema un mezzo fondato sull'illusione di movimento, è lampante come la temporalità sia costitutiva, tanto da distinguerlo dalla fotografia, e altrettanto lampante - sarà esplicitato solo ai fini del ragionamento - è il fatto che tale tratto sopravviva (o, in parte sposando le tesi del filosofo Gilles Deleuze, si potenzi) in caso di assenza di un intreccio propriamente detto.
Le percezioni relative al tempo, dunque, risultano essere il cardine di un Cinema abitualmente bipartito in narrativo e non-narrativo, e risultano tali anche in virtù della centralità creativa accordata allo spettatore: è lecito chiedersi, difatti, se la narrazione sia un concetto solo legabile alla concretezza del film o se sia un qualcosa di rinvenibile anche/solo altrove, se sia un qualcosa di assoluto, posto in rapporto univoco con ciò che è impressionato su pellicola, o se sia qualcosa di mutevole.
Corre in nostro soccorso la teoria cognitiva del film, la quale, scrive Francesco Casetti, fa "riferimento a dei processi 'effettivi' messi in moto dallo spettatore anziché a dei processi 'simbolici' messi in atto dal testo", senza per questo svincolarsi dalle caratteristiche inequivocabili delle opere, almeno nel caso di David Bordwell, che riflette sui film di finzione (!) da un punto di vista anche formalista.
Questi, per Casetti, vede la narrazione come "un processo in cui un film suggerisce a uno spettatore dei passi che lo portano a ricomporre [mentalmente, n.d.r.] una storia", uno spettatore inteso come singolo che si affida, inevitabilmente, alle sue specifiche "capacità di percepire e comprendere".
E per ricomporre una storia egli - citiamo ora Bordwell - "deve assumere [ciò, n.d.r.] come scopo cognitivo centrale", deve insomma "applicare una serie di schemi derivati dal contesto e dalla esperienza previa" e, aggiungiamo, da alcune peculiari informazioni presenti nel film.


[Un frame da Nanuk l'eschimese] docufiction docufiction
In quest'ultimo senso possiamo connetterci ad una nozione elaborata dal teorico Roger Odin, non cognitivista, il quale formalizza una serie di "modi di produzione di senso" attraverso cui "ogni film orienta i percorsi che gli si applicano".
Ne individua diversi, tra cui due che parrebbero inconciliabili, quello finzionale e quello documentario: il primo è delle opere che "chiedono di 'partecipare' alle vicende [della cui finzionalità originaria il fruitore è conscio o semi-conscio, n.d.r.] dei loro personaggi", il secondo "mira a informare a proposito della realtà" e, per chi scrive, porta tendenzialmente con sé tanto le coordinate fissate da Nichols quanto un'inconfondibile idea/impressione di (copia della) realtà.
Sempre secondo Casetti, "ogni pellicola segnala, soprattutto all'inizio, se è una finzione o un documentario", tuttavia - in accordo con tutta un'altra serie di determinazioni che non approfondiremo - essa può, in potenza e anche involontariamente, giocare con questi due modi di produzione di senso, come magari nel caso di docudrama e docufiction.
Posto che lo spettatore sappia riconoscere quei tratti in grado di creare un miscuglio complesso, cosa che non sembra comunque scontata, pare plausibile che un film possa oscillare tra due poli e posizionarsi nella zona grigia di quel continuum che li collega.
Dico ciò perché sarebbe interessante valutare quali condizioni testuali (e non solo) siano richieste per innescare lo scopo cognitivo indicato da Bordwell, scopo che potrebbe invero assumere una posizione, comunque più defilata, in relazione ad un puzzle più complesso - in termini di statuto superficiale, per così dire, delle immagini e non di tortuosità dell'intreccio.
Ma forse un vago tipo di ricomposizione mentale da parte dello spettatore, di narrativizzazione a posteriori, potrebbe intervenire anche nel caso di un documentario tipico, tendente alla purezza e sprovvisto di certi dati testuali: chiaramente ciò si riconnette ai modi in cui possiamo intendere il concetto di componente narrativa (o in cui possiamo etichettare linguisticamente alcuni fenomeni).
In tal senso, un ultimo spunto prima di passare oltre: assieme al discorso sulla temporalità, potrebbe tornare utile - pure in un'ottica solo simil-maieutica - il ricorso alle nozioni di interpretazione, connotazione e strategie retoriche evocate riferendoci a Nichols.


[Un frame da L'ultimo Eden] docufiction docufiction
Dopo aver relato le diverse questioni sollevate, senza aver fornito risposte, possiamo chiudere questa tediosa digressione, volutamente corposa - tanto da aver determinato la peculiare denominazione di questo stessa disamina - vista la necessità di problematizzare dei concetti che non è possibile dare per scontati.
Prima di riprendere la trattazione sulle definizioni di docudrama e docudrama, vediamo adesso - invertendo l'ordine logico-argomentativo segnalato in precedenza - di adagiare sul nostro tavolo operatorio qualche fatto bruto, tornando a Flaherty e segnalando in modo elencatorio le principali caratteristiche controverse innanzitutto di Nanuk l'eschimese, il cui sottotitolo originale (A story of life and love in the actual Arctic) già sembra suggerire qualcosa.
Nel/per il film: si cambia il nome del protagonista in modo totalmente arbitrario; si assembla una famiglia ad hoc, ancora in maniera arbitraria; si opta per l'impiego di strumenti di caccia desueti al posto delle ormai consuete armi da fuoco; si altera la costruzione di un igloo per esigenze di ripresa; si costruiscono scenette/sequenze interamente poggiate sulla recitazione (come quella in cui Nanook finge di scoprire l'esistenza del grammofono) o, ancor più nello specifico, sul reenactment (come quella della caccia al tricheco).
È presente inoltre una certa narrativizzazione, basata sia sulla finzione recitativa sia sul tandem sceneggiatura (per quanto abbozzata)-montaggio, che mira, in definitiva, a far aderire il fruitore alle vicende: per Geoff Brown difatti "Flaherty era soprattutto un narratore", e lo stesso regista - che "non sostenne mai di essere un etnografo" - esplicitò come, in generale, "spesso bisogna stravolgere una cosa per coglierne il vero spirito".
Tale verità di spirito si lega sì a un dichiarato soggettivismo ("volevo raccontare agli altri quel che sapevo"), dunque in parte consapevole della propria non-obiettività, ma al contempo si connette ad una volontà, quella di "afferrare il punto di vista dei soggetti osservati" (come scrive Cecilia Pennacini), che si risolve anche in un rapporto interattivo tra osservatore e osservati in grado di generare implicazioni parecchio profonde - e dibattute - rispetto alla prassi antropologico-etnografica.
Parecchi elementi simili ritornano per L'ultimo Eden, pellicola in cui la narrativizzazione ritaglia, citando Il Morandini, una "esile storia d'amore", e in cui: si costruiscono ancora famiglie e relazioni fittizie; si selezionano gli abitanti locali in base alla loro fotogenicità; si impone il ritorno ad un abbigliamento tradizionale e sorpassato a scapito del costume occidentale già diffusosi; si ricreano scenette fittizie come quella del tatuaggio, il cui protagonista sarebbe stato addirittura pagato per sottoporsi - a favor di camera - al rituale.
Non è questa la sede per riflettere su problematiche di metodologia scientifica né per problematizzare le interessantissime questioni etiche sollevabili: quel che ci interessa è come due opere come queste, caratterizzate da un'apparentemente paradossale "autenticità messa in scena" (per usare l'efficace formula dell'antropologo Dean MacCannell), siano sovente reputate come i primi esempi di film (filo-)etnografici e di lungometraggi documentari.


[Un frame da L'ultimo Eden] docufiction docufiction
Se nella scorsa analisi abbiamo indagato il primo aspetto, ora è il momento di problematizzare la seconda tesi, in costante relazione con la prima anche alla luce di certi malumori suscitati dal cineasta statunitense: lo studioso Brian Wilson (via Barry Keith Grant) ad esempio "si chiede quanto diversa - e quanto migliore […] - la storia del Cinema documentario [e di quello etnografico, n.d.r.] sarebbe stata se un antropologo come Franz Boas […] avesse creato il paradigma" fondante al posto del non-specialista Flaherty.
È piuttosto chiaro, in relazione ai tratti esposti, come Nanook of the North e Moana non siano posizionati in prossimità di nessuno dei due estremi del continuum documentario-film di finzione, è evidente appoggiandosi tanto al senso comune quando alla letteratura sul tema, Bill Nichols in primis.
Riprendiamo dunque a considerare termini quali docudrama e docufiction, formatisi per cercare di incasellare - in chiave più o meno normativa - le espressioni ibride ma invero piuttosto fumosi.
Come visto, una delle pagine Wikipedia evocate in precedenza li accomuna poiché entrambe le forme filmiche conterrebbero "sequenze ricostruite e/o interpretate da attori": lasciamo perdere quel "per finalità narrative" in quanto, interpretandolo come riferimento ad una narrazione intesa in senso stretto, rifiutiamo la consequenzialità tra questa e delle operazioni di ricostruzione/recitazione forte.
Occorre però segnalare subito una macro-distinzione, sia per evitare rischiose generalizzazioni sia per spiegare l'ultimo aggettivo sia per riferirci alle condizioni definitorie segnalate dall'enciclopedia online: posto che ogni documentario è segnato da un certo grado di mediazione (e/o finzione e/o messinscena), è infatti insensato non distinguere l'incidenza e la natura profonda di tali interventi.
Per esempio, sul piano della recitazione si potrebbero individuare coaguli di continuum come recitazione zero, recitazione debole e recitazione forte: la prima è ineludibile, e fa sì che ogni individuo - tipicamente un non-attore, cosciente di essere inquadrato - dinnanzi alla cinepresa del documentarista crei una sorta di "autorappresentazione di sé", per Simone Moraldi; la seconda è quella del reenactment, procedimento in cui il non-attore recita consapevolmente (e dietro precisa richiesta) la parte di sé stesso, sovente cercando di rivivere/rappresentare una propria esperienza passata; la terza è quella classica, nella quale un individuo - tipicamente un attore - impersona qualcun altro.
Si potrebbe ravvisare inoltre una particolare zona interstiziale collocata tra secondo e terzo tipo: come definire chi sì interpreta la parte di sé stesso, ma si trova alla prese con qualcosa di non effettivamente esperito in precedenza, con qualcosa di magari scritto in una sceneggiatura?
O, ancora, come definire chi sì interpreta la parte di qualcun altro, ma si trova a innescare un processo di riviviscenza per soddisfare Konstantin Stanislavskij?
In quest'ottica, il caso di Flaherty sfugge ad esempio a semplici categorizzazioni, chiama in causa recitazione zero, reenactment e comportamenti che appartengono all'interstizio menzionato, considerando come, in Nanuk l'eschimese, il cambio di nome del protagonista non inneschi comunque una drastica modificazione dell'ontologia della persona-personaggio.


[Un frame da L'ultimo Eden] docufiction docufiction
Tale discorso ipotetico sulla recitazione è parzialmente estensibile anche ai concetti di mediazione e di finzione, consci di come pure in espressioni documentaristiche in senso stretto l'incidenza può essere assai diversa, specie in superficie e nel caso della mediazione (si vedano le sei modalità teorizzate da Bill Nichols).
Nel nostro percorso definitorio, le condizioni segnalate da Wikipedia - analizzata, lo ripeto, alla luce della sua popolarità - non forniscono pertanto appigli univoci o troppo auspicabili.
Ricorriamo allora alla Treccani, per mettere a sistema ciò che troveremo con la questione terminologica presentata sempre su Wiki: nella sezione sui neologismi il docudrama è definito come "film o programma televisivo che rappresenta fatti storici o di cronaca realmente accaduti", mentre la docufiction vanta due schede.
La prima parla di "produzione […] che ricostruisce nella forma del documentario, ricorrendo però alle strategie e alle tecniche narrative della fiction, fatti storici o episodi di cronaca", la seconda - più approfondita - si biforca a sua volta, propone due definizioni: una vede la docufiction "mescolare la vena documentaristica (per es. riprese in set reali) a una ricostruzione che fa uso di attori non professionisti che rivivono, raccontano, mettono in scena la loro vita", l'altra la intende come "ricostruzione di fatti realmente accaduti […] ma con uso di attori professionisti".
Si noti innanzitutto un aspetto linguistico, il ripetersi tre volte del concetto di ricostruzione e l'impiego sinonimico del verbo rappresentare, che si salda con il costante riferimento ad un reale specifico, un reale sempre preesistente ed escluso dal momento della creazione filmica.
Storia, cronaca e reenactment sistematico sono difatti tre vie per scollare il film dalla realtà fenomenica (concedendo peraltro gradi di interpretabilità assai variabili), quindi vale la pena chiedersi quanto possa aver senso applicare l'etichetta di documentario, anche solo parzialmente, a certi prodotti.
Riferiamoci di conseguenza, per procedere nel ragionamento, alla nozione di mockumentary, per la Treccani "un particolare genere, che simula lo stile e il procedimento documentaristico nascondendovi invece la costruzione di una fiction".
Dove posizionare, grossomodo, tale genere nel continuum avente per estremi documentario e film di finzione?
Di certo né tra gli ibridi né nelle vicinanze del primo polo, poiché già il dato preesistente è finzionale, il che mostra come l'adozione di stili e procedimenti comunemente associati al documentario non possa fungere da discriminante (anche perché è impossibile e insensato, di per sé, isolare delle forme proprie ad un solo genere/tipo testuale).
Il mockumentary è insomma un film di finzione a tutti gli effetti, come pare piuttosto ovvio, e possiamo prendere spunto dalla motivazione fornita per compiere una precisazione: abbiamo infatti usato due volte il concetto di preesistenza, ma questo invero accoglie due diversi significati.
Nel caso del falso documentario, ciò che preesiste è una premessa ideale fittizia, tradotta poi in un profilmico più o meno fittizio; nel caso di una ricostruzione di un fatto storico/di cronaca/vissuto, ciò che preesiste è una premessa ideale derivata dalla realtà storico-fattuale, che può tradursi in un profilmico dalle caratteristiche ambigue: talvolta può essere quasi interamente fittizio, come in certe ricostruzioni storiche, altre volte può essere ben più reale, come in occasione di reenactment sistematici attuati da attori non professionisti nei "set reali" menzionati dalla Treccani.
Da tali indicazioni di massima possiamo trarre qualcosa a proposito del documentario quasi-puro, qualcosa di simile alle teorie di Nichols: esso, come suggerisce la forma lessicale, non poggia del resto su una premessa contenutistica da ricostruire, ma semmai su di una particolare intenzione produttivo-progettuale.
A livello tendenziale, il documentario coglie la realtà fenomenica nel suo farsi (non ex post e non orientandola con forza), impiega persone reali e un profilmico, nella sua interezza, reale: ovviamente modifica tutto ciò in qualche modo e, nel nostro caso, ne altera pure l'ontologia.


[Un frame da L'ultimo Eden] docufiction docufiction
Questi possono essere dei parametri da cui partire per definire i prodotti ibridi e per superare le voci della Treccani, le quali - oltre alla loro brevità - non sembrano essere in grado di accogliere molti degli spunti presentati.
Ipotizziamo allora due definizioni basate su alcune indicazioni suggerite da Wikipedia, facendo attenzione alle composizione lessicale dei due termini in questione, docudrama e docufiction.
Incominciamo dal docudrama: per chi scrive, pare sensato definirlo come "drammatizzazione di eventi reali", a patto che però alcune delle caratteristiche del documentario quasi-puro siano rispettate.
In tal modo, sarà un docudrama la pellicola che opti per un reenactment sistematico dai contorni precisi, quella in cui delle persone reali recitano in un contesto reale (nel senso di profilmico e in modo tendenziale) dei fatti già vissuti, fatti che, in quanto selezionati a priori, si prestano sovente alla narrativizzazione stretta e che, inoltre, rendono evidente allo spettatore accorto l'ibridismo.
La distanza dal documentario, appunto, risiede dunque nell'esistenza costante di una premessa ideale, ragion per cui certi fatti storici, di cronaca e pure semplicemente vissuti non possono divenir base per un docudrama se a mancare sono le persone reali e/o il profilmico reale.
Com'è ovvio, anche quest'ultime situazioni, con diverse sfumature, presentano dei tratti ibridi, ma le loro possibili traduzioni paiono più vicine al polo finzionale e non degne di contemplare un riferimento forte al documentario: esse potrebbero pertanto essere accolte in una concezione allargata - proprio a livello di collocazione nel continuum - di docudrama o, meglio, essere denominate in altro modo.
Il termine docufiction sembra invece essere indicato per le opere che fondono/giustappongono elementi documentari quasi-puri ed elementi (ri)costruiti.
Il mix, che già allontana dal docudrama, si fonda sulla presenza di persone reali che operano in un contesto reale (in senso tendenziale, come nel caso del docudrama), e il lato fittizio può riguardare l'esistenza di premesse ideali di due tipi: le prime sono quelle derivanti dalla realtà fattuale, e che dunque generano dei reenactment, delle ricostruzioni, le seconde sono quelle finzionali, generate da un progetto sì slegato da una realtà effettivamente preesistente ma, di norma, non dall'ontologia della persona-personaggio.
Il tutto si presta meno alla narrativizzazione stretta, e sul versante attoriale innesca un recitazione meno forte rispetto a quella richiesta dal docudrama (che impiega una forma sistematica e molto marcata di reenactment): anche in questo caso, poi, il fruitore può scorgere la presenza della finzione, sebbene questa, rispetto a prima, divenga più difficile da individuare e valutare.
Nonostante possano sembrare piuttosto precise, comunque, le definizioni proposte - come quasi tutte le definizioni - sono soggette a variabilità/estensibilità, essendo derivate da casi ideali generalizzati e posizionate in un punto specifico del continuum, e sono da rapportare alla prassi filmica: così le due pellicole di Flaherty che abbiamo citato paiono più affini al nostro modo di intendere la docufiction, pur presentando tratti problematici.


[Un frame da L'ultimo Eden] docufiction docufiction
Forse, però, in tal modo le definizioni risulterebbero ora poco applicabili alla prassi - necessitando di continue precisazioni - ora troppo sfuggenti, impiegate magari in modi fin troppo vari, e forse, in fin dei conti, potrebbe essere poco sensato proprio isolare due termini ibridi.
Del resto, l'idea stessa di ibridismo contiene invero una connotazione spesso tendente al negativo, essendo contrapposta alla purezza, che pare difficile da accettare, ma non solo.
Abbiamo intravisto come - potenzialmente anche alla luce del discorso ontologico - nel Cinema la purezza, ai due poli del continuum, non esista mai, come ogni pellicola sia intrinsecamente ibrida: invece di partire da due poli per individuare, in un secondo momento, una loro intersezione, potrebbe allora aver senso ribaltare la prospettiva di partenza.
Come scrive il teorico Daniele Dottorini, il Cinema è difatti "arte impura per eccellenza", e "la linea Lumière e quella Méliès", la cui opposizione fonda la dicotomia documentario-film di finzione, sono "co-originarie al Cinema stesso": di conseguenza, si potrebbe intendere l'ibridismo come una (im)purezza costitutiva in grado di biforcarsi, di generare - paradossalmente e provocatoriamente - due forme minori, non di essere generata (posto abbia senso parlare di generazione), per la felicità di Jean-Luc Godard.
In grado di annullare il senso di termini/concetti come docudrama e docufiction, a maggior ragione vista la loro fragilità.
In tutto questo, tuttavia, sono pur sempre da considerare l'evoluzione storica del Cinema, anzi, dell'istituzione Cinema, e il lato spettatoriale, per dirne due: la dicotomia rifiutata, a prescindere dalle dissertazioni teorico-critiche, occupa ineluttabilmente un ruolo fondamentale, è alla base della stragrande maggioranza degli atti fruitivi, il che ci riporta a Bordwell e Odin.
Dunque, che fare?
Nulla: scrivere due parole per contrastare delle separatezze discutibili ma difficilmente modificabili, piegarsi alla realtà dei fatti e abbozzare delle definizioni, rigettarle appena formulate e ripartire daccapo, girare probabilmente in tondo.
Chiudiamo così, con più dubbi che certezze, questa seconda parte di analisi, questo intermezzo che si è reso necessario per affrontare al meglio il terzo e ultimo segmento, in cui - tra un mese - andremo a considerare esempi concreti non più riconducibili a Flaherty e a introdurre, in parallelo, anche concetti come quello di etnofiction.
Ti è piaciuto questo articolo?
Sappi che hai appena visto il risultato di tanto impegno, profuso nel portarti contenuti verificati e approfonditi come meriti!
Se vuoi supportare il nostro lavoro perché non provi a far parte de Gli Amici di CineFacts.it?
Cinerama Out.
Chi lo ha scritto

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE
Lascia un commento

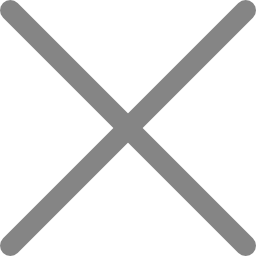
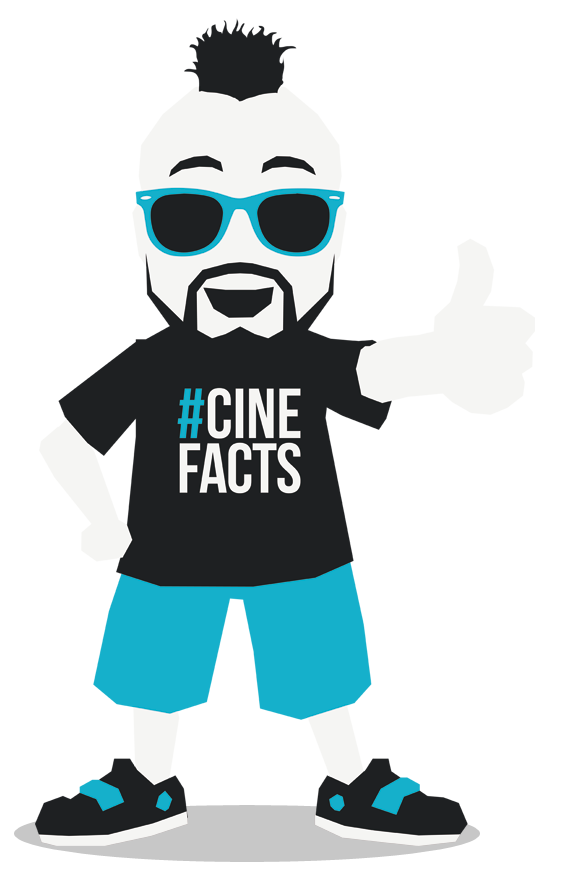

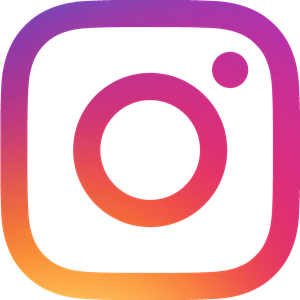




 :joy:
:joy: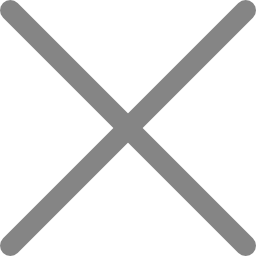
 Commentare gli articoli
Commentare gli articoli