
#Cinerama
L'attore feticcio per François Truffaut e Tsai Ming-liang - Cinerama 19
Jean-Pierre Léaud e Antoine Doinel, Lee Kang-sheng e Hsiao-kang
Due registi difficilmente accostabili, una svolta concettuale: François Truffaut e Tsai Ming-liang, collocandosi all'interno di una stessa linea evolutiva, aggiornano e superano il concetto di attore feticcio, avvalendosi di interpreti come Jean-Pierre Léaud e Lee Kang-sheng.
Entrambi i cineasti oltrepassano una definizione legata alla mera frequenza di collaborazione, e inglobano una serie ben più ampia di nodi tematici: coautori - e non solo veicoli - di questo consapevole processo di ridefinizione sono gli attori di riferimento.
Esaminiamo quindi in sequenza questi due processi esplicitamente collegati, relati a livello profondo ma ovviamente generati da premesse contestuali (sia in senso ampio che cinematografico) diverse.
Partiamo da Truffaut, dal suo primo lungometraggio.
Sul finire degli anni '50 egli decide di realizzare un film "in gran parte autobiografico", concentrandosi sul proprio periodo adolescenziale, parecchio travagliato.
Concepisce così I 400 colpi, ma sottolinea con veemenza uno scarto non indifferente, visto che "non tutto è autobiografico, anche se tutto è vero. Che quelle avventure siano state vissute da me o da un altro non ha importanza, l'essenziale è che siano state vissute".
Da ciò emerge una visione complessa - che poi andrà modificandosi - del rapporto tra realtà e finzione, che considera e miscela modelli parecchio differenti tra loro, tra Jean Vigo, Alfred Hitchcock, Jean Renoir e Roberto Rossellini, per dirne quattro: come scrive la Treccani, il fine ultimo è "la restituzione della vita attraverso la finzione cinematografica", e l'interrogativo principe riguarda le modalità concrete.
Sulle prime, nel redigere la sceneggiatura, Truffaut costruisce un alter ego, Antoine Doinel, più conforme a sé dal punto di vista ontologico che esperienziale, nonostante il grado di affinità sia elevato in entrambi i sensi: in fase di casting va quindi alla ricerca di una "somiglianza morale […] più che fisica", anche se inizialmente sembra scartare il tredicenne Léaud a causa del suo "viso […] troppo femminile" immortalato su una fototessera.
Le audizioni in loco (qui un estratto) sono però una vera e propria epifania: il giovane si presenta coi capelli quasi rasati, tanto da sembrare fin "troppo brutale", ma folgora il regista grazie alla sua personalità e al suo "gran desiderio di ottenere la parte".
"Dava l'impressione di una grande intensità, di nervosismo; faceva il disinvolto, ma non lo era affatto".
Ciò rende subito evidente l'esistenza di alcuni "scollamenti con la sceneggiatura": l'alter ego fin lì tratteggiato era "fragile, […] indifeso, meno aggressivo", mentre Léaud si mostra "arrogante, […] sfacciato".
Come Truffaut, anche il giovane - "continuamente sospeso da tutte le scuole di Francia" - ha alle spalle dei trascorsi difficile, ma essi divergono nell'esprimere un certo senso di "ribellione".
Potenzialmente in difficoltà, il regista decide di accogliere la "vitalità" di Léaud sposando la poetica di Renoir, uno dei numi tutelari della Nouvelle Vague: per le Patron "l'attore è più importante del personaggio", dunque Truffaut decide anch'egli di "sacrificare l'astratto per il concreto".


[François Truffaut] attore feticcio attore feticcio
Nasce così un "personaggio immaginario che si trova ad essere la sintesi di due persone reali", la cui effettiva realizzazione deve molto all'apporto creativo di Léaud.
Egli, sprovvisto di basi tecniche e animato da una buona dose di sana incoscienza, recita procedendo in modo empirico, forzando inizialmente il regista.
In fin dei conti, il giovane risulta però essere un "collaboratore prezioso", che "per istinto trovava i gesti giusti, rettificava il testo […] e impiegava le parole che aveva voglia di impiegare", e ciò rivela molto anche in merito al metodo di direzione degli attori di Truffaut.
Nonostante l'impronta linguistica impressa alla sceneggiatura da Marcel Moussy, il regista concede difatti un notevole margine di manovra a Léaud: come riferisce lo stesso interprete, le indicazioni principali consistono solo in "un'idea di quello che dovevo fare o dire", e vengono poi filtrate in maniera abbastanza spontanea.
Il massimo esempio in tal senso è rappresentato dalla sequenza - realizzata evitando di netto la classica alternanza campo-controcampo - in cui Antoine risponde alle domande della psicologa: per Jacques Rivette si tratta della "prova del nove […] della verità […] di questo film", in cui "l'improvvisazione più totale coincide con la ricostruzione più rigorosa".
Come rivela Truffaut, Léaud non ha battute scritte, dispone solo di vaghe istruzioni circa le domande e il "senso base delle risposte": sulle prime questa libertà ancor più ampia risulta spiazzante, ma acquisito un minimo di dimestichezza egli diventa "tanto spontaneo nelle […] risposte che alcune erano basate sulla sua stessa vita".
Talvolta la direzione attoriale acquisisce però maggior rigidità, rendendo chiara l'ovvia non-preminenza della coautorialità di Léaud: a livello aneddotico e paradigmatico, possiamo nominare due casi.
Il primo riguarda l'episodio clou in cui Antoine interagisce con un insegnante per giustificare un'assenza, a proposito del quale il regista riferisce - avendo al momento solo tre lungometraggi all'attivo - di "non […] aver mai diretto nessuno con [tale, n.d.r.] precisione […] perché sapevo esattamente come la volevo".
Il secondo caso concerne invece quello che Truffaut definisce "il complesso [di Léaud, n.d.r.] di sembrare antipatico", che determina un conseguente divieto di sorridere per non turbare la resa emotiva del film.


[Léaud/Antoine ne I 400 colpi] attore feticcio
Vale la pena spendere (o prendere in prestito) qualche parola in merito all'impianto stilistico della pellicola e al senso complessivo del rapporto Truffaut-Doinel-Léaud.
Come detto, le ispirazioni cinematografiche del regista sono varie, talmente varie da determinare un'apparente incompatibilità tra diverse dichiarazione dello stesso.
Egli afferma come "gran parte del film fosse essenzialmente documentario", e Rivette individua un riferimento imprescindibile in Robert J. Flaherty, documentarista statunitense collocato da André Bazin nella cerchia dei "registi che credono nella realtà" - opposti a quelli "che credono nell'immagine" - e precursore del cinéma vérité.
Rivette identifica con gran lucidità la forza del Truffaut de I 400 colpi, che consiste nel "non parlare mai direttamente di sé stesso, ma di legarsi pazientemente a un altro ragazzino […] e a questo sottomettersi ricostruendo umilmente, a partire da un'esperienza personale, una realtà parimenti oggettiva, che poi filma con il più assoluto rispetto".
Truffaut stesso, nei primi anni Sessanta, definisce però il film "hitchcockiano", perché "dalla prima all'ultima inquadratura ci si identifica con il ragazzino": negando l'efficacia della ripresa in soggettiva, egli comprende - a posteriori - l'importanza del "viso di cui [il pubblico, n.d.r.] ha più spesso incontrato lo sguardo".
"Facendo un documentario su di lui [Léaud, n.d.r.], io credevo di essere oggettivo, ma più lo filmavo di faccia, più lo rendevo presente".
Nasce pertanto così un "film totalmente naïf" e "inconsciamente scaltro", dall'esito talmente felice da generare una saga che vede "seguire un personaggio per vent'anni, osservandolo crescere nel corso di cinque film".
Già, perché tra 1962 e 1979 Antoine Doinel compare in quattro opere (tre lungometraggi e un corto): la prima è Antoine e Colette, segmento del film collettivo L'amore a vent'anni.
A differenza della pellicola precedente Truffaut parte con poche idee abbozzate ("solo il contorno"), e di conseguenza - forte anche di un approccio produttivo poco ingombrante - concede maggior spazio all'improvvisazione di Léaud e Marie-France Pisier.
Il personaggio di Doinel continua a essere una sintesi tutto sommato equilibrata, ed emerge ancora un marcato riferimento autobiografico per quanto riguarda il regista: l'altalenante rapporto tra Antoine e Colette s'ispira difatti a una travagliata relazione culminata in un tentativo di suicidio (nel 1950).
Sia il giovane Truffaut che Antoine che Léaud sono prossimi alla maggiore età, e la loro sovrapposizione giunge forse all'apice: nel raccontare con realismo le cronache quotidiane e sentimentali del protagonista, regista e interprete tratteggiano una figura psicologicamente più sfaccettata (cresciuta).


[Léaud e Marie-France Pisier sono Antoine e Colette]
Nel complesso, le prime due apparizioni di Doinel paiono molto coese, e gli scarti individuabili sono pienamente integrati alla luce delle due variazioni più rilevanti, quella contestuale (proprio a livello degli ambienti frequentati da Antoine) e quella anagrafica.
In particolare, ciò determina il sopravvento della tematica amorosa, costante che attraversa l'intera filmografia di Truffaut e che, nel caso del ciclo di Doinel, non poteva certo prescindere da uno studio della situazione familiare come quello confezionato ne I quattrocento colpi.
Esplicitata tale coesione, nel 1968 - coordinata da non trascurare - si apre tuttavia una frattura, un solco che separa con una certa chiarezza prima e seconda parte del ciclo.
Truffaut realizza Baci rubati per "lavorare di nuovo con Jean-Pierre", e nel frattempo decide di cambiare le carte in tavola: passa dal b/n al colore, da un impianto simil-rosselliniano a un naturalismo stilistico più disteso e (apparentemente) convenzionale, approda in definitiva alla commedia sentimentale, abbandona un certo tipo di radicalismo stilistico-produttivo proprio della Nouvelle Vague.
In breve, egli raggiunge un punto di svolta decisivo nell'ambito del proprio percorso autoriale.
Nonostante le sue opere più note siano grossomodo le prime - in modo non certo ingiustificato -, ritengo sia un'altra la cifra formale più personale del regista, quella la cui (prima) maturazione è collocabile a cavallo tra anni Sessanta e Settanta.
Benché grandissimi film come I 400 colpi, Tirate sul pianista e Jules e Jim presentino anch'essi uno stile facilmente riconoscibile, sono pellicole come Baci rubati (tra le commedie) e Le due inglesi (sul versante drammatico) a rappresentare il cuore ideale del Truffaut autore.
Posto che un autore/artista può benissimo non essere riconducibile ad un unico stile, pare sensato ipotizzare una bipartizione - o addirittura tripartizione - della filmografia del regista.
In ogni caso, è significativo il fatto che la prima svolta coincida con un episodio del ciclo di Doinel: lo stesso Truffaut esplicita di voler traslare il focus, che passa dall'individualità del protagonista a una visione più corale, valorizzando e aggiungendo "diversi ruoli di supporto".
In tal maniera egli decide di avvicinarsi a una "tradizione narrativa basata più sull'osservazione e sulla sintesi che sulla soggettività e l'esplorazione di sé", imbastendo un'operazione che raggiungerà la propria acme ne Gli anni in tasca.


[Léaud/Antoine in Baci rubati] attore feticcio
Baci rubati assume inoltre particolare rilievo nell'ambito del nostro discorso per diverse altre ragioni.
Innanzitutto, Doinel muta caratteristiche: per il cineasta "è lo stesso personaggio: come me ma non me; come Jean-Pierre Léaud ma non Léaud", ma invero si scorge un certo, nuovo disequilibrio.
Antoine de Baecque e Serge Toubiana, biografi del regista, notano difatti come "sempre più spesso i gesti, gli atteggiamenti, gli aneddoti e persino i ricordi del personaggio appartengono allo stesso Léaud".
E "Truffaut era pienamente consapevole di ciò e lo incoraggiava, senza mai frenare le improvvisazioni", dunque riducendo senza patemi la propria componente autobiografica.
Nel complesso del film, però, sia le reminiscenze di Truffaut che quelle di Léaud perdono importanza tematica, allontanando ulteriormente l'opera dalle precedenti del ciclo: nonostante l'avvento di un'estetica naturalistica più consona alla filosofia del regista (che sarà poi perfezionata da Néstor Almendros), la finzione emerge infatti - in termini relativi - dal punto di vista narrativo.
Non si tratta, di per sé, di un procedimento nuovo per Truffaut, considerando come quattro dei suoi sei lungometraggi precedenti fossero basati su romanzi dagli intrecci perlopiù netti e fattuali, e come le relative trasposizioni filmiche non nascondessero né la loro origine letteraria né una certa schematicità.
Tirate sul pianista presentava in aggiunta anche elementi di metacinema, nel segno del confronto con gli archetipi del noir hollywoodiano: nulla di più distante da I quattrocento colpi e Antoine e Colette.
Baci rubati, privo di ispirazioni dirette letterarie o cinematografiche, risulta essere grossomodo equidistante dai due poli.
L'interazione creativa tra Léaud e Truffaut rimane significativa, ma senza il margine di manovra del corto di L'amore a vent'anni: alcune scene sono completamente improvvisate e la sceneggiatura è tutto fuorché rigida, tuttavia il plot pare più costruito.
La struttura portante non è definibile convenzionale, come testimoniano le molte parentesi - iper-naturalistiche se considerate da sole - e l'approccio corale, ma il ritmo, la concatenazione degli eventi e alcune sequenze specifiche ne mostrano la presenza a più riprese.
Truffaut non cerca comunque di esibire l'artificiosità, ma allontanandosi consapevolmente dai propri autori di riferimento abbraccia (parzialmente) una concezione piuttosto classica della narrazione, e la componente finzionale acquisisce dunque rilevanza.
Considerando la fase di scrittura, sono paradigmatiche due scelte: "sfogliando un elenco telefonico" si decidono le sorti della vita professionale di Antoine, che lavorerà per un breve periodo come investigatore privato, mentre sul versante privato si guarda alla "fantasia di ogni giovane uomo: una relazione con una donna sposata".
A livello puramente recitativo, il ventiquattrenne Léaud definisce poi il proprio personalissimo stile, tanto legato alla propria esperienza/personalità quanto scarsamente mediato dalla tecnica.
Per Giacomo Giossi la "teatralità della recitazione", talvolta esagerata, genera "una tensione emotiva che attraversa anche i gesti più quotidiani", per Truffaut egli "secerne plausibilità e verosimiglianza, ma il suo realismo è quello dei sogni": come nel caso della narrazione, è evidente come non sia possibile parlare solo di naturalismo o antinaturalismo.


[Léaud/Antoine in Non drammatizziamo... è solo questione di corna] attore feticcio attore feticcio
Tutto ciò che è stato detto a proposito di Baci rubati risulta quasi interamente riproponibile, in senso tipologico, per quanto riguarda due capitoli conclusivi del ciclo.
Nel 1970 esce - per la gioia dei titolisti italiani - Non drammatizziamo… è solo questione di corna, per chi scrive il punto più basso della saga e forse della carriera di Truffaut, mentre nove anni più tardi L'amore fugge segna il definitivo congedo di Antoine.
Il primo dei due film è un'altra indagine sentimentale, stavolta della vita di coppia, mentre il secondo è oggetto filmico insolito.
In ogni caso, entrambi presentano un Antoine poco evoluto rispetto a Baci rubati, e ciò pare essere un problema per Truffaut, che ammetterà di non essere soddisfatto dal ciclo nel suo insieme.
Egli sottolinea come Doinel sia in fin dei conti un personaggio "infantile", e come le idee sul personaggio e "il modo in cui Léaud lo interpreta sono strettamente legate all'adolescenza".
Ciò genera un problema simile a quello dei fumettisti, che "creano un personaggio che avrà la stessa età per sempre": il pieno raggiungimento dell'età adulta da parte di Antoine è problematico, visto che "la vita di Antoine Doinel è solo […] la vita di una persona con le sue contraddizioni e i suoi difetti" e che, di conseguenza, la dialettica comica reiterazione-variazione non può bastare.
Tale nodo tematico rende piuttosto evidenti, a livello generale, alcune variazioni nel personaggio.
Truffaut, che pur nota una certa "somiglianza tra Doinel e Jean-Pierre nel non voler crescere", rileva il distacco crescente tanto rispetto a sè quanto rispetto a una certa forma di realismo: Antoine è ormai sempre più un personaggio di finzione inserito in un mondo di finzione che, guarda caso, presenta problematiche tipiche dei personaggi di finzione.
Questa evoluzione (o involuzione) potrebbe essere interpretata alla luce delle riflessioni metalinguistiche, spesso incentrate sulla scrittura, che il regista dissemina in diverse pellicole: proprio negli ultimi due capitoli del ciclo, ad esempio, Truffaut tematizza la trasposizione artistica autobiografica.
Ripercorrendo a ritroso la propria esistenza, Doinel scrive e pubblica difatti un romanzo, Le insalate dell'amore, un romanzo - come si scoprirà in L'amore fugge - ricco però di modifiche arbitrarie.
Ancor più pregno di significato è un episodio simile narrato in L'uomo che amava le donne, film il cui titolo corrisponde proprio a quello dell'autobiografia del protagonista: a un certo punto quest'ultimo, osservando la correzione di una bozza del proprio libro, decide di colpo di cambiare un dettaglio insignificante.
Il vestito di una bambina nominata una volta sola, di sfuggita, in uno dei tanti ricordi, da rosso diventa blu: questa variazione, voluta da un personaggio in cui Truffaut parzialmente si riversa e che potrebbe sembrare immotivata, parrebbe comunicare la necessità di separare - almeno un minimo - realtà e rappresentazione.
Il tema, che si ricollega al doppio scollamento sopracitato, è ovviamente centrale per l'autoriflessivo Truffaut, ma la sua insoddisfazione riguardo la conclusione del ciclo attenua, in parte, tali considerazioni.


[Léaud/Antoine in L'amore fugge] attore feticcio
Questo insieme di elementi, positivi o negativi che siano, genera però nel regista un nuovo (e non preventivato?) tipo di consapevolezza, che si riallaccia anche alle due opere nelle quali Léaud appare non nelle vesti di Antoine, realizzate tra quarto e quinto capitolo del ciclo.
In entrambe le pellicole Léaud interpreta dei personaggi con delle caratteristiche costitutive ambigue.
Nel dramma storico Le due inglesi, ambientato a cavallo tra Ottocento e Novecento, egli impersona Claude Roc, che - scrive Truffaut - "è nato ricco e si sente a suo agio nella vita, a differenza di Antoine Doinel".
Claude - come gli altri personaggi - è figlio della penna di Henri-Pierre Roché, ma Truffaut, Doinel e Léaud esercitano comunque una certa influenza: autobiografica per il primo, indiretta per il secondo, ontologico-recitativa per il terzo.
Il regista trova una corrispondenza fattuale, a grandi linee, tra il romanzo e una vicenda amorosa vissuta nel concreto, e proprio il tratto sentimentale e problematico - in chiave però tragica - di tali vicissitudini richiama debolmente le avventure di Antoine (e ciò invero dice qualcosa su Truffaut).
Il peculiare e non troppo mediato approccio attoriale di Léaud, che poggia molto sulla sua fisicità/gestualità naturale e sulla sua personalità, aggiunge poi un'ulteriore strato al personaggio.
Nell'ottica del nostro discorso è però ben più rilevante Effetto notte, premiato dall'Academy come Miglior Film in Lingua Straniera nel 1975.
In questo gioiello del metacinema, Léaud presta il volta all'attore Alphonse, personaggio slegato per la prima volta da qualsiasi tipo di auto-proiezione da parte di Truffaut, visto che questi interpreta direttamente il proprio alter ego, il regista Ferrand.
Alla luce dell'intento principale della pellicola, Alphonse risulta essere connesso profondamente a Léaud, e indirettamente ad Antoine: Simone Emiliani, per la Treccani, scrive che "Léaud impersona sé stesso" e che "l'adesione alla parte e gli spunti autobiografici […] sembrano fondersi.
L'instabilità sentimentale del suo personaggio (che è la stessa di Doinel) e la necessità di portare sullo schermo qualcosa di sé stesso da parte di Léaud costituiscono elementi propri di un metodo di avvicinamento al ruolo basato più sull'istinto che sulla tecnica".
Toubiana e de Baecque confermano come l'infantile Alphonse ricordi - in maniera talvolta non preventivata ma sempre consapevole - "il Léaud dei primi anni Settanta", anche per quanto riguarda il rapporto con Truffaut/Ferrand.
In aggiunta, il legame tra Alphonse e Antoine è poi esplicitato da una curiosa corrispondenza, la riproposizione integrale di una linea di dialogo pronunciata in Effetto notte nel successivo L'amore fugge.
La partner di turno sottolinea infatti come il personaggio interpretato da Léaud abbia bisogno contemporaneamente "di una moglie, di un'amante, di una balia, di un'infermiera, di una sorellina", anche a causa di una "infanzia difficile".
In ciò è sì rinvenibile un collegamento con Truffaut, ma nel personaggio, complessivamente, è Léaud a prevalere con decisione, il che determina un progressivo mutamento di sensibilità da parte del regista.
Tale evoluzione concettuale trova piena espressione proprio in L'amore fugge, "una specie di riassunto, di conclusione di tutto il ciclo".
Truffaut, riservando diciotto dei novanta minuti totali a flashback vari, decide difatti di "sfruttare un'opportunità mai concessa a nessun regista": impiegando veri e propri spezzoni dei primi quattro capitoli della saga per realizzare le molte analessi, egli cattura in maniera sublime e malinconica lo scorrere del tempo, uno scorrere del tempo che vive sulla pelle (di celluloide) di Jean-Pierre Léaud.


[Léaud e Truffaut sono Alphonse e Ferrand]
Ecco, questo punto specifico è forse il nesso essenziale che avvicina François Truffaut e Tsai Ming-liang, regista taiwanese di origini malesi.
In toto, quest'ultimo ha mutuato dal primo - radicalizzandole - diverse convinzioni tecnico-teoriche, in senso sia complessivo sia esclusivamente recitativo, e ha esplicitato il suo essersi posto nel solco tracciato dal cineasta francese collaborando per due volte proprio con Léaud.
Il suo attore feticcio è però il taiwanese Lee Kang-sheng, comparso in tutti gli undici lungometraggi per il cinema diretti tra Tsai, dal 1992 in poi.
Prima di analizzare la collaborazione tra Tsai e Lee, sarà utile fornire qualche coordinata generale in merito all’inconfondibile stile - che potremmo definire parametrico - del regista.
Elenco alcuni tratti principali: cinepresa spesso fissa; inquadrature dalla lunghezza estenuante; filmico e profilmico austeri; assenza di colonna sonora (con alcune lampanti eccezioni); troupe iper-leggera; centralità del sonoro in presa diretta; ambientazione in grandi metropoli (specie Taipei); scenografie reali; uso continuativo di un ristretto nucleo di attori; plot stringatissimi o quasi assenti; dialoghi e azioni rarefatti e dai ritmi compassati; tematiche intrecciate come solitudine esistenziale e sessualità.
Molte caratteristiche, tanto estetiche quanto produttive, rimandano a una drasticità concretamente e idealmente collegata alla Nouvelle Vague e al pensiero di Bazin, mentre alcune se ne distaccano con nettezza, come l'ambiguo rapporto tra naturalismo e antinaturalismo (che ora non approfondiremo).
Già, perché si tratta senza dubbio di un autore con la maiuscola, ben conscio della lezione di Truffaut, tanto dal punto di vista teorico quanto pratico.
Sul primo versante, il riferimento principale è quella "politique des auteurs" inaugurata dall'allora critico nel 1955, che determina, sul secondo versante, una graduale riduzione della troupe: l'esito più estremo è raggiunto proprio nell'ultima pellicola di Tsai, Days, "interamente creazione del regista".
Nonostante sia spesso associato - a ragione, in chiave stilistica - a Robert Bresson, Tsai ammira e introietta inoltre la capacità del Truffaut autore di creare "il suo mondo, che filma ancora e ancora".
In modo ancor più rigido, egli sviluppa alcune costanti che attraversano ogni opera, e che vanno a costituire un corpus filmico dalla coerenza ineguagliabile, un unico film realizzato in tre decenni ("per questo i miei film assomigliano alla realtà: è una ripetizione").


[Tsai Ming-liang] attore feticcio attore feticcio
Il nostro discorso potrà così procedere in maniera più spedita e lineare, senza doversi aggrappare ai singoli film.
Più che lo stile visivo, la pietra angolare (anche concettuale) del Cinema di Tsai è però l'attore feticcio, Lee, e anche questo rapporto regista-interprete è caratterizzato da eventi epifanici, due in particolare.
Il primo è totalmente casuale: nel 1991 Tsai, allora regista televisivo, è alla ricerca di un attore per un ruolo da bad boy.
Nessuno dei provinati lo convince, ma un giorno qualunque, uscendo da un cinema, vede Lee "accanto ad una sala giochi, […] seduto molto tranquillamente su una moto" mentre faceva da "vedetta per vedere se la polizia stesse arrivando o meno".
Il suo viso dai tratti "ordinari" e "il suo aspetto complessivo sono stati un fattore nella mia scelta", riferisce il regista, una scelta ispirata anche a Léaud.
Anche il viso dell'attore francese non presenta caratteristiche da "idolo del matinée", ma possiede una sorta di "magica affinità" cinematografica, rivelatasi a Tsai grazie alla scena conclusiva de I quattrocento colpi - film esplicitamente citato in Che ora è laggiù? - e materializzata nel suo volto, "un volto scelto dal film per vivere nella sua realtà" alla stregua di Lee.
A latere (ma forse non troppo), Tsai segnala anche come "la sua [di Lee, n.d.r.] delinquenza, la sua aria di mistero, la noia, il silenzio meditabondo e la lentezza […] il modo in cui fumava" gli abbiano ricordato il padre.
Più che l'interprete in sé, la seconda epifania riguarda poi la recitazione in senso stretto.
Entrato nei radar di Tsai, Lee - privo di qualsivoglia base tecnica - convince tutti ai provini e guadagna la parte.
Inaspettatamente, però, le riprese cominciano in modo disastroso: il semplice girare la testa che esauriva una breve scena "non era del tutto naturale", e il regista decide di rigirare circa una ventina di volta.
D'un tratto Lee, infastidito, esclama "ecco come sono naturalmente!" e sgretola di colpo le certezze di Tsai: "…mi ha fatto pensare che stavo proiettando troppe delle mie idee sulla […] performance", soffocando il suo "modo naturale di comportarsi".
Dunque "da quel momento, ho creduto che per raggiungere il massimo senso di naturalismo […] bisogna liberarsi di ogni traccia della recitazione professionale" e persino della "intera idea di performance".
Si estremizza in tal modo quella massima di Jean Renoir seguita anche da Truffaut, e proprio da questa estremizzazione scaturisce l'originale concezione del mezzo cinematografico di Tsai, analizzabile sotto vari, interrelati aspetti (alcuni già nominati).


[Lee/Hsiao-kang ne I ribelli del dio neon]
Il primo riguarda proprio la speculazione concettuale-filosofica: innanzitutto "la narrazione non ha importanza", assunto che tocca il parossismo in Days ("intenzionalmente privo di sottotitoli").
Il cardine è quindi rappresentato dall'attore feticcio, tanto che il regista, oltre a dichiarare di voler fare film solo con lui, definisce tutta la propria filmografia come "uno sviluppo del modo in cui guardo Lee".
E negli anni tali convinzioni si irrigidiscono: "…non si ha bisogno di uno script, ma […] nemmeno di un concetto" dice nel 2019, nonostante ammetta come sia impossibile (direct cinema?) abbandonare in toto la "struttura".
In ogni caso, è rinvenibile l'eco del Neorealismo italiano, di quel Cesare Zavattini secondo cui già allora il periodo era "maturo per buttare via i copioni e per pedinare gli uomini con la macchina da presa".
Certo, la cifra estetica globale di Tsai è talmente invasiva e ambigua (naturalismo/antinaturalismo) da allontanarlo non poco dalla concezione di pedinamento poi applicata da Vittorio De Sica, ma un comune principio di fondo, mediato, sussiste con chiarezza.
Questa mediazione - comunque non recepita in pieno - è proprio quella attuata dalla Nouvelle Vague, e prima ancora dai Cahiers du Cinéma, definiti addirittura "anti-zavattiniani" da Truffaut.
Nel 1977 il regista francese critica proprio la "concezione […] dell'utilità" sostenuta dallo sceneggiatore e teorico neorealista (per cui "bisogna fare dei film che siano utili all'uomo"), e non è un caso che Tsai espliciti il suo aderire a una diversa interpretazione di utilità.
"I film hanno un'utilità per l'uomo: rappresentano la realtà ma allo stesso tempo se ne distanziano.
Per questo per me fare un film non significa comprendere la società ma comprendere introspettivamente le individualità".
Tale impostazione, sommata alle molte coincidenze sul piano formale, avvicina il cineasta taiwanese anche a Michelangelo Antonioni, e ciò rende evidente come Tsai non sia certo un cineasta dallo stile derivativo, visto il parere di Truffaut - e di molti esponenti dei Cahiers - su Antonioni ("è l'unico regista importante su cui non ho nulla di buono da dire").


[Lee/Hsiao-kang in Che ora è laggiù?] attore feticcio
Emerge dunque uno stile autoriale sfaccettato, esplicitamente anticommerciale e, come vedremo in seguito, autoreferenziale.
All'origine di molti attributi citati è facile scorgere l'influenza, diretta o indiretta, di Lee, e il suo ruolo imprescindibile è poi correlato a due altri aspetti, la costruzione del personaggio e la realizzazione concreta dei film.
In merito al primo, il discorso non è semplice come sembra: non si assiste solo a un'espressione non-mediata della personalità di Lee, a una totale rimozione del concetto di personaggio.
Come nel caso Truffaut-Léaud, fanno capolino anche ontologia e autobiografia del regista, e lo stesso Tsai è esplicativo:
"…Lee interpreta un personaggio, non è sé stesso. Ma molte volte è la sua vita, il suo essere, che si riflette nei film.
…quando si è ammalato o quando ha lavorato come venditore […], ho incorporato elementi di questi eventi nel suo personaggio.
Questo in superficie.
Ma l'«interno» del personaggio […] riflette più me personalmente.
Ad esempio, attraverso Lee esprimo il mio orientamento sessuale, le mie ansie" e anche - ma raramente - vicende puramente autobiografiche, come la paura del buio conseguente alla morte del padre riproposta in Che ora è laggiù?.
Addirittura per Tsai "usare un personaggio che assomiglia e si comporta come mio padre è il […] modo per assicurarmi di fare film per me stesso", nel segno di un Cinema inteso come "scoperta del sé" che però si allontana dal metodo di Truffaut:
"…penso di aver spinto questo approccio ancor più lontano di Truffaut.
Mentre egli ha usato Léaud per ricreare importanti eventi nella prima metà della sua vita, io voglio solo osservare […] il volto di Hsiao-kang".


[Lee/Hsiao-kang in I don't want to sleep alone]
Non è tuttavia solo il viso, celebrato anche nel documentario Your Face, a interessare Tsai, visto che è proprio il corpo (di Lee) ad essere il cardine di un Cinema disadorno all'inverosimile, un corpo visto come "la cosa più bella e laica che possediamo".
À la David Cronenberg, la fisicità non è però nettamente separata dall'interiorità, come emerge ne Il fiume, in cui il lancinante e reale dolore al collo di Lee diventa il fulcro delle peripezie concrete ed esistenziali di Hsiao-kang.
Inoltre, nel tempo, Tsai è "passato dal voler controllare il suo corpo [di Lee, n.d.r.] al render[si] conto che non è qualcosa che può essere controllato", per quanto riguarda sia la salute che l'invecchiamento.
Proprio il cogliere il concreto passare del tempo in termini (non solo) materiali è il nesso che davvero unisce Tsai e l'ultimo Truffaut, il quale concepire L'amore fugge anche per "approfittare di aver filmato quello stesso ragazzo in diverse fasi della sua vita".
Ma lasciamo parlare Tsai:
"Voglio filmare Lee Kang-sheng per tutta la sua vita.
Questo è anche il motivo per cui ho insistito per avere Jean-Pierre Léaud nella pellicola [Visage, n.d.r.]".
Egli aveva quarant'anni "quando Truffaut morì e la gente smise di usarlo nei film. Ciò ha causato un buco nelle sue apparizioni sullo schermo…
...quindi volevo assicurarmi che le persone avessero l'opportunità di vedere anche il Jean-Pierre Léaud anziano", anche se purtroppo manca il progressivo "invecchiamento.
Sono convinto che Truffaut non abbia filmato Léaud perché pensava […] fosse il suo alter ego, ma perché sentiva l'intimo desiderio di documentare quest'uomo su pellicola.
Vederlo invecchiare, proprio come ho fatto con Lee Kang-sheng", e difatti "nemmeno Lee [...] è il mio alter ego".


[Tsai sul set con Jean-Pierre Léaud] attore feticcio
Giungiamo ora all'ultimo punto, la realizzazione concreta dei film, nell'ottica della collaborazione Tsai-Lee.
In primo luogo consideriamo il processo di scrittura: di norma Tsai realizza - non sempre in autonomia - delle sceneggiature piuttosto abbozzate, specie per quanto riguarda la seconda metà del film.
Si tratta di sceneggiatura mai intese "nel senso tradizionale", molto brevi e "come poesie", senza alcun dialogo per gli attori, tanto che sul set questi "non avevano mai uno script tra le mani e non ce l'avevo nemmeno io".
Gli interpreti, di norma non professionisti, sono infatti "allenati a essere sé stessi, a non cercare di recitare.
…cercano semplicemente, attraverso la propria esperienza di vita, […] di veicolare quella verità esperienziale…".
Così, senza fare alcuna prova o preparazione della scena, "è il loro ritmo a imporsi", e ciò è ulteriormente favorito dalla flessibilità garantita dalla leggerezza della troupe.
Tsai si pone così come semplice "osservatore", in attesa del "momento in cui essi si rivelino dinnanzi alla cinepresa".
Fornisce sì delle istruzioni di massima circa le azioni, ma aspetta poi che gli attori "abbiano dimenticato quei suggerimenti e che sfoderino una performance inattesa", semmai indirizzandoli un minimo gesticolando (e non parlando), pronto a cogliere "gesti quotidiani […] che non veicolano per forza, a priori, informazioni narrative".
Pronto a cogliere, in particolare, un nuovo stadio della vita psicofisica del suo attore feticcio, Lee Kang-sheng/Hsiao-kang, un novello Jean-Pierre Léaud/Antoine Doinel.


[Lee/Hsiao-kang in Days] attore feticcio attore feticcio
Il tema di questo articolo, come sempre scelto da voi tramite sondaggio nel gruppo Facebook Cinefactsers!, è uno strano mix delle proposte di Filippo Orzes, autumn_freedom_, Marco Sbicego e Andrea Parigi, che ringrazio tutti.
Ti è piaciuto questo articolo?
Sappi che hai appena visto il risultato di tanto impegno, profuso nel portarti contenuti verificati e approfonditi come meriti!
Se vuoi supportare il nostro lavoro perché non provi a far parte de Gli Amici di CineFacts.it?
Cinerama Out.
Chi lo ha scritto

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE
Lascia un commento

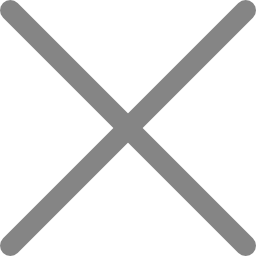
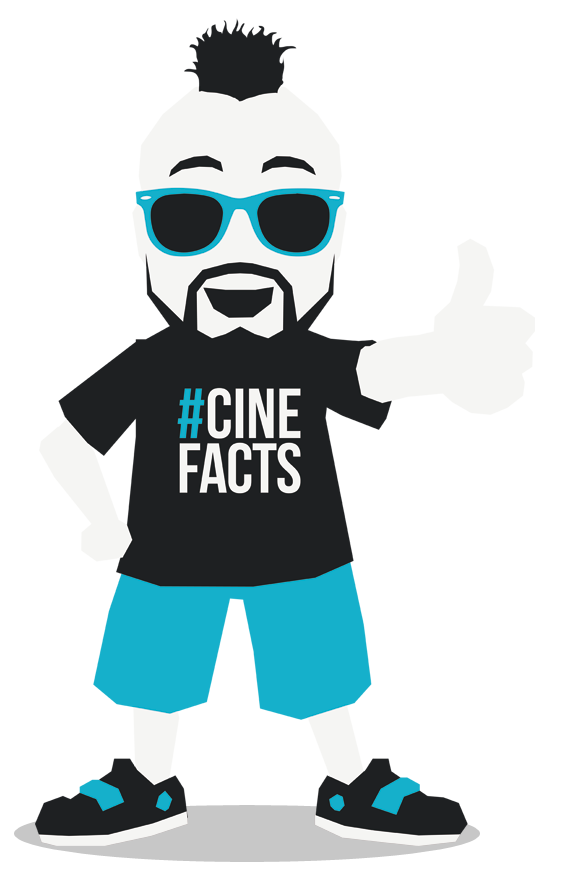

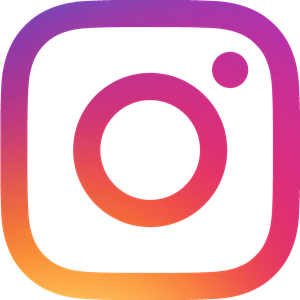




 :joy:
:joy: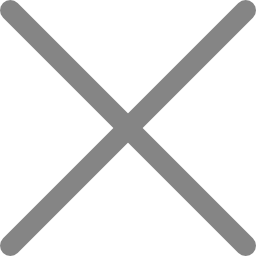
 Commentare gli articoli
Commentare gli articoli