
#articoli
Rashomon e la pluralità dei punti di vista: da Akira Kurosawa a David Fincher
Un excursus sul relativismo nel cinema a partire dall'effetto Rashomon
Riūnosuke Akutagawa e Luigi Pirandello, a pochi anni di distanza l’uno dall’altro, pubblicano rispettivamente il racconto Nel Bosco e Così è (se vi pare). Non è possibile stabilire un legame tra l’autore giapponese e l’italiano, ma possiamo sicuramente ipotizzare che il sottotesto scientifico e culturale non poteva portare ad altro che alla relatività degli eventi.
Sono gli anni della meccanica quantistica: gli eventi si influenzano l’uno con l’altro, analizzandone uno lo modifichiamo, i fatti vengono messi in discussione e si incomincia a parlare seriamente di probabilità e punti di vista.
Il mondo della scienza, dell’oggettività, è sottosopra e non può che essere seguito dall’ambiente filosofico, culturale.
Friedrich W. Nietzsche afferma contro il positivismo che non “ci sono soltanto i fatti”, ma che esistono solo interpretazioni. Akutagawa, come Pirandello, non poteva che lasciarsi permeare da tutte quelle suggestioni.
Raggomitolando il filo del discorso torniamo al fulcro: il Cinema.
[Il trailer di Rashomon]
La Settima Arte, che per sua natura è porosa ed assorbe stimoli da ogni parte, non poteva che subire questa fascinazione per la pluralità del punto di vista.
Il pensiero pirandelliano attecchisce in Giappone facilmente: in una società così rigida come quella nipponica indossare una maschera è assolutamente indispensabile per vivere serenamente, in modo tale da favorire la collettività sopprimendo l’individualità.
La maschera permette di reinventare se stessi, di conseguenza reinventare la verità che ci circonda.
Il cinema giapponese ci parla, quasi ci urla di questo problema, che pare non avere una risoluzione diversa dal suicidio o dalla follia, partendo da Una pagina matta di Kinugasa Teinosuke negli anni ’20 arrivando a Suicide Club di Sion Sono che risale a meno di vent’anni fa.
[Il trailer di Suicide Club]
Akira Kurosawa nel 1950 dirige in tal senso una pietra miliare del cinema classico giapponese, così potente da sbarcare al di là dei confini nazionali fino alla conquista del Leone D’Oro alla Mostra d'arte Cinematografica di Venezia, ispirandosi ad Akutagawa tramite una sorta di crossover tra due suoi racconti: il già citato Nel bosco e Rashomon, anche titolo del film.
"Nessuno dice la verità, non abbiamo il coraggio di dire le cose neanche a noi stessi"
L’opera è ambientata in un giorno piovoso nel quale un boscaiolo, un vagabondo e un bonzo si rifugiano sotto il portale di un tempio di Kyoto per discutere del processo per l’assassinio e lo stupro di un samurai e sua moglie, compiuto apparentemente dal noto assassino Tajomaru, interpretato da un Toshiro Mifune al massimo dello splendore.
Già le inquadrature dei titoli di testa aiutano lo spettatore ad introdursi nel contesto del film: travi, colonne, tetti cadenti, capitelli consumati della porta di Kyoto rappresentano letteralmente il portale che attraversiamo tra la realtà e il film e, vista in quest’ottica, la prospettiva non è affatto rassicurante.
Non è rassicurante come non lo è l’intera pellicola: i classici gialli, thriller o noir piacciono anche perché permettono di scommettere, con se stessi o con gli altri, sull’identità e sui moventi dell’assassino, ricostruire i pezzi in un puzzle più ampio.
Seppur molto diverso dal racconto Rashomon di Akutagawa, la porta che dà il titolo al film mantiene quell’aura oscura, quasi sovrannaturale e meschina del racconto da cui trae il nome.


Durante il processo vengono infatti fornite visioni prospettiche e discordanti ognuna delle quali si accorda agli interessi dell’imputato del momento: la prima è quella del bandito, seguita da quella della donna, la terza versione è data direttamente dallo spirito del samurai defunto, l’ultima è fornita da un boscaiolo che ha assistito al delitto.
Le varie deposizioni piuttosto che chiarire la faccenda la oscura ancor più, allontanando la verità.
Non ci sono elementi narrativi più importanti di altri e in questa luce è difficile fornire un’interpretazione logica del film che includa ognuno di questi elementi senza attuare preferenza.
Ogni tentativo di addomesticare interpretando questo film, per sua natura selvaggio ed indomabile come il personaggio di Mifune, risulta fallimentare e sempre lo risulterà.
Una delle particolarità registiche che salta facilmente all’occhio del capolavoro di Akira Kurosawa è che quasi mai viene utilizzata la soggettiva o la semisoggettiva, favorendo una versione rispetto l’altra, ma l’oggettiva, mostrando che ognuna delle prospettive è reale come può non esserlo.
I tre sospetti descrivono il partner come se fosse uno yokai piuttosto che un essere umano: Tajōmaru il bandito afferma che gli occhi di Masago sono gelidi, similmente Masago definisce algidi gli occhi del marito Takehiro ed infine a Takehiro pare che Masago sia in uno stato di trance.
Non c’è un controcampo o possibilità di risposta: Masago Takehiro e Tajomaru diventano la proiezione dei racconti degli altri.
La parola mente, l’immagine a sua volta mente tramite i falsi flashback.


I protagonisti però non si limitano a mentire, ma raccontano tante verità cinematograficamente possibili.
Un altro fuoco in cui converge il racconto è la volontà dei protagonisti di la colpa piuttosto che scagionarsi.
Il codice d’onore diviene dunque superiore alla legge, in conformità alla cultura della vergogna su cui si basa la civiltà nipponica: si esiste non in relazione al rapporto con se stessi quanto più in relazione a ciò che gli altri vedono di noi.
Ciò che è più vicino nella cultura occidentale a questo principio sono i poemi omerici e in generale la Grecia Antica, in cui viene più volte mostrato che la perdita dell’onore e della gloria corrisponde all’annullamento di sé.
Se con un volo pindarico invece pensiamo a Batman, un eroe dei nostri giorni, è chiaro a tutti che sono i suoi comportamenti a renderlo un eroe anche se in buona parte della storia è vissuto come un criminale.
I tre imputati, addossandosi la colpa, raggiungono il vertice nel loro ruolo: il samurai, il bandito e la donna cercano di vendersi al pubblico e alla giuria - che coincidono, dato che gli imputati guardano verso noi - il miglior samurai, il miglior bandito e la miglior donna.
Se con un altro volo pindarico giungiamo al nostro presente ci si può rendere conto di quanto Akira Kurosawa sia stato moderno.


Oggi più che mai infatti tramite i social network le persone tendono a vendere la versione potenziata, costruita, migliorata e raffinata di se stesse, i nostri profili sono una maschera ricca di dettagli, cosicché i rapporti virtuali diventano reali spesso più dei rapporti in carne e ossa e non è poi così banale definire chi si è davvero.
Lo speranzoso finale è sancito dalla nascita di una nuova vita: gli uomini sulla porta si prendono cura di un infante abbandonato tra verità e menzogne.
Il capolavoro giapponese è riuscito a conquistare il globo, tanto da spingere gli statunitensi a produrne remake su remake per rendere l’opera asiatica masticabile al pubblico americano.
La drammaturga Fay Kanin adattò Rashomon per Broadway e Sidney Lumet ne girò un film per la TV a dieci anni dall’uscita dell’originale; entrambi mantennero il titolo originale.
Martin Ritt nel 1964 girò L’oltraggio, un remake di Rashomon in salsa western, in cui Paul Newman interpreta il bandito nei panni di un messicano.
La suggestione americana nei riguardi di Rashomon e nella frantumazione del punto di vista non si limita allo scorso secolo: nel 2008 infatti c’è stato un nuovo tentativo di omaggiare la pellicola giapponese: Prospettive di un delitto, di Pete Travis.
[Il trailer di Prospettive di un delitto]
Il film cerca di far coincidere un taglio giornalistico, temi prettamente patriottici, un pasticcio action tra terroristi, complotti, inseguimenti automobilistici e la frammentazione prospettica della verità in otto diverse prospettive.
Seppur sulla carta può essere un esperimento interessante, inedito per un film puramente action, il risultato è corrotto e imbruttito dall’incapacità del film di separarsi dal concetto di giustizia puramente statunitense e, soprattutto, dal bisogno di definire una verità assoluta, ricombinando quei pezzi del puzzle.
La grandezza di un film universale come Rashomon è che non è addomesticabile e sfida la paura dell’ignoto.
Non è solo quindi mettere in discussione il giornalismo, la televisione, l’inquadratura cinematografica, la corruzione della legge, scaricando la colpa umana sul mezzo, ma Rashomon in modo unico spoglia la verità della sua stessa essenza mettendola alla mercé della percezione.
Ora voliamo fino al 2002, più in alto del vento, schivando le frecce, tra combattimenti danzanti, sul set di Hero di Zhang Yimou, fino a quel momento il più costoso film mai prodotto in Cina.
Dopo che La tigre e il dragone di Ang Lee spianò la strada nel mercato USA al wuxia, Zhang Yimou dirige un film più poetico ed elegante anche grazie al direttore della fotografia Chistopher Doyle, famoso per essere il collaboratore anche del regista di Hong Kong Wong Kar Wai.
Il film è basato sul tentativo di assassinio di Qin Shi Huang, primo Imperatore della Cina.
[Il trailer di Hero]
Zhang Yimou rielabora la più classica ambientazione dell’epos cinese tramite la sovrapposizione prospettica di piani temporali diversi.
Il principale è quello che vede il confronto tra il Re e lo Straniero.
Rievocando lo scontro con gli altri combattenti, i due ripercorrono diversi piani di verità tramite flashback.
Non solo è evidente il richiamo a Rashomon, ma è addirittura ufficiale.
Hero è un film che rimane inevitabilmente impresso; è iperrealistico, saturo di colori, con una particolare attenzione alla composizione dell’immagine: forme precise, piacevoli alla vista, si incastrano simmetricamente, la camera diventa tremolante solo quando si sintonizza con le turbe dei protagonisti e anche quando le inquadrature sono fisse non c’è mai un momento in cui non ci sia del movimento, che siano foglie e gocce di pioggia che cadono o vestiti che strusciano al ritmo del vento.


Il tutto è condito da un cast di attori formidabili, le star del cinema cinese ormai famose in tutto il mondo: Zhang Ziyi, Tony Leung, Maggie Cheung e Jet Li.
Una delle particolarità che ovviamente differenza Rashomon da Hero è l’utilizzo del colore.
Anche la fotografia non è esente dall’influenza di Akira Kurosawa, soprattutto per i colori saturi di Ran e Kagemusha.
Hero è costruito in modo tale che, variando l’angolo di visione, verrà trasmesso un colore piuttosto che un altro: rosso, bianco e blu per le storie e verde per i flashback.
I tre colori hanno ufficialmente una funzione puramente estetica, senza velleità simboliche per distinguere versioni e flashback, ma una delle particolarità della cinematografia del film è la presenza minima di contrasti.
Se in Rashomon i giochi di luce e ombre vengono sottolineati dall’uso di specchi in modo così netto da scatenare persino delle diatribe sulla loro interpretazione - come se potesse essere la chiave di volta per risolvere il mistero - Hero appiattisce questa possibilità lasciando che la bellezza dell’immagine e la grandezza degli eroi fatalmente vinca sulla dipendenza della verità.


Ben sappiamo che un pizzico di sale risalta il gusto del dolce, possiamo immaginare che uno spot luminoso risalti l’oscurità, l’assenza di contrasto è una delle peculiarità di questo film prismatico.
Da un punto di vista puramente contenutistico Hero vira rispetto Rashomon: i protagonisti sono eroi, a prescindere dalle verità e dalle menzogne e, come tali, sono depositari di valore di pace, coraggio, amore, empatia, onore e rispetto.
Sono dunque molto lontani dai personaggi meschini ed egoisti dell’epopea giapponese, in favore di una visione complessivamente pacifica della nascita della Cina.
I valori e la bellezza vincono anche sulla morte.
Mettiamoci comodi per fare un consistente salto temporale e geografico: siamo in Italia, a cavallo tra gli anni ’60 e gli anni ’70.
[Il trailer di Quante volte... quella notte]
Mario Bava, maestro del gotico italiano, riesce ad essere un precursore del tempi anche nel genere erotico, anticipando la commedia sexy con Quante volte.. quella notte o, forse, Four times.. that night, come suggerisce il titolo internazionale.
La storia tratta della notte d’amore tra Tina e Gianni raccontata, ancora una volta, tramite quattro punti di vista: ovviamente quello dei protagonisti, ma anche quello di un portinaio guardone e di uno psicanalista.
La verità, in tutti i casi, non si può conoscere.
Bisogna dimenticarsi degli eroi cinesi dagli importanti valori per tornare ad un’umanità provinciale.
Peccato che per chi scrive gli attori protagonisti, Daniela Giordano e Brett Halsey, paiono più modelli che altro, non convincendo mai nelle loro interpretazioni nonostante incantino nella loro bellezza.
Entrambi assumono, a seconda della prospettiva, il ruolo di preda e predatore, di santi e pervertiti, risultando sempre macchiettistici.


La colpa a mio avviso non è soltanto degli interpreti ma anche di una sceneggiatura zoppicante che non riesce mai a suggerire milioni di sfaccettature umane che si palesano tramite la sessualità.
Il guardone, il maniaco, la bigotta, la finta santa, la mangiatrice di uomini, l’omosessuale, gli amici al bar che si vantano delle loro conquiste e tutte le figure risultano stereotipati; in tal senso la scelta di inserire la figura dello psicanalista risulta poco convincente e non poco pretenziosa, considerando che il film è tutto sommato una commedia piacevole e originale.
Questo richiamo a Rashomon, per la frammentazione dei punti di vista ma anche per la tensione erotica, è palese persino paragonando la simile durata dei due film.
Esteticamente la pellicola rimane interessante tramite alcune trovate, come l’incipit animato e psichedelico, la fotografia di Antonio Rinaldi in cui risaltano il blu e il rosso accesi, l’atmosfera da horror fumettistico più che da film erotico, la scenografia degli interni squisitamente pop.


Ma oggi, nell’era del relativismo culturale, solo un’impostazione in stile Rashomon può raccontare la frammentazione del punto di vista?
Chiaramente la risposta non può essere affermativa.
Anzi, ripetere lo schema di Kurosawa potrebbe addirittura risultare ripetitivo o ridicolo, se non si è un artista del calibro di Zhang Yimou.
Persino a livello puramente tecnico esistono film che ci permettono di guardare da più occhi lo stesso avvenimento.
Basti pensare ad Elephant, capolavoro di Gus van Sant, in cui il regista osserva, in modo quasi documentaristico, la vita di alcuni comunissimi liceali, sia nella loro solitudine che durante gli approcci sociali, prima di una strage scolastica.
Il film non compie alcun giudizio morale sugli attentatori, sulla compravendita di armi negli Stati Uniti, sull’assenza dei genitori, sull’omosessualità latente dei due in contrasto con la virilità dei loro miti e su tutte le altre decine, se non centinaia, di possibili cause alternative, ma si limita a mostrarceli con la stessa freddezza con cui ci mostra tutti gli altri.
[Il trailer di Elephant]
La luce naturale agli esterni e le luci degli ambienti durante le riprese, oltre che il cast di attori non professionisti che passano la maggior parte del tempo a improvvisare, conferiscono ancor più neutralità alla quotidianità degli studenti fatta di ruoli e stereotipi che non è altro che lo specchio rimpicciolente della società degli adulti.
La macchina a mano, un utilizzo massiccio della steadicam, i pianisequenza e la, quasi, assenza di musica riescono a immobilizzare il film in quel preciso momento in cui si trattiene il respiro prima di un evento orribile che non ci si aspetta e che coglie di sorpresa, prolunga quell’attimo di apnea lasciando addosso una sensazione di asfissia.
È forse Elephant una sorta di filippica nei confronti della cultura statunitense?
Vuole forse mostrare il contesto in cui certi ragazzi sviluppano la mania genocida?
Forse, ancora, è un modo per sottolineare quanto la depressione giovanile sia sottovalutata e pericolosa?
La risposta può essere sì ad ognuna di queste domande e a tanti altri interrogativi che ci si può porre di fronte a questo film.
Questo infinito ventaglio di possibilità conferisce al freddo e quasi documentaristico film di Van Sant l’opportunità di essere annoverato come una pietra miliare della Storia del Cinema, oltre che una dolorosissima stoccata nel cuore e nel cervello di chiunque ne abbia affrontato la visione.
Ci sono decine e decine, sicuramente anche migliaia, di film di cui si può parlare ancora, ma per concludere ne ho scelto uno in particolare per sottolineare la partecipazione e l’importanza che hanno i media nella frammentazione, ma anche nella semplificazione e nel riallineamento dei punti di vista: Gone Girl di David Fincher.
[Il trailer di Gone Girl]
“Non mi conoscevo affatto, non avevo per me alcuna realtà mia propria, ero in uno stato come di illusione continua, quasi fluido, malleabile; mi conoscevano gli altri, ciascuno a suo modo, secondo la realtà che m'avevano data; cioé vedevano in me ciascuno un Moscarda che non ero io non essendo io propriamente nessuno per me: tanti Moscarda quanti essi erano.”
Luigi Pirandello, Uno nessuno e centomila
_________________________
Amy, interpretata dall’algida Rosamunde Pike, è nient’altro che un simulacro, il riflesso di aspirazioni e desideri altrui.
Per i genitori non è nient’altro che la proiezione della protagonista del loro libro per bambini, per suo marito Nick è la strafiga che sa essere oca e intelligente a comando, per la società semplice e un po’ retrograda del Missouri è la moglie dedita e un po’ trascurata, per il suo stalker non è altro che un uccellino spelacchiato e ferito da nascondere dagli sguardi indiscreti.
Ingabbiata da sempre, da stereotipi e aspirazioni altrui, Amy decide di ingabbiare a sua volta gli altri.
Attraverso una serie di sotterfuggi diabolici quanto geniali, Amy tesse una fitta tela in cui i personaggi vengono ricostruiti, decostituiti, decomposti e ricomposti in nuove forme, plasmate dall’opinione pubblica, catalizzate dall’azione dei media, soggetti a mutazioni repentine.
Al centro c’è suo marito Nick incarnato da Ben Affleck, uomo medio in tutto e per tutto, che pian piano riuscirà a districarsi dalla morsa di Amy, tessendo a sua volta la sua tela.
Entrambi evidentemente compiaciuti giocano ad una sfida all’ultimo talk show che non è altro che un’iperbole del rapporto matrimoniale, fatto di incastri, di dubbi, di ingerenze esterne di parenti e vicinato, di ruoli archetipici, di scaramucce piccole che si ingigantiscono pian piano in cui tutti hanno la colpa e nessuno ha la colpa.


Il matrimonio di Amy e Nick sul finale si rafforza intorno ai segreti in comune, seppure il collante è fatto di ricatti, l’odio è uno step in avanti rispetto all’indifferenza e la noia in cui il loro matrimonio placidamente stanziava ed è più solido rispetto alla gelatinosa consistenza dell’amore.
Possiamo tifare per Amy, che si riscatta per essere sempre stata schiacciata piuttosto che stimolata da chi le stava attorno, possiamo tifare per Nick, che rischia la pena di morte con l’unica colpa di essere stato un pessimo marito, possiamo tifare per entrambi o possiamo tifare per nessuno.
La giustizia assoluta è pappa per i media, l’accidia di Nick e il cinismo di Amy si scambiano e si incrociano, più si cerca di mettere a fuoco un punto di vista quanto più questo diventa sfocato.
Alla fine dei conti, seppur si riesce a ricostruire il filo logico della storia, le loro reali reazioni rimangono oscuri.
Giocando sulle loro identità televisive tanto definite quanto mutevoli Amy e Nick rimangono due persone affette da una irrimediabile dislessia dei sentimenti, incapaci di comunicare e comunicarsi, raccontarsi e migliorarsi se non tramite un mezzo esterno che riesca ad inquadrare le loro sensazioni.


Gone Girl è stato accusato di misoginia - oltre che contemporaneamente di misandria - dal Washington Post, per il personaggio cinico, impositivo e terrificante di Amy Dunne, sempre critica e a volte volgare nei riguardi delle altre donne, ma è anche stato considerato femminista da altre fonti come Forbes, per la protagonista ribelle, che non desidera più essere estensione di un uomo ma entità a sé stante, mostrando tante sfaccettature di una donna che non si limitino al solito binomio donna vittima o supereroina.
Addirittura per Vox è il film più femminista uscito negli ultimi anni.
La superficialità, la pigrizia, l’egoismo spropositato di Nick lo rendono un carnefice o rimane una vittima?
L’interpretazione di questo film dipende dagli occhi, la cultura, l’esperienza di chi lo sta guardando.
Persino la mia scelta di questo film e le parole che ho usato per descriverlo possono tradire la mia idea a riguardo.


Ci si può fidare dei nostri occhi o la nostra percezione sarà sempre offuscata, seppur inconsciamente, dall’interesse personale?
È poi così importante aggrapparsi al concetto di verità?
Quanto le nostre visioni influenzano quelle degli altri, in una sorta di infinito telefono senza fili?
Dove iniziamo noi e dove finisce l’immagine che vogliamo dare di noi stessi?
E come può qualcosa di così estremo accordarsi con il diritto? La visione parziale della verità di una persona finisce forse con la morte o influenza i vivi in qualche modo, continuando a riciclarsi ancora?
Esiste qualcuno che non mente?
E quanto anche la più piccola menzogna si ingigantisce con lo scorrere degli eventi?
È mai esistito un essere umano capace di compiere del bene totalmente altruistico senza pensare a se stesso?
Sarà mai possibile rispondere a queste domande?
Fortunatamente, finché esisteranno gli esseri umani, si avrà voglia di raccontare storie.
Storie inventate.
E finché ci saranno storie ci sarà anche il Cinema.
Sei stanco di clickbait, fake news e altre amenità? Passa da Cinefacts.it!
Se vuoi che le nostre battaglie diventino anche un po' tue, entra a far parte de Gli amici di CineFacts.it!
Chi lo ha scritto

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE
Lascia un commento

9 commenti
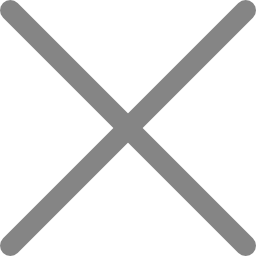
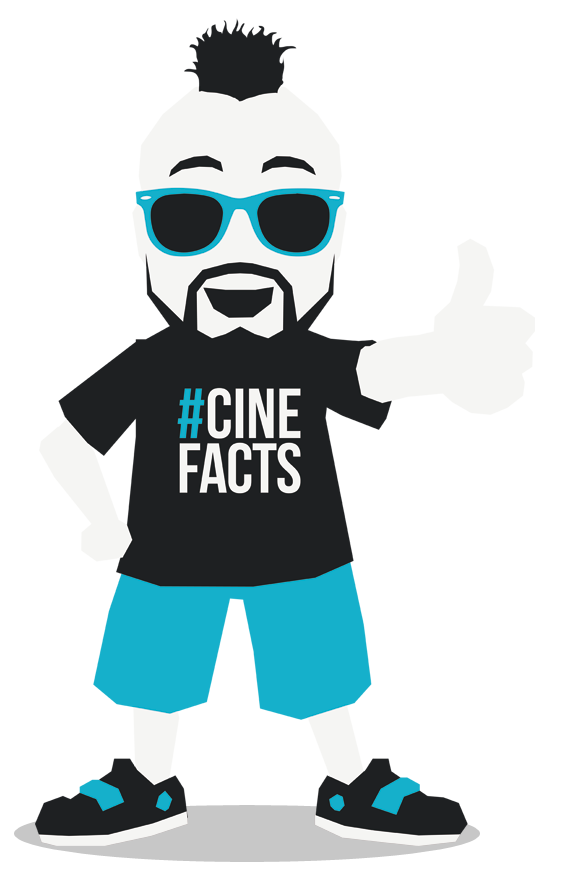

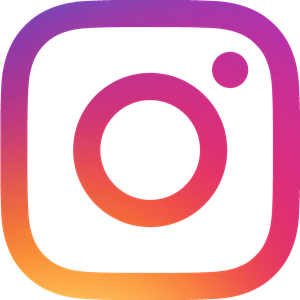





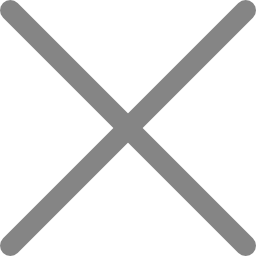
 Commentare gli articoli
Commentare gli articoli
Lorenza Guerra
6 anni fa
Rispondi
Segnala
Drugo
6 anni fa
Rispondi
Segnala
Davide Arienzo
6 anni fa
Adorati entrambi
Rispondi
Segnala
Drugo
6 anni fa
Rispondi
Segnala
Davide Arienzo
6 anni fa
Penso che Rashomon sia un capolavoro solo per la genialiatà di puntare la telecamera in maniera fissa verso gli imputati durante i processi. Davvero, è una delle più grandi genialate nella storia del cinema
Poi per il resto, come hai detto tu, la pluralità dei punti di vista è resa in maniera eccezionale da Kurosawa e il suo mi è piaciuto talmente tanto che proverò a tutti i costi ad infilarlo al cineforum che mi hanno chiesto di organizzare nella mia scuola (sperando che mi diano il permesso sigh)
Comunque non organizzare, è già entrato nella mia top dei preferiti :3
Rispondi
Segnala
Davide Arienzo
6 anni fa
Oggi provo a guardarmi Fahrenheit 451 di Truffaut e vedo se entro fine settimana riesco a guardarmi Rashomon
Rispondi
Segnala
Lorenza Guerra
6 anni fa
Rispondi
Segnala
Davide Sciacca
6 anni fa
In effetti è facile, visto che solo ad inizio film vediamo il lato traditore di Nick, considerarlo semplicemente una vittima, con due ore di escalation di accuse e incomprensioni nei suoi confronti. Non mi sono mai dimenticato del preambolo, pero' non mi sono mai spinto a chiedermi se fosse effettivamente colpa sua, dati tutti gli altri stimoli che costringono Amy dentro uno stereotipo.
Rispondi
Segnala
Lorenza Guerra
6 anni fa
In realtà la fisica e la chimica sono il mio campo di studi quindi è un collegamento che mi è venuto spontaneo!
Comunque in realtà l'idea di Nick mi è venuta ascoltando proprio un bel po' di persone che lo ritenevano innocente!
Rispondi
Segnala