
#articoli
Hirokazu Kore'eda - Monografia: scorci di memoria e mimesi del quotidiano
Una monografia parziale di uno dei più grandi registi giapponesi degli ultimi vent'anni
Il cinefilo è un divoratore di storie, un esploratore di mondi.
Implicitamente curioso, il cinefilo non si limita ad essere attratto da ciò che recepisce come più simile a sé e al proprio contesto di riferimento, ma sfrutta l’arte cinematografica per guardare a nuovi orizzonti, a terre lontane e scoprire che - strabuzzando gli occhi e andando oltre alle differenze dei costumi - i meccanismi del cuore e della mente non sono poi così diversi.
In questo frangente il nostro focus è in Estremo Oriente, per la precisione in Giappone, un Paese artisticamente prolifico dalla lunga, affascinante e diversificata tradizione cinematografica; in particolare parliamo di Hirokazu Kore’eda: uno dei Maestri del Cinema giapponese contemporaneo.
Approcciarsi al Cinema del regista di Tokyo vuol dire aprire delicatamente le porte scorrevoli delle case nelle periferie nipponiche, lasciarsi travolgere pian piano dalla resilienza dei protagonisti, dall’eroismo dei teneri atti d’amore e dall’acredine dei piccoli atti di meschineria.


[Hirokazu Kore'eda sul set di Little sister]
Nonostante la fama di Hirokazu Kore’eda sia arrivata al grande pubblico grazie a Father and son, vincitore del Premio della Giuria nel 2013 al Festival di Cannes, la sua carriera ha origine molti anni prima.
L’autore di Tokyo, classe 1962, dopo essersi laureato in letteratura all’università di Waseda - in un primo momento desiderava intraprendere una carriera da scrittore - inizia la sua esperienza con la cinepresa all’età di ventinove anni.
L’approdo al Cinema non è immediato: Kore’eda inizia a lavorare per la TV Man Union per cui dirige diversi documentari, di cui ne ricordiamo in particolare due, cioè Mou hitotsu no kyouiku - Ina shogakkou haru gumi no kiroku (1991) e Without memory (1996).
In Mou hitotsu no kyouiku - Ina shogakkou haru gumi no kiroku vengono riprese le vicende di una scuola elementare in cui viene avviato un programma sperimentale: i bambini infatti si prendono cura di una mucca e, attraverso il loro rapporto con l’animale, imparano la matematica, la biologia, ma soprattutto iniziano a interfacciarsi con il concetto di vita o di morte.
Questo documentario rappresenta il seme da cui poi è fiorito il Cinema di Hirokazu Kore’eda apprezzato e premiato in tutto il mondo: il lutto, l’unione e i bambini sono infatti i tre perni principali attorno a cui ruotano i suoi film.
La presenza di bambini nella filmografia del regista – di cui l’esempio più memorabile è Nessuno lo sa (2001) in cui una famiglia di bambini abbandonati viene ripresa la maggior parte del tempo – indica un duplice aspetto: il primo è quello più immediato quando si pensa a un qualsiasi artista, cioè la necessità di comunicare con il proprio bambino interiore per non lasciare affievolire il fuoco della curiosità e dell’incanto verso il mondo.
Il secondo, più caratterizzante nel Cinema di Hirokazu Kore’eda, è la possibilità di smascherare tramite l’intelligenza grezza e la debolezza intrinseca dei bambini le idiosincrasie e la meschinità della società giapponese e, più in generale, del mondo degli adulti.


[Un frame che ritrae i bambini di Nessuno lo sa di Hirokazu Kore'eda]
Per quanto una così massiccia presenza di minorenni possa sembrare rincuorante, il modo in cui viene messo in scena lo scontro generazionale assume delle sfumature di critica sociale tutt’altro che rassicuranti; i contrasti necessari alla crescita diventano anche metafora delle disparità sociali.
"Da piccolo mi dicevano che ero un bambino già adulto, più maturo rispetto alla mia età; magari invece non sono diventato completamente adulto proprio perché nella mia infanzia ero già un po' adulto, e quindi ora sono rimasto un po' bambino."
[Da un'intervista per Movieplayer]
In Without memory viene documentata la storia di una famiglia, in cui il padre soffre di una particolare forma di amnesia ed è incapace di incamerare ricordi successivi a un intervento chirurgico.
La memoria collettiva si va a sostituire a quella individuale grazie all’intervento di moglie e figli: ricordi e famiglia sono altre due parole chiave assolutamente necessarie per capire e amare la filmografia di Hirokazu Kore’eda.
Il documentario, uscito successivamente al suo esordio nel Cinema di fiction con Maborosi (1995), ha tenuto impegnato l’autore per ben due anni di riprese.


[Un frame da Maborosi, esordio al Cinema di fiction di Kore'eda]
La memoria è il materiale attraverso cui si cementificano i legami tra individui e attraverso cui si definisce un’identità individuale; senza la creazione di ricordi la quotidianità, ripetuta incessantemente giorno dopo giorno con piccole variazioni, è per Kore’eda priva di significato.
Non si tratta soltanto di una questione di interiorità, ma anche del rapporto con l’esterno: la nostra essenza giace anche tra i ricordi che gli altri hanno di noi.
L’ossessione nei riguardi della memoria ha anche un aggancio alla sua esperienza biografica: l’autore ha infatti sofferto molto durante la sua infanzia per l’Alzheimer del nonno.
Kore’eda non abbandona mai davvero l’approccio documentaristico: un utilizzo copioso della camera fissa e delle luci naturali, una regia posata che non cede mai a virtuosismi, una scrittura asciutta e mai ridondante, una fotografia mai davvero estetizzante, permettono allo spettatore di osservare i protagonisti delle sue storie da una prospettiva privilegiata ma mai invadente.
Viene naturale - proprio pensando al dramma familiare, all’utilizzo dei cosiddetti pillow shots e allo stile così asciutto - collegare l’autore a Yasujiro Ozu, uno dei registi più importanti della cosiddetta Golden Age del Cinema giapponese; d’altro canto l’autore ha più volte negato questo collegamento e, approfondendo la sua filmografia, non se ne possono negare le ragioni.


[Hirokazu Kore'eda ritira la Palma d'oro al Festival di Cannes 2018 per Un affare di famiglia]
Come Claude Monet dipingeva le scogliere dell’Etretat e le variazioni di luce e colori a seconda degli orari e delle stagioni, così Ozu metteva in scena le variazioni sul tema della famiglia tradizionale della middle class.
Kore’eda, proprio per la sua origine documentaristica, sfrutta il discorso sul microcosmo della famiglia per traslarlo al macrocosmo della società intera: in questo senso il regista ha dichiarato di sentirsi più affine al regista inglese Ken Loach e a un altro caposaldo del Cinema tradizionale giapponese Mikio Naruse.
Da entrambi ha ereditato una visione più nichilista della realtà: dal primo nel rapporto tra l'individuo e la società e dal secondo all'interno del nucleo familiare stesso, soprattutto per quanto riguarda le protagoniste femminili.
"Come individuo esprimo la mia posizione contro le politiche del governo, le modifiche alle leggi, la sicurezza e i diritti delle persone.
È pubblicamente noto e non ha nulla a che fare con i film.
Come regista non è che voglia fare un film su quell'opposizione, preferisco di più farlo su persone che commettono crimini o che si trovano in situazioni di povertà, persone che sono un inconveniente per il governo, che non vengono viste, persone che cerchiamo di nascondere."
[Da un'intervista su Un affare di famiglia per Little White Lies]
Kes (1969) di Loach e Floating clouds (1955) di Naruse sono infatti due dei suoi film preferiti in assoluto.
Tra i registi che hanno influenzato particolarmente il regista troviamo anche i taiwanesi Hou Hsiao-hsien e Edward Yang, in particolare nella stesura di Maborosi (1995), After Life (1998) e Distance (2000), le sue prime tre opere di finzione; tra i documentari di Kore’eda a riguardo è opportuno citare Eiga ga jidai wo utsusutoki - Hou Hsiao-hsien to Edward Yang (1993).
"Hou Hsiao Hsien ha avuto una grande influenza su di me. Avevo visto tutti i suoi film e mi erano piaciuti molto.
Ho incontrato Hou mentre faceva un programma televisivo nel 1993.
Stava girando The Puppet Master e rifletteva su cosa significasse essere taiwanesi. Affronta ancora le questioni di identità, cercando di capire da dove vengono i taiwanesi e quale sia la loro direzione.
Lo stesso vale anche per Edward Yang, a modo suo.
Quando stavo girando il documentario su Hou e Yang, li ho guardati e ho pensato: ci sono registi giapponesi che si occupano di rispondere a queste domande?
È stato questo il mio punto di partenza.
Se non avessi incontrato Hou nel 1993 probabilmente avrei continuato a fare film, ma non con le mie attuali preoccupazioni.
Dopo aver visto Maborosi Hou mi ha detto:
"Le riprese sono meravigliose. Tecnicamente è perfetto. Ma il Cinema riguarda il modo in cui riprendi il soggetto.
Non è qualcosa che decidi tu, come la composizione, in cui progetti tutto e poi inserisci semplicemente il soggetto. Il film viene dal soggetto stesso.
Hai fatto dei documentari, sai cosa significa".
La reazione di Hou è stata una delle ragioni per cui il mio modo di vedere è cambiato dopo Maborosi.
Ho ribaltato il mio punto di vista di 180° nel mio secondo lungometraggio, e di nuovo nel mio terzo.
Ora cerco di non selezionare uno stile per un film; decido strada facendo.
Ho in mente un piano e una destinazione, ma i progetti più interessanti sono quelli che sfuggono a ogni schema. Il lavoro che trovo più attraente è quello che devia dal suo punto di partenza.
Quando c'è una discrepanza, sento più coinvolgimento e il lavoro diventa più avvincente."
[Da un'intervista consultabile qui]
Per quanto concerne la trattazione della famiglia inoltre Kore’eda è figlio della sua epoca e, proprio per questa ragione e per la sua natura da osservatore, non può che mettere in discussione i tradizionali ruoli imposti tra le mura domestiche.
"La cosiddetta “famiglia ideale” è considerata oggi un concetto superato.
I valori familiari in Giappone si stanno aggiornando, ci stiamo avvicinando a una concezione più moderna della famiglia. Si lavora molto sulla formazione morale dell'individuo e della coppia, altrettanto per riconoscere alle donne un ruolo più attivo nella società.
Anche se ci sono ancora troppi uomini che vorrebbero costringere le donne a casa a crescere i figli, sono stati fatti molti passi avanti.
Se una donna vuole in Giappone oggi può anche conservare il "cognome da signorina"...
Qualcuno sostiene che le 'nuove famiglie' non prestino le cure necessarie ai propri figli ma io credo che si potrebbe dire la stessa cosa di quelle tradizionali.
Personalmente faccio film sulla famiglia per testarle, indagarle, fare il punto alla luce dei cambiamenti sociali."
[Da un'intervista a MyMovies]
Di seguito in questa monografia tratteremo i suoi film di fiction a partire da Maborosi (1995) fino al suo ultimo lavoro, la produzione franco-giapponese La verità (2019).
In attesa di Broker (2022), presentato al Festival di Cannes, avremo a che fare con un prolifico viaggio lungo quasi trent’anni, tra incursioni nel fantasy, nel legal drama e persino nel jideai-geki, nel mondo di un autore fatto di piccole cose, di legami e affetti, di assenze e presenze, nascite e lutti, intimità e socialità, mimesi e rivelazioni.
__________________
Maborosi
(幻の光 Maboroshi no hikari), 1995
scritto da Yoshihisa Ogita, Teru Miyamoto
direttore della fotografia: Masao Nakabori
genere: drammatico
Hirokazu Kore'eda esordisce con Maborosi - in giapponese il titolo è "Maborosi no hikari" che vuol dire "fantasma di luce" ma è traducibile anche come "fuoco fatuo" - nel 1995, premiato con l'Osella d'oro per la MiglregiRegia alla Mostra del Cinema di Venezia.
[Il trailer di Maborosi, di Hirokazu Kore'eda]
Yumiko e Ikuo - il celebre Tadanobu Asano in uno dei suoi primi ruoli importanti - formano una giovane coppia apparentemente felice e spensierata; l'idillio viene spezzato dal suicidio di Ikuo, i cui motivi non verranno mai alla luce e tormenteranno tanto lo spettatore quanto Yumiko.
La donna, interpretata dalla modella Makiko Esumi, tenterà di rifarsi una vita tramite un matrimonio combinato e il trasferimento in una piccola comunità di pescatori.
Il film è una sinfonia di silenzi, un delicato gioco di luci naturali in cui l'ambientazione è intrisa di romanticismo, nel senso artistico del termine: la periferia del Giappone accoglie Yumiko, i tempi dilatati della comunità marittima sanciscono il ritmo della sua esistenza, il mare è ampio, sereno in superficie ma misterioso e irrequieto negli abissi, esattamente come lo spirito ferito della protagonista, tormentata dai dubbi sul suicidio del primo marito.


[Tadanobu Asano e Makiko Esumi in Maborosi]
Il caos della natura nascosto tra le nuvole e il rilassante sciabordio delle onde pulsa al ritmo del cuore di Yumiko e nell'esordio di Kore'eda le immagini si sostituiscono quasi completamente ai dialoghi, asciutti ed essenziali.
Maborosi è un film contemplativo, in cui prevalgono la luce naturale, piani fissi, campi lunghi e lunghissimi, intriso di domande le cui risposte appartengono solamente al mondo dei morti. Il dolore più grande giace proprio nell'ineluttabilità del dubbio, nel mistero sospeso tra cielo, terra e mare.
I personaggi e la regia stessa paiono voler catturare l'ineffabile, l'inspiegabile, cogliere l'essenza di una spiritualità immanente che vibra a mezz'aria e si palesa nel vuoto di una stanza o nel suono di un campanellino.
Maborosi è un film ermetico, la cui trama è ridotta all'osso e riflette l'approccio meditativo alla morte, in particolare al suicidio, di un popolo diverso da quello occidentale con un modo diverso di elaborare il dolore e il lutto.
___________________
After life
(ワンダフルライフ Wandafuru raifu), 1998
scritto da Hirokazu Kore'eda
direttore della fotografia: Masayoshi Sukita, Yutaka Yamazaki
genere: drammatico, fantastico
Il secondo lungometraggio di Hirokazu Kore'eda è After Life del 1998, un compendio sulla memoria e sull'amore verso il mezzo cinematografico.
After Life è un lungometraggio in cui prevalgono - nuovamente - le inquadrature fisse, interpretato da un cast misto diviso tra attori professionisti e non, ambientato in un limbo laico dalle sembianze di una vecchia scuola di mattoni invasa dall’edera e popolato da angeli vestiti da impiegati dietro cui non c’è un’elezione divina ma una scelta sofferta.
Il film ci offre anche un’arguta dichiarazione d’amore al Cinema e alle sue potenzialità.
[Il trailer di After life di Hirokazu Kore'eda]
Un campanellino annuncia l’arrivo degli ospiti appena defunti che appaiono in mezzo a una nebbia sottile.
Hanno ancora addosso tutti i loro beni personali e i loro abiti, non palesando il proprio stato di fantasmi.
Gli impiegati li informano del decesso, li aiutano a ripercorrere la loro esistenza e scegliere un solo ricordo. La scelta permetterà all’ospite di passare oltre in uno stadio successivo della vita ultraterrena scevro di qualsivoglia connotazione religiosa dove l’unica attività sarà rivivere per sempre il ricordo in questione.
La scelta è di fondamentale importanza e gli ospiti della struttura hanno solo una settimana per decidere il momento ideale, il più significativo, il più importante da portare con sé per l'eternità.
Il compito dei dipendenti/angeli è duplice: da un lato devono aiutare gli ospiti nel ripercorrere la propria vita organizzando delle vere e proprie interviste - come in documentario, genere molto caro alla carriera di Kore'eda - e a carpire più dettagli possibili dalla memoria, dall’altro devono utilizzare questi dettagli per organizzare un vero e proprio set per mettere in scena il ricordo.
[Una delle interviste nell'aldilà]
Assistiamo ad un vero e proprio making of di questi corti dal gusto artigianale tra nuvole in cotone e brezza del ventilatore.
Il passaggio allo stadio successivo è sancito dalla visione del cortometraggio ed è proprio nella sala che si è destinati a scomparire e ad accedere a un altro stadio della vita eterna.
Nonostante i dipendenti abbiano accesso a videocassette infinite che rappresentano la vita dei defunti, l’utilizzo del mezzo filmico è necessario perché solo tramite il Cinema ci si può evolvere.
La riproposizione della memoria diventa più reale della memoria stessa, rivivere una sensazione è possibile, ma soltanto riproducendone ogni dettaglio. La vita è tridimensionale e il Cinema ne ricalca gli eventi come se fosse carta copiativa.
Il Cinema di Kore'eda, soprattutto in questa trilogia del lutto, è proprio un continuo ricalcare la vita, alla ricerca dei non detti, una fotografia particolareggiata di assenze invisibili, ma soffocanti, indelebili, impositive e di memorie sottili, impalpabili, insignificanti e leggere che però diventano straordinarie nella dimensione della normalità.
La scelta dei ricordi, frutto dell’improvvisazione degli attori, è varia e parla principalmente d’amore: amore per la natura, amore per un fratello, amore non corrisposto, amore impossibile, amore non vissuto al pieno delle proprie possibilità o, semplicemente, amore per la vita.


[Due dei protagonisti nella sala cinematografica destinata alla proiezione dei ricordi dei defunti]
L’esistenza è effimera e ogni momento è potenzialmente sprecato, si può solo andare avanti e cercare di cogliere la grandezza nella piccolezza della quotidianità.
Il legame è ciò che più è importante perché non si scinde neanche con la morte.
Ce lo ricorda uno dei dipendenti: il trasognante e misterioso protagonista Takashi Mochizuki, interpretato da un malinconico Arata Iura: non esiste felicità se non si rende felice qualcun altro.
Non esiste felicità nella solitudine, ma solo nella condivisione.
After life è la prima opera che sancisce il sodalizio tra Kore'eda e Arata Iura, l'attore infatti sarà anche nel cast di Distance e Air Doll.
Il finale del film è immerso nella prima neve d’inverno. Una neve purificatrice sancisce l’avanzare del tempo e delle stagioni, di nuovi ospiti, nuovi amori, nuovi dipendenti, nuove connessioni.
La neve è il sipario che cala su questo silenzioso limbo meta-cinematografico e si porta dietro le palpitazioni e i sospiri di una inevitabile malinconia.
________________
Distance
(ディスタンス Disutansu), 2001
scritto da Hirokazu Kore'eda
direttore della fotografia: Yutaka Yamasaki
genere: drammatico
La storia narrata in Distance, in concorso al Festival di Cannes 2001, è ispirata a un fatto realmente accaduto: l’attentato con il gas sarin alla metropolitana di Tokyo perpetrato dagli adepti di Aum Shirinkyo, una setta religiosa estremista con una visione nichilista del presente e apocalittica del futuro.
Gli atti di violenza di cui si è macchiata la setta hanno avuto un forte impatto nella cultura pop giapponese, basti pensare alla setta in Love exposure (2008) di Sion Sono o all'anime Neon Genesis Evangelion (1995) di Hideaki Anno.
La trama di Distance ruota attorno ai familiari degli attentatori che ogni anno si recano sulle rive di un lago in mezzo al bosco per commemorare il giorno del suicidio rituale dei loro cari.
Il lutto, la memoria, la natura: ancora una volta, come nei due film precedenti, sono queste le tre colonne portanti su cui il film si sviluppa.
[Il trailer di Distance di Hirokazu Kore'eda]
Ci sono l'impiegato Minoru, Atsushi che vende fiori e nasconde più di un segreto, l'estroverso insegnante di nuoto Masaru, l'insegnante Kyoka e Sakata - vediamo nuovamente il giovane Tadanobu Asano - che è l'unico superstite della setta; a seguito della giornata trascorsa insieme scoprono che l'auto con cui erano arrivati nel luogo designato è stata rubata.
Ad accoglierli per la notte è proprio la vecchia sede del culto.
Il bosco, che da sempre rappresenta un archetipo nel panorama horror, in Distance si pone come traslazione dei moti interiori dei protagonisti, dei misteri che li avvolgono e dell'oscura patina di disagio intorno alle scelte, a volte inspiegabili, che hanno spinto i familiari dei protagonisti ad approcciarsi alla setta.
In Distance, a differenza dei lungometraggi precedenti, Kore'eda si spinge in un'analisi della società che sarà poi essenziale con il proseguire della sua filmografia.
Tramite una serie di flashback sulle vite degli adepti che si inseriscono nella narrazione l'autore ci spinge a interrogarci sull'arché di quel sentimento di ribellione nei confronti delle rigide imposizioni della società, sulla ricerca di spiritualità - seppur in una declinazione distruttiva e intrinsecamente errata - in un mondo sempre più materialista, sulla mancanza di fiducia verso lo status quo e sul rapporto tra vittime e carnefici, la cui narrazione dei media è fin troppo spesso polarizzata e ridotta alla morbosità della cronaca nera.


[Distance è immerso in un'atmosfera a metà tra l'horror e la malinconia]
Ancora una volta osserviamo la mano del documentarista: piani fissi, l'utilizzo della macchina a mano, lunghi piani sequenza, riprese frontali caraterizzano la cifra stilistica di Kore'eda, soprattutto nelle sue prime opere.
Come in Maborosi alcuni elementi, seppur naturali, hanno una forte valenza simbolica e rivelano una grande sensibilità poetica: i gigli, la nebbia, il pontile bruciato non fanno che contribuire al fascino di Distance e al mistero che circonda la morte e le relazioni che intercorrono tra gli esseri umani.
_______________________
Nessuno lo sa
(誰も知らない, Dare mo Shiranai), 2004
scritto da Hirokazu Kore'eda
direttore della fotografia: Yutaka Yamasaki
genere: drammatico
Il Cinema di Hirokazu Kore'eda sa essere cruento e terribile.
Oltre la poesia delle piccole cose e l'ineffabilità della natura e del senso della vita, oltre le dinamiche familiari che gli sono valse il titolo prestigioso ma non sempre corretto di erede di Yasujiro Ozu da parte del pubblico internazionale, ci sono delle pennellate violente che ritraggono le storture della società nipponica - e non solo - e la volontà di squarciare, seppur senza exploit emotivi e con grazia formale, il cuore dello spettatore, stimolandone il senso critico.
Probabilmente uno degli esempi più diretti del nichilismo e della potenza del Cinema di Kore'eda nella sua declinazione più critica è proprio Nessuno lo sa.
Similmente a quello che è accaduto anni prima con Una tomba per le lucciole di Isao Takahata, film animato prodotto dallo Studio Ghibli, nel film dell'autore di Tokyo i protagonisti sono bambini, invisibili alla società, totalmente dimenticati dagli adulti e destinati a venir privati della spensieratezza e dell'innocenza.
[Il trailer di Nessuno lo sa di Hirokazu Kore'eda]
I piccoli, privi di potere contrattuale ed economico, sono il mezzo più potente per raccontare delle disuguaglianze nella società; sceglierli come protagonisti rende la critica inequivocabile, senza che possa essere soggetta a disquisizioni etiche e filosofiche.
Ispirandosi a un fatto di cronaca vera Kore'eda racconta la storia di quattro bambini abbandonati da una madre egocentrica, che li lascia in un appartamento con una manciata di yen per scappare con il nuovo compagno e rifarsi una vita.
A guidare i ragazzini sarà il fratello più grande, il dodicenne Akira; per questo ruolo il quattordicenne Yûya Yagira è stato il più giovane vincitore del Premio per la Migliore Interpretazione Maschile al Festival di Cannes.
Sono proprio gli occhi di Akira quelli attraverso cui osserviamo la vita di questa famiglia priva di una vera e propria figura di riferimento; è un ragazzino che sogna una vita normale ma che teme un'ulteriore frammentazione del nucleo familiare, che anela a una fuga, responsabilizzato troppo presto ma che non riesce a gestire una situazione troppo grande per lui.
È taciturno e serioso, ma è ben chiaro il tumulto interiore che arde nel suo cuore, tra preoccupazioni e desideri.
Il lungometraggio è scandito dalle stagioni, tant'è che vediamo crescere i bambini persino fisicamente e percepiamo il cambiamento di voce dello stesso Akira.


[Hirokazu Kore'eda con il cast di Nessuno lo sa al Festival di Cannes]
Il nido familiare diventa sempre più caotico, sporco e disordinato con l'ingigantirsi dei problemi dei quattro bambini abbandonati, fino al finale dove ancora una volta la morte farà capolino nella vita sfortunata dei protagonisti.
Nessuno lo sa è il primo approccio di Kore'eda ad attori bambini e il risultato è emblematico della sua bravura a interagire con i più piccoli; il film infatti è improvvisato, l'autore si è limitato a dare dei suggerimenti ai giovani interpreti.
_________________________
Hana
(花よりもなほ, Hana yori mo Naho), 2006
scritto da Hirokazu Kore'eda,
direttore della fotografia: Yutaka Yamasaki
genere: commedia, drammatico
Uno dei generi per cui il Cinema nipponico è maggiormente riconosciuto a livello internazionale è il jideai-geki, cioè il dramma storico; con il termine si fa riferimento principalmente ai film che narrano vicende ambientate prima della fine dell'epoca Tokugawa, cioè nel 1968, e spesso è accostato al Chambara, il filone di cappa e spada giapponese.
Anche i meno avvezzi alla cultura del Sol Levante hanno avuto modo di interfacciarsi almeno una volta alle storie di samurai e ronin.
Il samurai è la personificazione dell'onore, dell'onestà, della lealtà e della giustizia, così come prevede il cosiddetto codice Bushido.
[Una clip da Hana di Hirokazu Kore'eda]
I grandi autori del Cinema giapponese sono stati capaci di esaltare ma anche di ribaltare questo aspetto.
Dai bislacchi combattenti de I sette samurai (1954) di Akira Kurosawa ai lascivi samurai sessualmente repressi di Gohatto (1999) di Nagisa Oshima, passando per la potente e lucidissima critica all'ipocrisia di Harakiri (1962) di Masaki Kobayashi, sono moltissimi i possibili esempi elencabili di decostruzione, esaltazione, rielaborazione, (de)mitizzazione del concetto di eroe e meriterebbero un approfondimento a se stante.
Hirokazu Kore'eda - come abbiamo già potuto evincere nel corso della prima parte di questa monografia - nella sua carriera si è rifatto principalmente ai shoming-geki, un genere che racconta le vicende quotidiane della classe medio-bassa; con Hana decide invece di fare una breve incursione nel jideai-geki.
Hana chiaramente rientra in quel filone di film che mira a sovvertire il genere a cui appartiene, è una commedia corale e colorata il cui protagonista è un samurai tutt'altro che furbo e abile con la spada.
Siamo all'inizio del XVIII secolo e il giovane samurai Soza, interpretato dall'attore ed ex pop star Jun'ichi Okada, trova rifugio nel villaggio di Edo - che un giorno diventerà Tokyo - mentre cerca di vendicare la morte del padre a cui non era legato con un forte legame.


[Una scena da Hana. Nel film ci sono altre due superstar dello star system giapponese: nuovamente Tadanobu Asano e Jun Kunimura]
Allergico ai combattimenti ed estraneo a un vero concetto di eroismo tramite vendetta, Soza finisce per affezionarsi alla comunità in cui è stato accolto, in particolare alla vedova Osae - intepretata da Rie Miyazawa - e al figlio di sette anni.
In questa dinamica possiamo sicuramente vedere uno dei cardini del concetto di famiglia per Kore'eda, le cui fondamenta non sono da cercare nei legami di sangue, ma negli affetti.
Non è questo il film a cui si pensa quando ci si riferisce a questo aspetto del Cinema del regista di Tokyo; d'altra parte questo principio che avrà il suo definitivo picco in film come Father and son (2011) e Un affare di famiglia (2018) ha una sua radice anche in questo esperimento di generi.
Hana è un film dai toni scanzonati tanto che i personaggi agiscono spesso e volentieri in modo caricaturale, ha un ritmo più serrato e un approccio più mainstream - complice anche un budget decisamente più elevato - rispetto ai lungometraggi precedenti, ma funziona maggiormente lì dove Kore'eda decide di rientrare nella sua comfort zone seppur addobbandola da dramma storico.
____________________
Still walking
(歩いても 歩いても, Aruitemo aruitemo), 2008
scritto da Hirokazu Kore'eda
direttore della fotografia: Yutaka Yamasaki
genere: drammatico
In Giappone una volta l'anno le famiglie si riuniscono per celebrare un defunto, commemorare il passato e disquisire sul presente.
In Still Walking - in giapponese "Aruitemo aruitemo", frase di un brano cantato dalla madre all'incirca a metà del film - una famiglia si riunisce a Yokohama in un giorno d'estate per commemorare la morte di Junpei, il figlio maggiore nonché palesemente il preferito dai genitori, scomparso dodici anni prima per salvare un amico che stava annegando in mare.
La famiglia è composta da un burbero e misantropo medico in pensione, una madre casalinga che non si risparmia mai le frecciatine velenose e due figli sposati: Ryota con una vedova che ha avuto un bambino nel precedente matrimonio e Chinami con un venditore di auto con cui ha avuto due figli.
All'incontro viene invitato anche il superstite all'incidente con il lapalissiano e meschino intento di farlo sentire in colpa.
[Il trailer di Still walking di Hirokazu Kore'eda]
Dopo l'incursione nel jideai-geki di Hana Kore'eda torna a esaminare l'istituzione della famiglia con la lente d'ingrandimento.
Se in Nessuno lo sa si presagisce la tragedia fin da subito intuendo l'egoismo della madre, in Still Walking assistiamo a uno stillicidio non privo di ironia e a una famiglia moderna logorata da uno scontro generazionale sussurrato, implicito, che aleggia soffocante tra i silenzi e i dialoghi solo apparentemente banali.
Nonostante la perfidia, le idiosincrasie, le comparazioni tra i figli, le convenzioni sociali sofferte, l'opportunismo e le incompresioni Still Walking non manca di barlumi luminosi di serenità e di affetto: fondamentali in tal senso le due passeggiate, quella verso la tomba di Junpei, in cui la famiglia di Ryota accompagna la madre, e quella del giorno seguente in cui Ryota e il bambino arrivano fino al mare insieme al padre.


[Una scena ripresa dal basso in Still Walking, uno scorcio della famiglia che ricorda le inquadrature tipiche di Yasujiro Ozu]
Kore'eda non è mai strettamente giudicante e, pur mettendo in discussione alcuni fondamenti e paradossi della famiglia tradizionale giapponese, non ha in progetto di detonare il nucleo ma di analizzare i rapporti tra consanguinei, le molteplici variabili che lo contraddistinguono in un sistema di equazioni dai numeri evanescenti.
Ryota è intepretato da Hiroshi Abe, che lavorerà con Kore'eda anche in I Wish e Ritratto di famiglia con tempesta.
____________________
Air Doll
(空気人形, Kūki Ningyō), 2009
scritto da Hirokazu Kore'eda (sceneggiatura), Yoshiie Gōda (manga originale)
direttore della fotografia: Ping Bin Lee
genere: drammatico, fantastico, romantico
Anti-erotico, horror, romantico, violento, sociale, grottesco: Kore'eda confeziona una favola per adulti in cui la dolcezza di un impacchettamento sognante nasconde un cuore di torbida vuotezza.
Air Doll, tratto dalla serie di manga Kuuki Ningyo di Yoshiie Gōda, rielabora un archetipo dalle radici antiche che rivela la paura e il fascino dell'essere umano nei confronti delle proprie stesse creazioni e lo adatta alla modernità, in particolare di un Paese come il Giappone dove il mercato dei fetish e dei sex toys è molto attivo: il risveglio e la presa di coscienza di una bambola gonfiabile.
L’umanità è la regina incontrastata del film, la sua mancanza è annichilimento, senza umanità il nostro corpo non è altro che sangue e budella, “rifiuto riciclabile”.
L’umanità non è intrinseca allo stato di persona, ma può sfuggire, rimanere impantanata nel passato tra le perdite e i dolori a cui non si vuol rispondere.
A ricordarcelo è Nozomi - interpretata da Bae Doo-na, nota per aver preso parte a Mr. Vendetta, Cloud Atlas e la serie TV Sense8 - bambola gonfiabile economica, che presto prenderà inspiegabilmente vita.
[Il trailer di Air Doll di Hirokazu Kore'eda]
Una goccia penzolante risalente alla precedente notte piovosa scivolerà sulla sua mano, le prime parole che pronuncerà saranno “bel-lis-si-mo”.
L’acqua feconda la terra, l’acqua sostiene il corpo umano, l’acqua è matrice del mondo, sorgente primordiale di cui si nutre la vita stessa.
Nozomi, tanto incantata dalle particolarità del mondo quanto lei stessa incantevole anomalia di giorno, cerca di afferrare quanto più possibile ogni pulsazione del mondo tramite vista, tatto, olfatto, mentre la notte non si sottrae dal suo compito di oggetto.
Il meccanico atto sessuale è scandito dal cacofonico stridio delle giunture plastiche e si conclude con una meticolosa pulizia della vagina artificiale.
La bambola gonfiabile risvegliata troverà un impiego da commessa presso una videoteca e saranno proprio i film ad aiutarla ad approcciarsi alla vita.
Diversi saranno i titoli citati, più o meno famosi, di tutte le epoche, alcuni nominati esplicitamente ed altri evocati in secondo piano.


[Una scena di Air Doll]
Attorno alla curiosa Nozomi orbitano diversi personaggi: un'accumulatrice compulsiva che vive tra i rifiuti, un hikikomori capace solo di relazionarsi con donne virtuali, un vecchio solo, saggio e malato, una donna interessata alla cronaca nera che si reca alle stazioni di polizia per non essere sola.
Lo stesso Hideo, legittimo proprietario della nostra bambola gonfiabile, è incapace di un approccio naturale con l’altro sesso.
Se da un lato la protagonista commuove con i suoi discorsi sulla vita in cui tutti sono indispensabili gli uni con gli altri, come le api che impollinano i fiori, supportata da una fotografia sempre luminosa, dall’altro il quadro generale che Koreeda ci offre è desolante, alienato e, soprattutto, vuoto.
Pare saperlo anche il costruttore di bambole gonfiabili, un moderno Geppetto che non si vanta delle sue creazioni divine, ma si mantiene in disparte in atteggiamento colpevole, come un dio che non riesce più a fare i conti con le conseguenze del libero arbitrio.
È proprio la vuotezza, fisica e spirituale, l’essenza del film, la vuotezza che non può essere riempita dal riverbero di un amore superficiale, sostitutivo, ombra del passato.
Non è il legame debole di un amore a poter rovesciare i rapporti di forza in cui l’uomo sarà in qualche modo sempre aggressivo nei confronti di chi è più debole, che sia un’altra persona o un oggetto, oppure chi come Nozomi è entrambe le cose.
____________________
I Wish
(奇跡, Kiseki), 2011
scritto da Hirokazu Kore'eda
direttore della fotografia: Yutaka Yamasaki
genere: drammatico
In seguito alla separazione dei genitori, due fratellini, Koichi e Ryunosuke, si trovano costretti a vivere separati.
Koichi, il più grande e più riflessivo tra i due, affidato alla madre e ai nonni, continua a tormentarsi sull’insensatezza di tale condizione - riflessa nell’assurdità di vivere accanto a un vulcano che continua a spargere di cenere la sua esistenza - e vive nella speranza di poter riunire la propria famiglia.
Ryunosuke, invece, di una vivacità disarmante, sembra aver accettato con più facilità la scelta dei genitori, riflettendo lo stile di vita spensierato del padre, con cui vive.
Un giorno Koichi scopre che, se si assiste al momento esatto in cui due treni ad alta velocità si incontrano in una determinata stazione, avverrà un miracolo - il Kiseki del titolo originale - e i propri desideri diventeranno realtà.
Decide quindi di coinvolgere gli amici e il fratellino in un’avventura che, in qualche modo, farà maturare ognuno di loro.
[Il trailer di I Wish di Hirokazu Kore'eda]
Kore’eda approfitta dell’incarico da parte della rete ferroviaria giapponese Shinkansen di sponsorizzare la costruzione di una linea ad alta velocità per porre di nuovo l’attenzione sui bambini, ma questa volta con uno sguardo decisamente più ottimista e leggero rispetto a quello di Nessuno lo sa.
Tuttavia, nonostante la dolcezza e la comicità innata dei due piccoli protagonisti, interpretati dai fratelli nella vita reale nonché duo comico Maeda, con I Wish il regista ci fa nuovamente riflettere sul ruolo degli adulti e dei bambini che, spesso, sembra quasi invertirsi.
Basti pensare al padre dei fratellini, un musicista che conduce una vita sregolata e che ha bisogno del figlio per ricordarsi di alzarsi la mattina e andare a lavoro; o alla madre, appena trentenne in cerca di un impiego, ancora confusa su cosa fare della propria vita.
È chiaro che si tratti di giovani diventati genitori troppo in fretta, prima di volerlo davvero o di sentirsi pronti, e per questo non completamente condannabili anche se, ancora una volta, sono i figli a dover pagare le conseguenze dell’irresponsabilità e della fallibilità di chi li ha messi al mondo.
Lo stesso vale anche per gli amici di Koichi e Ryunosuke, ognuno con un desiderio da esprimere e con un complesso da esorcizzare.


[I piccoli protagonisti di I Wish]
In I Wish - una tenera storia di formazione, con una componente d’avventura sullo sfondo del dramma della separazione - Hirokazu Kore’eda riesce, come lui solo sa fare, a conferire importanza a ogni dettaglio della vita quotidiana dei due bambini, deliziosa nella sua consuetudine e resa ancora più autentica dalla decisione di non dare un vero script ai due fratellini e di puntare sulla loro improvvisazione.
Il tono leggero, qui, ben si sposa con la facilità in cui i bambini riescono a semplificare anche la situazione più complessa, ricordando agli adulti disillusi che spesso, nella vita, non conta tanto realizzare i propri desideri, quanto l’entusiasmo impiegato nel provarci.
____________________
Father and son
(そして父になる Soshite Chichi ni Naru), 2013
scritto da Hirokazu Kore'eda
direttore della fotografia: Mikiya Takimoto
genere: drammatico
Father and Son muove i passi a partire da uno degli intrecci narrativi più utilizzati della storia: lo scambio di due bambini nella culla e le rispettive conseguenze che la rivelazione ha sulle vite delle famiglie coinvolte.
Ryota (Masaharu Fukuyama) è un architetto di successo, malato di lavoro, assente per la famiglia e frustrato dall’incapacità di trasmettere le proprie qualità al figlio Keita, troppo “mite” per seguire le facoltose orme del padre.
L’uomo non perde occasione per sottolineare che quello specifico tratto caratteriale sia ereditato dalla madre, come se la gentilezza fosse un difetto invalidante.
Quando, insieme alla moglie Midori (Machiko Ono), viene informato dall’ospedale circa lo scambio, l’incredulità e la disperazione lasciano presto il posto al sollievo: “ora si spiega tutto”.
Keita, infatti, proviene da una famiglia agli antipodi rispetto a quella di Ryota: modesta, spesso approfittatrice ma di sicuro più accogliente e affettuosa nei confronti dei bambini.
[Il trailer di Father and son di Hirokazu Kore'eda, Premio della Giuria al Festival di Cannes]
Pur rischiando di scadere in una dualità piuttosto stereotipata, Kore’eda si avvale del contrasto tra le due famiglie per riflettere su un altro degli aspetti ricorrenti del suo Cinema, ovvero le differenze sociali che sembrano affliggere ancora oggi la sua nazione.
Nel Giappone feudale il mercante - lavoro esercitato dall’altro padre di famiglia, Yudai (Lily Franky) - si trovava sul gradino più basso della scala sociale e Ryoda, vero e proprio workaholic, non può fare a meno di guardare dall’alto in basso chiunque abbia scelto di non sacrificare la propria vita per la carriera.
D’altronde, la lingua giapponese prevede un termine specifico (karoshi) per indicare la morte per il troppo lavoro.
Il vero focus di Father and Son è però nonostante tutto la dicotomia “Nature versus Nurture” - coniata nel 1869 dall'antropologo Francis Galton - che mette in contrapposizione l’eredità biologica e i fattori esterni nella formazione del carattere di una persona e, soprattutto, l’effettivo valore del legame familiare.


[Un padre e un figlio, nonostante non ci siano di legami di sangue]
Midori, essendo donna e madre, viene additata maggiormente del marito per non aver capito che stava crescendo un figlio non suo.
Una madre dovrebbe sentirlo, ma quando finalmente la donna si trova faccia a faccia con il vero figlio Ryusei sente la mancanza del bambino cresciuto per sei anni e alla fine, seppur con riluttanza, anche Ryoda arriverà alla stessa conclusione.
Il legame di sangue è indubbiamente importante, ma non sufficiente a provare automaticamente dei sentimenti reali; una dinamica, questa, che verrà ripresa dal regista e maggiormente approfondita in Un affare di famiglia.
Bastava davvero poco a rendere Father and Son un melodramma per la lacrima facile, a eccedere in picchi drammatici e patetici volti a impressionare lo spettatore.
Tuttavia Kore’eda si destreggia tra l’intreccio e le vicende delle due famiglie in maniera, come al solito, elegante e leggiadra; preferendo togliere invece che aggiungere, lasciando alla bravura e alla naturalezza degli interpreti il compito di trasmettere emozioni senza il bisogno di troppe parole.
_________________
Little Sister
(海街diary Umimachi Diary), 2015
scritto da Hirokazu Kore'eda (sceneggiatura), Akimi Yoshida (manga originale)
direttore della fotografia: Mikiya Takimoto
genere: drammatico
In Little Sister ci troviamo ancora una volta di fronte a delle figlie costrette a contare esclusivamente sulle proprie forze poiché abbandonate da genitori non all’altezza del proprio ruolo.
Non si tratta dei bambini di Nessuno lo sa, ma di giovani donne guidate dalla maggiore, Sachi (Haruka Ayase), ormai alla soglia dei trent’anni.
Attraverso allusioni disseminate nel corso della pellicola ci rendiamo conto che le sorelle si trovano già da tempo in tale situazione, esattamente a partire dal divorzio dei genitori, quando il padre si è risposato con quella che era stata la sua amante e la madre ha deciso di voltare pagina e andare via, lasciando le sorelle sole nella grande casa della nonna, affidate esclusivamente allo sguardo vigile della proprietaria di un ristorante, unica figura vagamente materna per le ragazze.
[Il trailer di Little Sister di Hirokazu Kore'eda]
In occasione del funerale del padre, le sorelle conoscono la figlia che l’uomo ha avuto dalla seconda moglie e provano nei suoi confronti un’immediata affinità, tanto da proporle di andare a vivere con loro; Suzu (questo il nome della ragazza, interpretata da Suzu Hirose), sentitasi sempre sola ed emotivamente distaccata dalla madre, accetta di buon grado.
Little Sister è tutto qui: la quotidianità di quattro giovani donne, ognuna con una storia diversa, che conducono un’esistenza a metà tra la tradizione e la modernità, si sostengono a vicenda e imparano a conoscersi mentre la più piccola si ritaglia un posto sempre più grande nel cuore delle maggiori.
Uno dei punti di forza del film - ispirato al manga Our Little Sister - Diario di Kamakura di Akimi Yoshida - è indubbiamente la caratterizzazione delle quattro sorelle e l’interpretazione delle rispettive attrici che riescono a dar vita a personaggi reali, diversi l’uno dall’altro, con pregi e difetti.
Persino la sorella più grande, che si è trovata a dover ricoprire il ruolo di madre e padre per le altre quand’era poco più che una bambina e che sembra all’apparenza la più responsabile ed equilibrata delle quattro, nasconde una relazione extraconiugale con un dottore dell’ospedale per cui lavora come infermiera, cosa che non la rende molto diversa dall’odiata amante e seconda moglie del padre.


[Le protagoniste di Little sister]
Sachi, Yoshino, Chika e Suzu sono quattro “piccole donne”, determinate e ambiziose, con complessi e paure che cercano di esorcizzare tenendosi per mano e che si fanno strada in una società sempre più moderna, pur continuando a essere fortemente legate alla tradizione giapponese.
Lo sguardo di Hirokazu Kore’eda si muove leggiadro tra la quotidianità della ragazze: dal lavoro ai pasti consumati insieme, dalle partite di calcio di Chika e Suzu ai fuochi d’artificio; quello che colpisce è proprio la maestria con cui il regista pone l’accento sulle piccole cose, su momenti apparentemente insignificanti ma dotati di una bellezza pura e intrinseca, difficile da spiegare con le parole ed efficaci solo se catturati dall’occhio capace di riconoscerli.
Ed è ormai chiaro a questo punto che Kore’eda possieda quell’occhio e la capacità di rendere l’ordinario straordinario.
_____________________________
Ritratto di famiglia con tempesta
(海よりもまだ深く Umi yori mo mada fukaku), 2016
scritto da Hirokazu Kore'eda
direttore della fotografia: Yutaka Yamasaki
genere: drammatico
Ryota (Hiroshi Abe) è uno scrittore la cui carriera si è arenata dopo essere riuscito a pubblicare un unico romanzo.
Per sbarcare il lunario lavora come investigatore privato e si barcamena come meglio può, spesso con mezzi non proprio ortodossi.
A causa della sua indole inaffidabile, ha perso la moglie (Kyoko Shiraishi) e il figlio, che vede raramente.
Durante una tempesta, la famiglia si riunisce per una notte a casa della madre di Ryota (Kirin Kiki) – rimasta da poco vedova – e l’uomo coglierà l’occasione per provare a rimettere in sesto la propria vita.
[Il trailer di Ritratto di famiglia con tempesta di Hirokazu Kore'eda]
Ritratto di famiglia con tempesta raccoglie molti dei temi cari a Kore’eda e approfonditi - in maniera probabilmente più accurata - nei film precedenti.
Ancora l’elaborazione del lutto, ancora l’accento su quanto il denaro e la realizzazione professionale contino nel giudizio di un uomo, ancora un bambino che osserva con sguardo rassegnato il tormento dei genitori, ancora una famiglia raccolta attorno a un tavolo con il cibo a fare da mediatore.
Tuttavia, Ritratto di famiglia con tempesta si distingue in quanto, seppur delinei le dinamiche di una famiglia, sembra soffermarsi maggiormente sul percorso del protagonista.
La prima parte della pellicola infatti si concentra perlopiù sulle peripezie da investigatore improvvisato di Ryota, sul senso di umiliazione e frustrazione che prova ogni volta che chiunque, persino la stessa madre, gli faccia notare quanto sia un fallito e sulla lotta personale che intraprende per poter stare di più con il figlio.
Ryota è un personaggio piuttosto complesso, schiacciato dalle aspettative che non riesce a soddisfare e da un orgoglio personale che gli impedisce di accettare lavori che ritiene mediocri, pur vivendo un’esistenza nient’altro che misera.
Non è abbastanza per la madre, che dopo una vita di sacrifici avrebbe voluto dal figlio quanto il marito non era riuscito a offrirle; non è abbastanza per l’ex moglie che ha cercato la sicurezza nelle braccia di un altro uomo; e non è abbastanza per il figlio, dato che non riesce nemmeno a provvedere al suo mantenimento.


[Ryota con la moglie e il figlio]
La tempesta, allora, arriva a spazzare via un po’ di questo senso di inadeguatezza, ad alleviare la vergogna per se stesso e a scuoterlo dalla trance ossessiva in cui è rimasto incagliato: è proprio attraverso l’accettazione del proprio stato e delle motivazioni di chi gli sta accanto, in primis dell’ex moglie, che lo strappo inizierà pian piano a rimarginarsi.
Nonostante lo spazio dedicato alle attività di Ryota come detective privato possa risultare un po’ ridondante, Kore’eda utilizza nuovamente dei pennelli dai colori tenui per dipingere il ritratto di famiglia a cui si riferisce il titolo italiano.
Questa volta, però, decide di calcare la mano su un uomo perso lungo i sentieri della vita, che rimpiange il passato e rincorre il futuro, senza soffermarsi sul presente; il cui dolore non è urlato ma esternato attraverso il volto espressivo di Hiroshi Abe e con cui risulta impossibile non identificarsi, perché tutti noi ci siamo smarriti almeno una volta nella vita.
________________________
Il terzo omicidio
(三度目の殺人 Sandome no satsujin), 2017
scritto da Hirokazu Kore'eda
direttore della fotografia: Mikiya Takimoto
genere: drammatico, thriller
Il terzo omicidio rappresenta una novità all’interno della filmografia di Hirokazu Kore’eda.
Come era già successo con Hana e Air Doll, il regista decide di allontanarsi dallo studio delle emozioni umane ritratte nella loro quotidianità, questa volta per approcciarsi al thriller legale senza, però, rimanere impigliato nei limiti del genere, ma usandolo anzi come pretesto per delle riflessioni piuttosto interessanti.
L’avvocato Shigemori (Masaharu Fukuyama) deve difendere Misumi (Kõji Yakusho), condannato alla pena di morte per aver ucciso il proprio datore di lavoro.
Misumi era stato già accusato di omicidio trent’anni prima, ma era riuscito a scampare la pena capitale grazie al giudice, padre di Shigemori.
[Il trailer de Il terzo omicidio di Hirokazu Kore'eda]
Per un motivo apparentemente inspiegabile Misumi non ha problemi ad ammettere la propria colpevolezza, ma continua a cambiare versione sul come e sul perché abbia compiuto l’omicidio.
Inizialmente Shigemori, da avvocato freddo e distaccato qual è, non si mostra interessato alla verità; vuole soltanto fare il suo lavoro e trovare un modo per salvare il cliente dalla pena di morte.
Man mano che Misumi continuerà a modificare il proprio racconto, però, l’avvocato comincerà a interrogarsi sulle motivazioni di tale atteggiamento e su quale sia effettivamente la verità.
Quello che inizia come un dramma legale abbastanza classico, allora, si trasforma in una riflessione sul concetto stesso di verità - sulle orme di Rashomon - sulla pena di morte, tutt’ora vigente in Giappone nonostante la bassa criminalità e - come in ogni film di Kore’eda - sulla famiglia, in particolare sul rapporto padre/figlia.


[Shigemori e Misumi]
Lo spettatore è portato a identificarsi con Shigemori, perennemente confuso dall’atteggiamento di Misumi.
Perché mentire? Cos’è successo davvero?
Il film non offre una risposta definita a questi interrogativi.
Probabilmente le versioni incoerenti di Misumi riflettono l’inutilità della verità in sé: a prescindere da quale sia, ci saranno sempre vittime e carnefici e spesso sarà complicato distinguere le due condizioni.
Lo stesso Misumi mette a paragone le proprie orribili azioni con quelle perpetuate della legge: non si tratta forse, in entrambi i casi, di una mera risoluzione di un problema?
Perché un omicidio compiuto da un cittadino dovrebbe essere diverso da quello eseguito dallo Stato soprattutto se, in entrambi i casi, sia finalizzato a eliminare un colpevole?
In una delle tante versioni, infatti, sembrerebbe che Misumi abbia ucciso il proprio capo perché quest’ultimo abusava della figlia adolescente.
Quanto ci sia o meno di vero in questa giustificazione rimane, ancora una volta, impalpabile ma funge da spunto per meditare sul rapporto genitori-figli e sull’incomunicabilità intergenerazionale, un problema universale ma particolarmente radicato in una società rigida come quella giapponese.
Come noi ci immedesimiamo in Shigemori che, messa da parte la freddezza del sistema legale che rappresenta, si inoltra in una zona sempre più oscura pur di comprendere le motivazioni di Misumi; così l’avvocato stesso inizia pian piano ad avvicinarsi al proprio cliente, assottigliando sempre di più la distanza tra loro fino a riconoscersi in lui in più aspetti, come espresso dalla bellissima inquadratura che vede i loro riflessi perfettamente sovrapposti sul vetro divisorio.
_____________________
Un affare di famiglia
(万引き家族 Manbiki kazoku), 2018
scritto da Hirokazu Kore'eda
direttore della fotografia: Ryūto Kondō
genere: drammatico
Una famiglia allargata, che vive di espedienti e piccoli furti, accoglie nella propria casa una bambina trovata a vagare sola per strada, con evidenti segni di violenza sul corpo.
Immersi in quello che appare come un quadretto famigliare idilliaco, nonostante le ristrettezze economiche, scopriamo pian piano che non tutto è come sembra.
Quella che avevamo qualificato come una famiglia senza nemmeno pensarci, si rivela essere nient’altro che un insieme di persone finite insieme a vivere nell’illegalità per necessità, affetto, o altre vicissitudini.
Un affare di famiglia - vincitore della Palma d’oro al Festival di Cannes 2018 - è ad oggi il film più riconosciuto di Hirokazu Kore’eda, nonché quello che gli ha permesso di uscire dai confini nazionali per diventare uno dei registi giapponesi contemporanei più popolari al mondo.
Un successo decisamente meritato perché la pellicola, seppur riprendendo temi cari al regista e diffusamente approfonditi nei film precedenti, non risulta come un’ennesima variazione degli stessi concetti, bensì la sintesi ultima degli stessi.
[Il trailer di Un affare di famiglia di Hirokazu Kore'eda]
Dall’idea di famiglia al valore dei legami di sangue, dalle differenze sociali all’abbandono dei figli da parte dei genitori, fino ad arrivare a un discorso generale sulla solitudine e sul labile confine tra giusto e sbagliato: ognuna di queste nozioni incontra la perfetta sublimazione in questa opera.
Kore’eda, mettendo insieme delle persone opportuniste e al contempo altruiste, riflette sul significato stesso di famiglia e sull’ipocrisia della società che guarda dall’alto in basso chi non è genitore - soprattutto chi non è madre - andando a favorire piuttosto situazioni tossiche per i bambini, senza considerare la possibilità che non tutti i genitori riescano a essere all’altezza del proprio ruolo.
Il regista, tuttavia, riesce a evitare il melodramma conferendo dei chiaroscuri ai suoi protagonisti: malgrado sia impossibile non empatizzare con ognuno di loro e non rimanere colpiti dagli slanci di genuino altruismo, riusciamo comunque a riconoscere la profonda scorrettezza alla base del loro stile di vita.
Si tratta di parassiti della società a tutti gli effetti, persino la saggia e sarcastica nonna - ultima interpretazione della magnifica Kirin Kiki - sfrutta la propria condizione per estorcere denaro a parenti lontani e l’intera famiglia si appoggia sulla sua pensione.
Inoltre, a causa della loro condizione, i bambini non possono andare a scuola e, anzi, vengono istruiti all’arte del taccheggio.
Tra le interpretazioni del film spicca in particolare quella di Sakura Ando nel ruolo di Nobuyo, lanciata in Love exposure di Sion Sono e uno dei volti del Cinema nipponico contemporaneo.


[Questa particolare famiglia in gita al mare]
Un affare di famiglia, dunque, è un racconto ai margini sotto tutti i punti di vista: persone sole e sfortunate che vivono ai margini di Tokyo, il cui fine ultimo è semplicemente sopravvivere secondo le proprio leggi, senza nessun obbligo nei confronti di una società che non ha fatto altro che emarginarli.
Non ci sono eroi né vittime per Kore’eda, al di fuori dei bambini che in un modo o nell’altro finiscono sempre per subire sulla propria pelle gli errori e l’irresponsabilità degli adulti, come dimostra il triste finale del film.
Nonostante l’amarezza di fronte a uno spaccato di vita talmente ingiusto, però, sarà inevitabile sentire il calore emanato da quello che è il cuore pulsante dell’opera: un gruppo di persone abbandonate dalla vita che si ritrovano a gioire attorno a un tavolino imbandito di prelibatezze – ancora il cibo a fungere da collante – in una casa minuscola e soffocante eppure accogliente.
Un’immagine semplice che trasuda umanità.
_____________________
Le verità
(La Vérité), 2019
scritto da Hirokazu Kore'eda
direttore della fotografia: Éric Gautier
genere: drammatico
Dopo il successo di Un affare di famiglia, per Kore’eda giunge il momento della prima trasferta al di fuori del suolo giapponese.
Le verità, infatti, è ambientato in Francia e conta nel cast tre attori internazionali del calibro di Catherine Deneuve, Juliette Binoche ed Ethan Hawke.
Se a primo acchito il cambio di registro potrebbe risultare scioccante per lo spettatore abituato alla poetica del regista, basterà prestare un po’ più di attenzione per capire quanto, in realtà, la mano di Kore’eda sia riconoscibile anche in un contesto a lui estraneo.
Nello specifico, ci troviamo ancora di fronte a questioni care al regista come la famiglia, il concetto di verità, il ruolo della memoria e l’elaborazione del lutto.
[Il trailer de Le verità di Hirokazu Kore'eda]
Deneuve interpreta una famosa attrice, Fabienne Daugeville, che giunta ormai al tramonto di una vita di successi sta per pubblicare un’autobiografia.
Per l’occasione, la figlia Lumir (Juliette Binoche), insieme al marito (Ethan Hawke) e alla figlia, torna da New York dove lavora da anni come sceneggiatrice.
Il rapporto tra le due donne non è mai stato idilliaco, ma quando Lumir legge le menzogne raccontate nel libro, decide di affrontare la madre una volta per tutte.
Il film introduce anche un elemento relativamente nuovo all’interno della filmografia di Kore’eda - con l’esclusione di After Life - ovvero il ruolo dell’attore e di come esso si sia evoluto nel tempo e l’incontro tra il Cinema (finzione) e la vita (realtà).
È possibile affermare che Deneuve interpreti a tutti gli effetti se stessa: il prototipo dell’attrice-diva, che ha vissuto gli anni d’oro della Settima Arte e che, con una mentalità probabilmente classista, sostiene la superiorità di un certo tipo di Cinema intellettuale, tipicamente europeo, in contrasto con quello “commerciale” di oggi, usufruibile da tutti, a patto di avere una connessione Internet, rappresentato del genero Hank, attore di serie TV web.
Tra i due estremi si trova Lumir, ottimamente interpretata da Binoche, che incarna l’idea più contemporanea dell’attore che respinge il divismo.


[Catherine Deneuve e Juliette Binoche]
Interessante, inoltre, come Kore’eda scelga di riflettere sui temi della memoria e della verità attraverso una “riproduzione” della realtà: il nuovo film di Fabienne è infatti una storia fantascientifica in cui una madre non invecchia e incontra la figlia in diversi momenti della sua vita.
Un espediente utile non solo a riflettere sul rapporto madre figlia ma anche sul “fantasma” di Sarah, un’altra attrice nominata di continuo nel corso del film che intuiamo aver avuto un ruolo materno nei confronti di Lumir prima di venire “uccisa”, almeno da un punto di vista morale, dall’egocentrismo spietato di Fabienne.
Persino la riconciliazione tra madre e figlia diviene una messa in scena, a dimostrazione di quanto la verità sia un concetto astratto, soprattutto dal punto di vista dell’attore che consacra la propria vita alla finzione.
Hirokazu Kore’eda osserva con sguardo attento ma leggermente distaccato un universo che conosce bene, ma di cui non fa totalmente parte, un po’ come il personaggio interpretato da Ethan Hawke che capisce il francese ma non sa parlarlo, intimidito da Deneuve e da tutto ciò che rappresenta.
[Articolo a cura di Lorenza Guerra e Nadia Pannone]
Ti è piaciuta questa monografia? Sappi che hai appena visto il risultato di tanto impegno, profuso nel portarti contenuti verificati e approfonditi come meriti!
Se vuoi supportare il nostro lavoro perché non provi a far parte de Gli Amici di CineFacts.it?
Chi lo ha scritto

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE
Lascia un commento

2 commenti
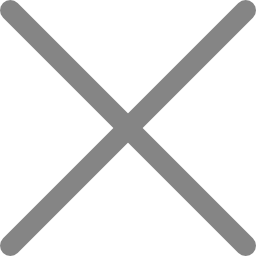
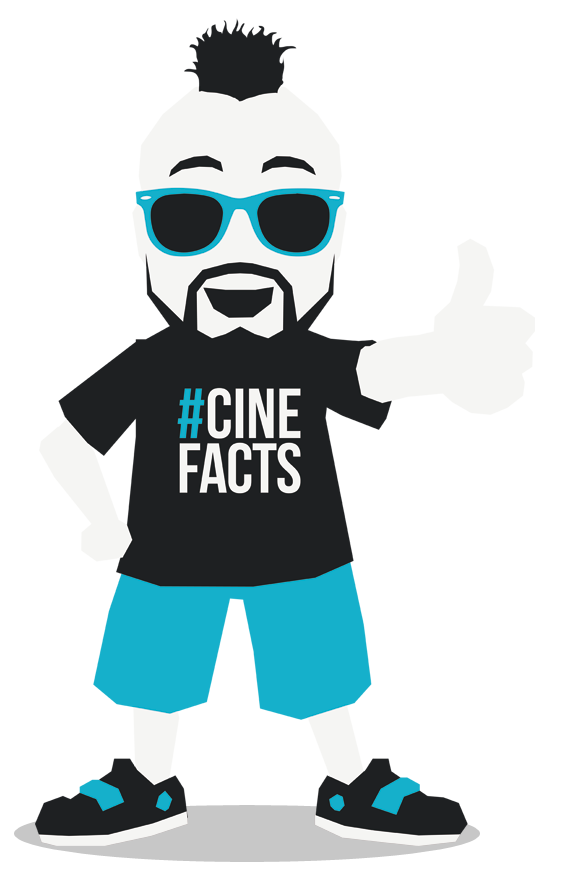

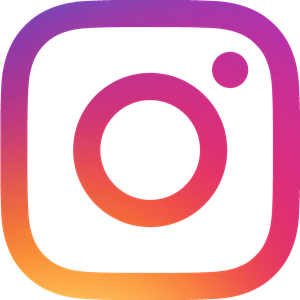





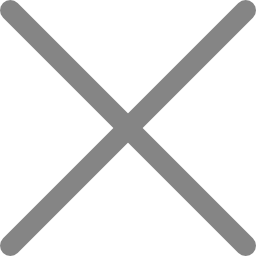
 Commentare gli articoli
Commentare gli articoli
Terry Miller
1 anno fa
Rispondi
Segnala
Lorenza Guerra
2 anni fa
Rispondi
Segnala