Oscar2024
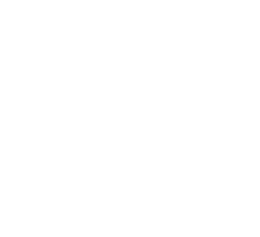
#articoli
È da un po’ che rifletto sullo scrivere o meno un pezzo su Se la Strada potesse parlare.
Un’indecisione che si è dispersa recentemente, in seguito e a causa di due occorrenze: la prima - più banale - è il fatto che abbia sentito la necessità di riguardarlo e di mostrarlo a chi mi è vicino; la seconda coincide col crescere della sensazione che in questi giorni, in questi mesi, si stia facendo la Storia di un conflitto secolare, passando sulla pelle di centinaia di migliaia di manifestanti in quel pentolone di contraddizioni e antinomie antropologiche che chiamiamo Stati Uniti d’America.
Sensazione peculiare, se ci si vuol soffermare, poiché nella Storia ci siamo immersi, e tale coinvolgimento esplicito - si sa - rende sfuggevole avvertire l’entità dei momenti in cui si vive.
[Ed Skrein interpreta l'Agente Bell]
Eppure - senza dilungarsi oltre - tale percezione non è giunta senza essa stessa pormi ulteriori interrogativi: è giusto che a scrivere di un film così potente ci sia… io?
Potrebbe (o dovrebbe) venire da chi in prima persona è in grado di sentirne amplificato il messaggio, le emozioni, l’eredità estetica?
Prevengo le perplessità che in Italia spesso scaturiscono a seguito di quesiti come questi: no, non penso ci sia bisogno di un Imprimatur di qualsiasi genere per parlare di un film sulla questione razziale, e men che meno di patenti morali di alcun tipo, ma riconosco il mio potenziale difetto nella capacità di cogliere sfumature, dinamiche relazionali o idiosincrasie proprie di un universo a cui non appartengo.
Il mio, in sintesi, vuole essere un gesto di rispetto e ammirazione per un lavoro - quello di Barry Jenkins - che a mio parere è tra i migliori ritrovabili nel genere, un’autentica perla di grazia e amarezza… e che, infine, è un film di un afroamericano basato sul romanzo di un afroamericano: per entrambi la questione razziale è al centro della poetica del loro medium.
_________________
[Fotografia di Roy DeCarava, ispirazione del film, © Estate of Roy DeCarava, via David Zwirner]
Se la strada potesse parlare si apre con un ralenti aereo che cattura due ragazzi passeggiare mano nella mano in un parco di una New York autunnale.
L’atmosfera è vibrante, romantica, i passi sono scanditi dalle note di una colonna sonora lenta e appassionata, mentre la palette cromatica che li circonda si fonde con le loro vesti e il tutto viene catturato straordinariamente da un movimento fluido, continuo, della macchina da presa, con i pochi tagli riservati ai primi piani dei visi quasi estatici degli innamorati.
Traspare l’allegoria biblica del Giardino dell’Eden, dove però anche in assenza di alcun Peccato Originale, l'incanto viene spazzato via senza apparente causa, mentre una sirena brutale stronca le note dolci, segnando l’inizio dell’orario di visita nella prigione di Rikers Island.
Scena.
[Stephan James e Kiki Layne, i protagonisti del film]
Da qui in avanti l’intreccio è presentato in maniera non lineare, e la narrazione viene intervallata da flashback, ricordi, episodi significativi della vita dei due, in un'altalena emotiva che è ritrovabile anche nel precedente film del regista, Moonlight (2017).
Se la strada potesse parlare è il terzo lungometraggio di Barry Jenkins, giovane regista americano salito agli onori della cronaca in occasione del suo secondo lavoro, appunto Moonlight, vincitore del Premio Oscar per il Miglior Film e protagonista con La La Land della storica gaffe della Notte degli Oscar 2017.
Basato sull’omonimo romanzo del grande James Baldwin, Se la strada potesse parlare racconta la storia dell’amore di Fonny (Stephan James) e Tish (Kiki Layne), due giovani ragazzi neri che cercano di costruirsi la propria strada nella New York City di inizio anni ’70, pur consapevoli delle difficoltà cui vanno incontro.
Caratteristica chiave, centrale, che permea interamente i 117 minuti della pellicola è esattamente questa: una consapevolezza - quella dello status quo - che appare ereditata più che acquisita, tramandata dalle generazioni anteriori come una forma di ultima difesa o di perenne vigilanza, e che ha come conseguenza implicita un’apparente indolenza, incorporata da tempo immemore nella coscienza collettiva di un popolo.
È talmente palpabile che, da spettatore bianco - ed ecco la problematicità del comprendere a fondo una questione stratificata, complessa, storica - ho esperito dei moti di irrequietezza, di collera istintiva, non capacitandomi della calma e della rassegnazione con cui delle attitudini assolutamente ignobili venissero tollerate come parti integranti del vivere quotidiano.
Una di queste, al centro della vicenda narrata da Jenkins, è la difficoltà dei due nel trovare un appartamento da affittare a causa del razzismo dei locatori, che appena vedono in persona la coppia inventano scuse o si rimangiano la parola data.
[ndr: questo fenomeno, studiato in diverse scienze sociali, cade sotto il nome di redlining, se può interessare l'approfondimento].
Fonny soffre silenziosamente questa ingiustizia e sogna di lasciare il Paese, ma persevera nella ricerca di un posto dove finalmente sposare l’amata Tish e costruire insieme un futuro.
Tuttavia la realtà bussa presto alla porta, il razzismo sistemico della New York degli anni ’70 produce i suoi effetti attesi, e Fonny finisce accusato di uno stupro assurdo per il quale viene detenuto in attesa del processo.
Uno degli apici emotivi del film viene raggiunto proprio durante una visita in prigione di Tish, che gli comunica di essere felicemente incinta e che presto gli avvocati riusciranno a tirarlo fuori.
Il seguito della vicenda - che non approfondirò - si può immaginare facilmente, ma ciononostante vederlo (o rivederlo) non sottrae un millesimo alla potenza drammatica del film.
[Uno dei flashback che ritrae l'amicizia di una vita di Fonny e Tish]
A mio avviso non esistono scene superflue in questo film.
Eppure c'è una scena in particolare, tra quelle narrate in flashback antecedenti all’arresto, in cui credo che più che in tutte le altre Jenkins abbia voluto condensare la poetica del suo lavoro.
È quella in cui Fonny si imbatte in Daniel, un vecchio amico d’infanzia che si aggirava per il quartiere in cerca di lavoro, un incontro da cui scaturisce la gioia di quando due anime scoraggiate sperano di trovare nell’altra uno spiraglio di luce.
Fonny, intenzionato a riallacciare il rapporto, decide di portarlo a casa, e ciò a cui assistiamo poco dopo è la reunion di una coppia di amici che un tempo doveva essere affiatata.
Mangiano, bevono, fumano, ridono ricordando il passato.
È qui, se ci si presta attenzione, che uno dei momenti più dolorosi del film ha luogo, dipanandosi in tutta la sua rassegnazione, vero leitmotiv emotivo del film, come accennavo in precedenza: con i minuti che passano, la conversazione passa rapidamente dal nostalgico al cupo, e le ragioni dei rispettivi scoraggiamenti emergono spontanee.
Daniel è appena uscito di prigione, dove c’è finito forzatamente, poiché incastrato dalle autorità razziste della città; Fonny è incapace di trovare un tetto alla sua famiglia per ragioni analoghe.
[Brian Tyree Henry interpreta l'amico Daniel]
È un lento, inesorabile scambio di compassione, mentre le ferite sono ancora aperte, vive, cocenti nei corpi di due ventenni che devono fare i conti con una realtà e un paese che “really don’t like niggers man… they’ll rent to a leper before they rent to a nigger”.
[“odia i negri, amico… affitterebbero a un lebbroso pur di non affittare ad un negro”]
Le risate nervose e i sogghigni che si scambiano suonano sempre più come tentativi maldestri di sdrammatizzare, o anche di placare la rabbia dell’altro e di se stessi.
Personalmente ho avuto bisogno di una seconda visione per rendermi conto dell’assoluta centralità di questa scena, e della sua potenza drammaturgica.
Il dialogo tra i due vecchi amici è la raffigurazione dell’incapacità di estendere un dialogo costruttivo al di fuori della cerchia degli oppressi. E talvolta - lo abbiamo visto - risulta una conversazione difficile da sostenere persino tra di loro.
Jenkins sceglie di intrappolare la macchina da presa tra i due, prediligendo le panoramiche ai tagli e lasciando la lente vagare nello spazio vuoto che li separa (nel cosiddetto negative space), conferendo una continuità più genuina e inclusiva al dialogo, ricco di pesanti silenzi e attese scomode.
La catarsi ricercata nella reciproca consolazione fallisce miseramente, e ciò che rimane è la paura.
La paura di Fonny di non riuscire a provvedere all’amata Tish.
La paura di Daniel di ciò che la prigione è stata e di come lo ha cambiato per sempre.
Un’incertezza quotidiana che rende vana qualsiasi progettualità, qualsiasi aspirazione o sogno… spazzando via anche quella ricerca della felicità, enunciata nella Costituzione americana che - per gli afroamericani, anche nel 2020 - sa di beffa, di un cattivo scherzo.
Se la strada potesse parlare Se la strada potesse parlare Se la strada potesse parlare Se la strada potesse parlare Se la strada potesse parlare
James Laxton alla fotografia, vincitore dell'Oscar per Moonlight, ha dichiarato di avere tra le sue ispirazioni i film di Wong Kar-wai e Claire Denis, e le bellissime fotografie di Roy DeCarava, fotografo di Harlem molto attivo negli anni in cui è ambientato Se la strada potesse parlare.
Laxton sceglie il 65mm, un grande formato digitale per catturare con una definizione estrema particolari e dettagli, e per facilitare le diverse riprese negli interni bui con il maggior range dinamico possibile, utile in particolare in presenza delle pelli scure, più difficili da catturare.
La ricchezza del colore - tra le più belle che abbia mai visto - è stata oggetto di un profondo studio da parte dei colorist e dello stesso Jenkins, che voleva far sì che si respirasse il più possibile l’aria della Harlem degli anni ’70, dove la presenza afroamericana (e pertanto la cultura nera) distingueva l’estetica del quartiere dal resto della frenetica New York.
La natura del grande formato implica anche che - a parità di lunghezza focale - i campi dell’inquadratura siano molto più grandangolari e abbiano una profondità di campo minore, esasperando la sensazione di immersività e il focus sull’umanità delle figure.
[Fotografia di Roy DeCarava, ispirazione del film. © Estate of Roy DeCarava, via David Zwirner]
Mi si conceda qui un tecnicismo becero, come amiamo chiamarlo in Redazione e nel Podcast.
La consistenza delle ombre, la profondità dei neri e la ricchezza dei colori caldi ricordano terribilmente quelle di un film girato in pellicola (a me, ad esempio, ha fatto venire in mente alcune scene del BlacKkKlansman di Spike Lee, girate in Ektachrome) e in effetti, scavando un po’, è emerso che il team di colorist abbia usato diverse emulsioni analogiche popolari all’epoca (Provia, e lo stesso Ektachrome) per offrire un riferimento in post-produzione in fase di color grading.
Inoltre, e chiudo così l’angolo tecnico, Jenkins ha optato per un formato impopolare, l’Univisium ideato dal nostro Vittorio Storaro, che ha come caratteristica principe l’aspect ratio di 2:1.
[Trailer internazionale di Se la strada potesse parlare]
Vorrei poter dire che la fotografia che ho acclamato poco fa sia la punta di diamante del film, ma la verità è che veramente ogni aspetto, dal più “artistico” al più “tecnico”, è curato nei minimi dettagli, e l’ensemble che ne risulta non può che essere di qualità finissima anch’essa.
La musica scritta da Nicholas Britell, ad esempio, è altrettanto splendida nell'accompagnare le tortuose vicende emotive dei protagonisti con maestria e delicatezza, e si lascia intervallare solo dalla voce divina di Nina Simone o dal sax di John Coltrane ed altri giganti (neri) della musica del Novecento.
Se la strada potesse parlare è un film che come Moonlight offre numerosi spunti di riflessione e la cui problematicità dialettica si incrocia con una profondità drammaturgica pregevole.
Prove attoriali notevoli come quelle di Regina King (la madre di Tish) e Stephan James lasciano il segno per la capacità di andare oltre gli archetipi dei personaggi che interpretano e per offrire nuove occasioni di ammirare un’umanità che sopravvive in un ecosistema sociale ad essa strutturalmente ostile.
Se la strada potesse parlare Se la strada potesse parlare Se la strada potesse parlare Se la strada potesse parlare Se la strada potesse parlare
Compresenza - questa di umanità e protesta - che costituisce una costruzione non ordinaria per un film di denuncia, e che difatti è difficile da bilanciare.
Tant'è vero che non è la prima volta che si levano critiche di escapism (evasività) nei confronti del giovane regista di Miami.
Anche dalle parti più liberali e progressiste del dibattito cinematografico, alcuni hanno sottolineato come sia Moonlight che Se la strada potesse parlare siano troppo belli per dipingere una realtà così acre, così dura da digerire.
... E diamine se sono belli, aggiungerei io.
L’estetica espressionista del giovane regista americano rappresenta forse tra i più riusciti equilibri nella resa audiovisiva dei contenuti, un profluvio di suoni, immagini e dialoghi che mettono in scena sequenze meravigliose, tanto da ispirare le lodi di numerosi colleghi filmmakers tra i quali spicca Paul Thomas Anderson che - per la commozione in diretta di Jenkins - durante un recente podcast di The Director’s Cut si disse invidioso dei suoi close-up.
Jenkins una volta rispose a una critica simile che definiva i suoi film dei lavori di evasione (escapist, appunto):
“The world is on fire.
So if you’re making a film and there’s not a quality to it that is a burning passion, a burning desire, then it’s not important.”
[“Il mondo è in fiamme.
Se fai un film e non c’è quella passione bruciante, o un desiderio che arda… allora non può essere importante.”]
Ed è all’alba di una nazione in rivolta, di un movimento - come quello del #BlackLivesMatter - che scuote le fondamenta sociali di decenni, di secoli di oppressione, che ci si rende conto di quanto Barry Jenkins abbia prodotto un capolavoro di passione e di desiderio, ma soprattutto qualcosa che bruci, che infiammi il presente e getti luce su una condizione atroce e mai sconfitta veramente.
Gli assassinii di George Floyd e Breonna Taylor sono solo la miccia più recente che rianima una fiamma che arde viva alla base del film.
E come ogni fuoco scotta, poiché affrontare ancora una volta la questione razziale, nel 2020, scotta davvero.
Se la strada potesse parlare Se la strada potesse parlare Se la strada potesse parlare Se la strada potesse parlare Se la strada potesse parlare Se la strada potesse parlare

Oscar2024
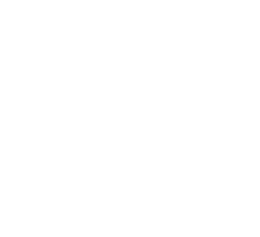

1 commento
Teo Youssoufian
3 anni fa
scrivimi un messaggio a info@cinefacts.it: c'è una sorpresa per te 😉
Rispondi
Segnala