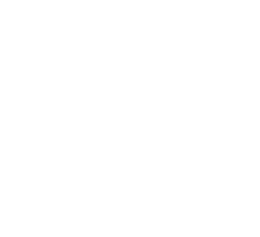Articoli
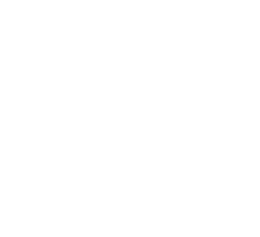
#articoli
Nel documentario If It Were Love il regista austriaco Patric Chiha affrontava con coraggio il tema della temporalità, intersecando a un tempo due piani di riflessione (meta)artistica - proprio nell'interazione tra temporalità e possibilità del mezzo teatrale e del mezzo cinematografico si situava uno dei maggiori punti d'interesse dell'opera - a un livello tanto elementare quanto, se portato a coscienza, significativo.
Una temporalità incarnata, con riferimento al concetto di embodiment, guidava un discorso tutto estetico sui corpi danzanti impegnati in Crowd, la pièce ideata da Gisèle Vienne che Chiha si incarica di riscrivere cinematograficamente, nel tentativo (riuscito) di stratificarne ancor di più la concettualità.
Guardando coreograficamente e iconograficamente alla scena rave, le traiettorie descritte dalle carni in movimento riecheggiano, anzi sono (letteralmente, e non potrebbero essere altro) delle traiettorie interiori, ognuna con una velocità propria, ognuna con una risonanza soggettiva e intersoggettiva, come addensamento in una trama di corpi e di tempi.
[Il trailer de La Bête dans la jungle]
Ne La Bête dans la jungle Chiha continua la propria ricerca ridimensionando il pensiero direttamente rivolto al (e condotto attraverso il) dispositivo cinematografico a favore di una strategia più inscritta nella narrazione, in accordo con la natura finzionale di un lavoro che marca allora una distanza strutturale - non che questa sia intrinseca alla problematica distinzione tra fiction e non-fiction - rispetto a If It Were Love e Brothers of the Night.
Come punto di partenza non più una pièce, affare di corpi in movimento, ma un racconto di Henry James dalle coordinate fattuali estremamente rarefatte, che Chiha raccoglie e riaggiorna brillantemente riscrivendo nei propri termini una parabola pregna di significati.
Nel film come nel racconto (ora scientemente privato del potenziale discorso di classe), i giovani John e May si incrociano un decennio dopo un fugace contatto in cui il ragazzo aveva rivelato alla donna il proprio segreto, la convinzione incrollabile che qualcosa di eccezionale - volente o nolente, ma il presentimento è senza dubbio positivo - debba accadergli.
La Bête dans la jungle è la storia dell'attesa a due di questa bestia, segregata negli anfratti proto-surrealisti delle pennellate di Henri Rousseau, in una deformazione che - seguendo André Breton e colleghi - trova il proprio principio nella rottura del confine interno/esterno (soggettivo/oggettivo).
Lo spazio (mentale) di elezione, uno spazio-coperta di Linus che non si vuole abbandonare, è un club ritagliato dal resto del mondo che fa (ben più che) da sfondo all'ondivago rincorrersi di John e May tra 1979 e 2004: con le appariscenti tende dorate e la figura aliena interpretata da Beatrice Dalle, il locale incornicia (dunque separa) il suo spazio astratto esattamente come la balconata e il suo parapetto - iconograficamente assimilabile a una grata - isolano la coppia dal resto degli avventori.
[Un frame da La Bête dans la jungle]
Tra alti e bassi i due aspettano e sperano insieme, entrambi folli, lui trascinato da una fede ottusa, lei dal mistero che lui rappresenta (lo definisce una "zona sconosciuta" con un puntuale riferimento spaziale) e dalla conseguente volontà di vivere una vita "come un romanzo": in definitiva, ciò che John offre è, secondo le parole di Chiha, una great fiction, una grande prospettiva attraverso cui affrontare finzionalmente la vita.
Il passaggio, traducendo alla lettera, da fiction a finzione si rivela tuttavia spinoso: almeno in via preliminare è infatti da rimuovere la connotazione morale del secondo termine, mettendo invece in rilievo la componente costruttiva e ordinatrice della finzione.
In nome di quella fiction, a essere definita è una prospettiva sul mondo (una visione-del-mondo) teoreticamente legittima e pertanto da vagliare nell'ottica - certo non edonistica - della cura di sé; nel caso specifico la postura è contemplativa, subordinata com'è all'attesa di una rivelazione.
Il club è lo scenario ideale per mostrare uno sfasamento di prospettive ben sottolineato dal montaggio incentrato sull'alternanza tra movimento e immobilità, tra temporalità differenti: in pista un sabba totalmente risolto nel presente infinito del qui e ora, in alto (o a lato) una visione - in chiave anche onirica - del sabba.
Il disimpegno motorio equivale al distacco sentimentale se vale il motion is emotion ribadito da Chiha in senso anche autoriflessivo; cionondimeno, entrambe le posture riguardano la vita (e la morte) proprio perché riguardano, in vista di un obiettivo comune, il tempo.
Il presente infinito è al contempo "il massimo della vita e il minimo", sfuggito dionisicamente a una concezione lineare ma privo di una funzione formante, mentre la contemplazione trascende l'agire proiettandosi in un futuro indefinito.
E il film striscia tra questi poli investigando chi vuole fuggire dal tempo, chi rifiuta l'amore perché "l'amore è anche la fine dell'amore", perché sfogliare l'ultima pagina - finire il romanzo - significa dover ricominciare.
Affidarsi a un destino scritto da sé (malamente: le possibilità di riscrittura sono lampanti, perché "se fosse la cosa ad attendere" che accadrebbe?) diviene un rifugio, come aprirsi fintamente alle possibilità castrandone invero le emergenze lontane da uno schema narrativo già fissato.
Solo il vedere realmente - in un cimitero, e quando ormai l'inchiostro scarseggia - delle possibilità altre pensandole come attuabili, come vestiti da misurare sul proprio corpo-vita, rilancia il senso (non più contro il tempo): alla stregua di un mito greco ("molto semplice, molto chiaro e assolutamente misterioso al centro"), peraltro raccontato da un'enunciatrice - quella interpretata da Dalle - piuttosto trasparente, le questioni sollevate da La Bête dans la jungle sono allora esistenziali nella maniera più ampia.
[Beatrice Dalle ne La Bête dans la jungle]
Jorge Luis Borges, in un passaggio di Altre inquisizioni, scrive che la "imminenza di una rivelazione, che non si produce, è forse il fatto estetico"; e Chiha fa di tutto per comprimere e dilatare il ritmo di una pellicola che non può che ragionare anche sui propri tempi, servendosi sia di ripetizioni talora ossessive sia di momenti di sospensione.
In questo flusso, John e May sono spettatori (delegati) e noi spettatori o impiantati nel loro sguardo o posti proprio dinnanzi alla loro condizione spettatoriale: la loro attesa, non beckettiana, si trasforma nella nostra e l'imminenza di una rivelazione, specie attraverso il lavoro sul ritmo, dona alle immagini - spesso di grande impatto sul versante scenografico e fotografico - tanto una profondità discorsiva impensata quanto una valenza emozionale teoreticamente rilevante, ancorata al cinetico.
In quest'ottica, la costruzione di quest'attesa e di questa (possibilità di) rivelazione gioca sapientemente con le aspettative del fruitore, invitandolo a posteriori a soffermarsi sul proprio posizionamento in rapporto alla narrazione e sul suo stesso investimento sentimentale e cognitivo.
Del resto, definire cosa sia una rivelazione - come si muova la bestia, quale sia la giungla - e pensare di conseguenza, in chiave progettuale, un prima e un dopo è tutt'altro che scontato; e precisamente di simili incognite si ciba La Bête dans la jungle.
CineFacts segue tantissimi festival, dal più piccolo al più grande, dal più istituzionale al più strano, per parlarvi sempre di nuovi film da scoprire, perché amiamo il Cinema in ogni sua forma.
Vuoi sostenerci in questa battaglia a difesa della Settima Arte?

Articoli
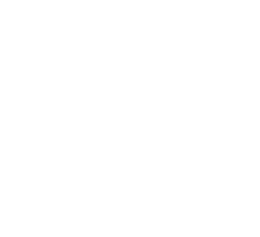
Articoli
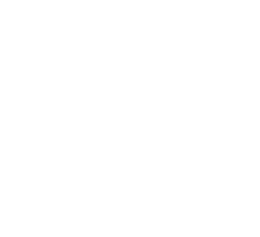
Articoli