Articoli
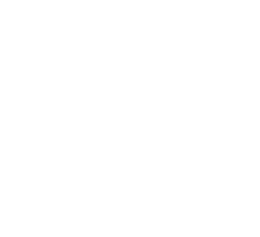
#articoli
Una delle cose meravigliose dell’arte è la sua universalità.
Qualche tempo fa mi sono ritrovato in una discussione con un giovane, aspirante fumettista.
Un tipo che da un lato lodava le opere di Hayao Miyazaki senza capirle davvero e usandole come fonte d’ispirazione per il proprio lavoro, e dall’altro odiava l’arte con ogni fibra del proprio essere, rifiutando ogni connessione o adesione con “i classici”.
Capite da voi quanto fosse paradossale l’idea che un fumettista, un artista non solo per osmosi ma quasi per ovvia derivazione dalle molteplici discipline seminali dalle quali deriva il mezzo da lui prediletto, un esponente di una delle forme espressive più pop(olari) - giusto per ricordarvi da dove viene la parola - arrivi a nutrire astio verso un concetto che per lui dovrebbe essere aria, additando l’idea del classico, punto di partenza di ogni idea e ispirazione, e idolatrando un maestro che non è solo storia dell’animazione - quindi un generatore di classici - ma esponente alto dell’arte in animazione e portabandiera di un cinema che sceglie una comunicazione pop(olare) che, in quanto tale, riesca a veicolare storie pregne di significati nobili e meravigliosi, a un pubblico vasto, potenzialmente infinito.
È un assurdo, un paradosso del nostro tempo, dove l’arte e i suoi meccanismi sono disprezzati anche da chi, per primo, dovrebbe comprenderli senza troppe spiegazioni.
Sarà forse colpa di chi ha dovuto comunicare l’arte e di chi, senza titolo, se ne è fatto scudo?
Questa la domanda del momento presente.
Amo il Cinema proprio perché, tra tutti i suoi generi e sottogeneri, nasconde il potenziale utile a comunicare qualcosa di inestimabile al pubblico, senza dimenticare di intrattenerlo.
In fondo il Cinema è nato con il genere, come le avventure fantastiche e a volte orrorifiche di Georges Méliès, e proprio in questo suo aspetto cela la potenza della sua epica, dei messaggi, delle romanticherie che portano ogni autore a innamorarsi, inevitabilmente, di esso.
Il cinema, in quanto arte, comunica con l’uomo attraverso un livello di immediatezza, anche quando estremamente complesso, pur non essendolo davvero, senza eguali.
Il legame con una pellicola può nascere per molteplici motivi e questo può portare a esplorare il filone legato ad essa e via discorrendo, scatenando una reazione paragonabile a quella di un sassolino che comincia a prendere velocità cadendo lungo la facciata di una montagna.
Se Sergio Leone non si fosse innamorato del mito dei Sette Samurai di Akira Kurosawa, oggi non avremmo la Trilogia del Dollaro.
Se autori americani quali Martin Scorsese e Steven Spielberg non avessero trovato nel cinema neorealista Italiano una grande fonte d’ispirazione, Ladri di Biciclette e Miracolo a Milano di Vittorio De Sica, oggi forse non staremmo parlando di loro come maestri.
Se David Lynch non si fosse innamorato di Viale del Tramonto di Billy Wilder, oggi non avremmo film quali Velluto Blu, Strade Perdute e Mulholland Drive, dei capolavori che hanno reinterpretato quel noir attraverso metodi narrativi sempre più complessi da arrivare a sentire il bisogno di decostruirlo, per creare qualcosa di nuovo.
Parlando di Velluto Blu e le connessioni emotive con le opere, ad esempio, il mio personale legame con la pellicola giace in quella, meravigliosa, scena dove Dean Stockwell si esibisce in un lip sync estatico di In Dreams di Roy Orbison.
Una scena potentissima, dove la fotografia, la composizione dell’immagine, la scrittura, la messa in scena di Lynch e il quadro costruito a schermo sono un qualcosa che trascende il mezzo, divenendo qualcosa di oltre, quasi estraniante dalla visione stessa, portando lo spettatore oltre il cinema, la poltrona, la sala e calandolo in quel sogno che è Velluto Blu; al cinema deve essere stato meraviglioso.
Allo stesso modo è dal 2004, quando avevo 17 anni, che non riesco a levarmi dalla testa il sorriso scanzonato e dolce di un’inedita Natalie Portman in La Mia Vita a Garden State.
Infantile, sgraziata in una bellezza stonata che ti fa venire voglia di salire sul sidecar del personaggio di Zach Braff e guidare nella notte umida del Garden State, senza controllo e senza meta, solo per il gusto di farlo; solo al pensiero posso quasi sentire i polmoni riempirsi di quell’aria fredda ed elettrica che si respira dopo la pioggia.
Per questi e altri motivi, sono innamorato follemente di quel film.
Una pellicola che non guardo spesso, perché fa anche un po’ male.
La mia vita a Garden State - o come vuole più semplicemente il titolo originale: Garden State - è l’esordio alla regia di Zach Braff.
Uscito nel 2004 è valso al regista, sceneggiatore e attore, il premio speciale della giuria del Sundance Film Festival, divenendo al contempo un instant classic.
Zach Braff, nel 2004, aveva iniziato a godere di un successo planetario proprio grazie alla serie culto Scrubs.
Una sit-com che, nel suo piccolo, era riuscita a cambiare la televisione spostando il medical drama verso la commedia e comunicando con un pubblico di millennials - diviso tra adolescenti e neo ventenni - che si preparava ad affrontare la vita senza che nessuno li avesse, fino a quel momento, presi davvero in considerazione.
La serie aveva colmato un vuoto comunicativo che, dopo la fine di quella sit-com e di un certo periodo storico, sarebbe nuovamente imploso per non rivedere mai più la luce.
Fino ad ora, eccetto forse How I Met Your Mother - che ormai è bello che concluso - nessun altro serial è davvero riuscito a comunicare con le generazioni di riferimento, lasciando a casa il pop e divenendo altro, ovvero la nuova televisione che ha riportato in auge lo star system, ma lascia a casa il pubblico più giovane; prima o poi qualcuno si sentirà fortemente abbandonato e ne vivremo le conseguenze.
Uno dei meriti della serie stava proprio nella scelta di Zach Braff, un attore non formidabile, ma dotato di una capacità empatica molto presente e potente.
Braff era, e penso lo sia ancora, capace di comunicare con il suo pubblico attraverso uno spettro di emozioni complesse, sfumando dalla commedia demenziale al dramma, senza suonare forzato o ridicolo.
Il mito di J.D., così ragazzo comune, re dei perdenti e pieno di idiosincrasie, lo portava a essere paladino di un pubblico insicuro, tremendamente spaventato dall’idea di crescere e afflitto dalle stesse problematiche che, se non in quel momento, da lì a poco, si sarebbero affacciate alla sua finestra.
Braff è dotato, naturalmente, del potere empatico atto a trasmettere quelle espressioni, un viso in grado di spegnersi in uno sguardo vitreo, cristallizzato dalla violenta ed istantanea collisione con la drammaticità della realtà della situazione.
Il tutto era portato allo spettatore in episodi da 25, scarsi, minuti.
Mica male!
Ne La mia vita a Garden State Braff mette in gioco le sue migliori capacità autoriali, spingendo il pedale sull’apatia, svuotando il J.D. clown per riempirlo con le nevrosi di un ragazzo, tipicamente americano, la cui voglia di gridare viene addormentata.
Andrew Largeman, il protagonista del film interpretato da Braff, è appunto un aspirante attore i cui sentimenti sono stati anestetizzati dalle terapie farmacologiche del padre psichiatra e che ritorna a casa nel Garden State - Stato Giardino: soprannome affibbiato al New Jersey - in occasione del funerale della madre.
Il film gode e si riempie di questo spunto iniziale e della totale mancanza di emotività del protagonista, presentando allo spettatore una storia in costante crescendo e che nel narrare la realtà della provincia americana, va sempre più su verso un crescendo emotivo, una sorta di risveglio da quel torpore tragicomico che, via via lungo il racconto, si fa scanzonato, rumoroso e assurdo.
Zach Braff è abile a mantenere una certa linea narrativa e di mood, andando su gradualmente e senza mai esplodere in situazioni eccessive, usando un umorismo bilanciato e sottile, come ad esempio la famigerata scena dove compare un giovanissimo, e allora sconosciuto, Jim Parsons - lo Sheldon di The Big Bang Theory - nei panni di un cavaliere, con tanto di armatura, da fast food.
Uno dei segmenti più interessanti e iconici della Storia del Cinema e forse specchio perfetto di una generazione poco raccontata.
I temi dello studio delle piccole comunità e del racconto generazionale si uniscono per dare vita a un film che è parte della tradizione narrativa americana e che non sempre riesce ad arrivare a schermo con la stessa forza e potenza.
Garden State si cataloga in quella filmografia, balzana, alla quale appartiene anche Little Miss Sunshine, dove le idiosincrasie di una struttura sociale resa schizzata dalla vastità dei meccanismi che la governano arriva a trovare i suoi paladini e i suoi esponenti migliori negli outsider, smascherandosi e mitizzandosi nei provincialismi che, contrariamente a quelli italiani molto più radicati nella cultura quotidiana e oramai nazionalizzati, hanno un gusto affascinante conferito proprio da quell’aria surreale.
Il film sfrutta quindi benissimo i contrasti del suo protagonista e l’emotività repressa per fare della storia una soluzione antidepressiva, un medicinale dall’azione leggera eppure euforica, dove la descrizione dello Stato Giardino funge da effetto collaterale quasi allucinogeno, mettendo in scena spaccati sopra le righe, scanzonati, eppure resi tremendamente umani dai caratteri messi in gioco e dalle loro mancanze.
Un film che trova la sua potenza proprio nell’interpretazione apatica ed empatica di Braff, in un cast di comprimari all’altezza di una sceneggiatura bizzarra e dal taglio che, per quanto tipico di una certa poetica del cinema americano, si riconosce solo nella mano del suo autore.
La Generazione X, quella raccontata nell’omonimo film di Kevin Smith - aka Mallrats - trova nella scrittura di Braff dei ritmi più languidi, meno volgari, spensierati e superficiali, toccando dramma, comicità e momenti crudi, poco lusinghieri con una provincia americana bipolare, quasi da logica da racconto lynchiano nel suo sovrapporre e alternare la bucolica poesia di provincia alle droghe assunte per noia e disperazione, a vite vissute con una decadente superficialità quasi estrema.
Impossibile da dimenticare la faccia di Peter Sarsgaard e la sua interpretazione indolente di un carattere quasi ostile, eppure magnetico e vitale per il racconto.
A supporto della scrittura e regia di Zach Braff abbiamo quella che, secondo gli annali, è una delle colonne sonore più di successo: una vera e propria compilation di brani messa insieme dallo stesso regista.
Una soundtrack che spazia da Don’t Panic dei Coldplay, passa per Caring Is Creepy dei The Shins, si sofferma su poeti americani quali Nick Drake e Simon & Garfunkel e diventa modernità con il languore elettronico di Let Go dei Frou Frou.
Una playlist evocativa per un film fortemente legato alle atmosfere e alle sensazioni, dove arrivare fino in fondo non è difficile ma richiede allo spettatore uno sforzo emotivo che lo costringe ad affrontare alcune domande che, quando superi l’adolescenza, cominci a porti sempre più insistentemente e alle quali spesso è davvero difficile rispondere.
Non è facile confrontarsi con Garden State, l’indifferenza non appartiene a questo film generazionale il cui impatto sul pubblico, come per l’arte, varia da persona a persona.
Una parte del pubblico potrebbe rimanere affascinata dai quadri ironici che Braff mette in scena per sviluppare, con gusto, una certa comicità visiva.
Una fetta potrebbe farsi affascinare dall’house party languido, pruriginoso, impasticcato ed electropop.
Alcuni troveranno la perfezione nell’incontro con la Sam interpretata da Natalie Portman, in quel suo sorriso genuino accompagnato dalla New Slang dei The Shins o nella costante aria di strambo romanticismo che la sua presenza, un po’ da proteggere, porta in ogni scena.
Garden State obbliga lo spettatore a confrontarsi con emozioni complesse, quelle legate a sapori passeggeri della propria vita, descrivendo uno spaccato generazionale che ha bisogno di un baratro nel quale gridare, che necessita del diritto di sentirsi afflitto, quando necessario, che ha voglia di trovare un po’ di romanticismo e significato in un momento storico che ha costretto questi ragazzi a situazioni fuori controllo, a volte drammatiche, e governate da un mondo adulto assente e pesante nelle scelte imposte.
La mia vita a Garden State è un vero e proprio cult del cinema che non va dimenticato e che consiglio caldamente non solo ai fan di Zach Braff ma anche a chi nutre una certa curiosità nel voler conoscere una fetta della narrazione di una Generazione X che, al cinema, è stata troppo spesso semplificata all’interessante, quanto riduttivo, film di Smith.
Un film agrodolce, così potente da sedimentare per diversi giorni nell’animo dello spettatore che, prima di ritornare a guardare il film, spenderà molto tempo in compagnia della colonna sonora.
Ti è piaciuto questo articolo? Sappi che hai appena visto il risultato di tanto impegno, profuso nel portarti contenuti verificati e approfonditi come meriti.
Se vuoi supportare il nostro lavoro perché non provi a far parte de Gli Amici di CineFacts.it?

Articoli
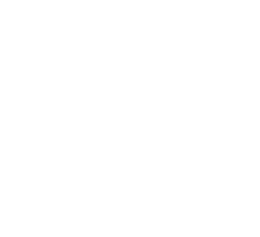
Articoli
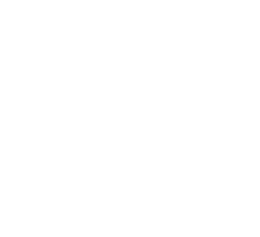
Articoli
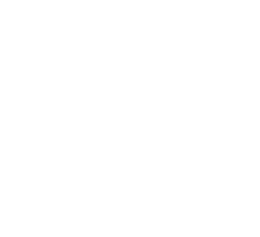

3 commenti
Alessandro Dioguardi
5 anni fa
Sono molto felice di averti fatto scoprire questo film.
Sai, è un film complesso, nel senso che sedimenta nel corpo.
L'ho visto una prima volta e mi è rimasto dentro per diversi giorni e poi sono tornato a rivederlo e poi ancora e poi non l'ho visto per anni e poi ci sono ricascato.
E' un film difficile da metabolizzare ma con una sua poetica.
Poi, quella colonna sonora è qualcosa di stupendo.
Rispondi
Segnala
Davide Sciacca
5 anni fa
Rispondi
Segnala
Alessandro Dioguardi
5 anni fa
Rispondi
Segnala